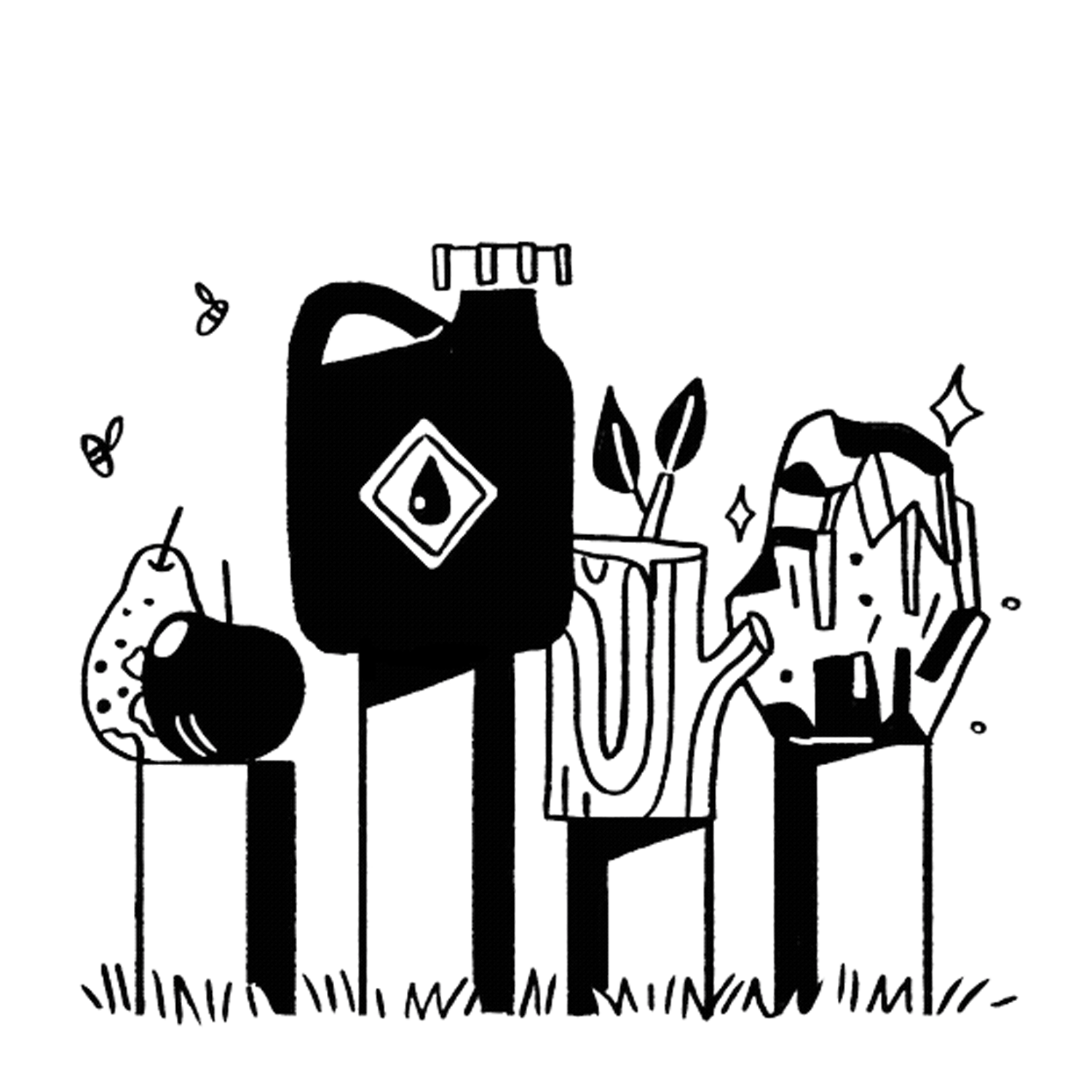Sabato 25 ottobre Maurizio Landini, segretario della Cgil, si esibirà nuovamente nelle piazze italiane alzando la voce su sanità, salari, pensioni: nel mirino la manovra di Bilancio in via di definizione. Tutto legittimo. Il tenore della protesta è arcinoto, vista la sequenza interminabile di scioperi che quest’anno è stata inflitta al Paese. Ma questa volta, oltre al disagio sociale Landini intende portare sul palco un tema più spigoloso: la destinazione alla Difesa di quote più ampie del bilancio pubblico. Secondo il sindacalista, la «logica del riarmo» è incompatibile con la giustizia sociale e i diritti del lavoro. E d’altro canto, la questione mette con le spalle al muro la politica, spaventa i contabili, divide le coscienze. Perché armarsi è costoso. Ma non armarsi potrebbe esserlo molto di più.
Il piano Marshall
Ursula von der Leyen ha evocato un «Piano Marshall per la difesa europea» da oltre 800 miliardi nel prossimo decennio. L’obiettivo, più volte suggerito anche da Mario Draghi, è ridurre la dipendenza dall’ombrello atlantico, rafforzare l’industria militare europea, costruire una capacità di deterrenza autonoma. È la risposta strategica a un mondo che cambia: l’aggressione russa in Ucraina, l’instabilità mediterranea, la fine dell’illusione pacifista post 1989. E’ il nuovo ordine mondiale, dove sul dialogo prevale la forza: non piace, ma in questa fase storica così stanno le cose. In questo scenario, anche l’Italia è chiamata a contribuire. Fino a oggi alla Difesa ha destinato l’1,5% del Pil, quasi 28 miliardi di euro. L’obiettivo, condiviso a livello Nato, è arrivare al 2% (per poi salire ulteriormente sino al 5%). Tradotto: subito altri 8–10 miliardi l’anno, in una fase in cui la finanza pubblica non ha tesoretti da distribuire e le priorità sociali restano alte. La protesta del 25 ottobre nasce qui: da una sensazione di squilibrio. Come si può chiedere sacrifici ai lavoratori, mentre si aumentano le spese per l’acquisto di armi e sistemi militari? Come giustificare nuovi investimenti nella difesa quando gli ospedali rispondono a singhiozzo e gli edifici scolastici hanno problemi di tenuta?
Eppure, la domanda va capovolta: come si può difendere la coesione sociale se non si difende, prima ancora, la sovranità stessa? Sicché il problema non è se armarsi o meno. Il problema è come farlo: con quali priorità, con quale trasparenza, con quale bilancio politico. C’è chi vede nel riarmo un’opportunità industriale. In parte è vero: l’Italia dispone di un comparto difesa d’eccellenza (a cominciare da Leonardo e Fincantieri), che potrebbe beneficiare di una domanda continentale coordinata. Ogni miliardo investito nel settore potrebbe generare fino a 8.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti. Ma, come ricorda l’Economist, l’industria militare è altamente capital-intensive, poco adatta alla redistribuzione sociale, scarsamente permeabile ai benefici diffusi. E non sempre le tecnologie belliche si trasformano in innovazione civile. In molti casi, rimangono confinate in un’economia chiusa, sostenuta da fondi pubblici, utile a pochi e pagata da tutti. Il dibattito, quindi, non è ozioso e le risposte debbono essere convincenti.
La parola e la forza
Ciò detto, non si può ignorare il fatto – come dimostrano anche le vicende in Medioriente – che l’equilibrio internazionale è tornato a reggersi sul principio più barbaro e più antico: chi ha la forza ha la parola. Con ciò aprendo una questione morale non marginale. È giusto destinare risorse al potenziale distruttivo mentre il pianeta reclama interventi sul clima, sulla povertà, sull’istruzione? Domande fondate. Ma se concordiamo sul fatto che la pace è il bene supremo, allora dobbiamo proteggerlo costi quel che costi. E per proteggerlo, di fronte a Paesi che riconoscono solo la forza, servono purtroppo le armi, non solo per rispondere alle aggressioni ma anche e soprattutto come argomento di deterrenza. Se sai che posso rispondere adeguatamente, ci pensi due volte prima di aggredirmi. Dunque, il vero problema non è “se” armarsi. Ma “quanto”, “come” e “perché”. L’equilibrio è difficile, ma necessario. E l’Europa non può restare neutrale in un mondo polarizzato. Deve dotarsi di una forza credibile, senza perdere la propria anima democratica. Deve difendersi, senza diventare aggressiva. Deve investire nella sicurezza, senza sacrificare la coesione sociale. La nuova difesa europea sarà sostenibile solo se sarà anche trasparente, efficiente, integrata. Se non diventerà pretesto per spartizioni industriali o espediente contabile per aggirare i vincoli europei. E se saprà convivere con un progetto sociale che resti ambizioso, esso potrebbe tradursi in una polizza assicurativa contro l’irrilevanza.
L’apologia del cannone
In conclusione, scioperare per la pace è nobile. Non è nel nostro stile fare l’apologia del cannone, ma la pace, oggi, non si regge sulla disarmata innocenza. Si regge – tragicamente ma concretamente – sulla capacità di deterrenza. Non si tratta di glorificare le armi, ma di riconoscere che in questo tempo storico nessuno ascolta chi non ha voce. E la voce, spesso, viene dalla forza. Sicché, armarsi non è una resa all’ideologia della guerra, è una necessità geopolitica. Perché nessuno negozia davvero la pace se non ha nulla da perdere in guerra.
I manifestanti che sabato 25 ottobre andranno in piazza con le loro bandiere, non meritano né slogan né racconti consolatori. Se Landini vuole davvero tutelare i lavoratori, smetta di raccontare favole che nascondono i costi reali: la responsabilità pubblica impone trasparenza, non le solite semplificazioni che confondono soltanto. Abbia il coraggio di dire il signor Landini, che la sicurezza collettiva, come la coesione sociale, ha un prezzo non solo economico che devono pagare tutti.
© Riproduzione riservata