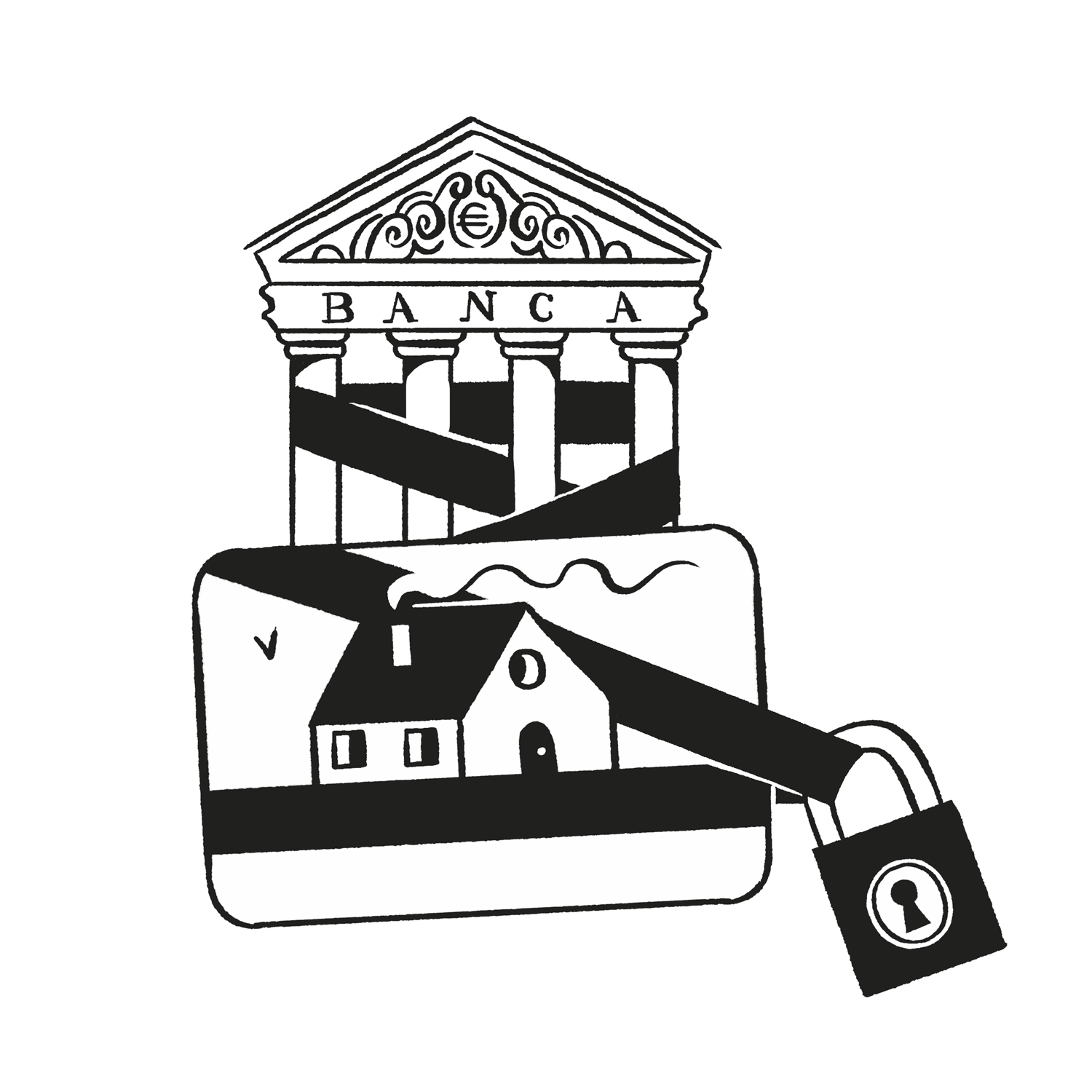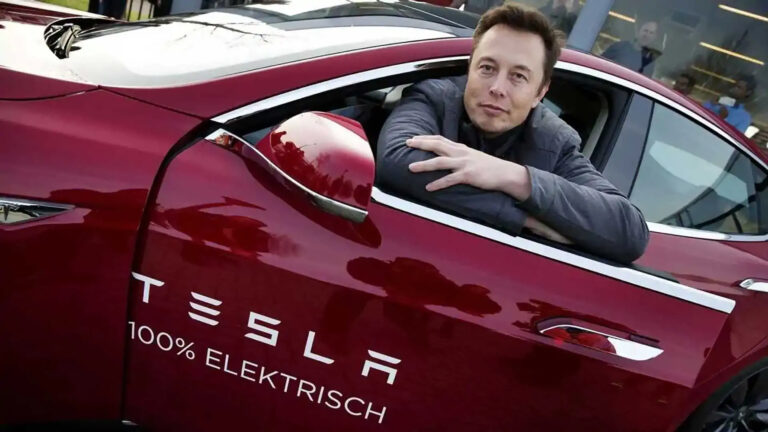Undicimila miliardi di dollari. Undici. Tanti ne sono stati bruciati in appena un decennio per rincorrere il sogno – o meglio, l’illusione – della transizione energetica. Risultato? L’80% dell’energia primaria globale continua imperterrita a provenire da fonti fossili. Il sole splende, il vento soffia, le conferenze si moltiplicano, ma a far girare il mondo, purtroppo per gli attivisti climatici da salotto e i burocrati in ghingheri di Bruxelles, sono ancora petrolio, gas e carbone.
A lanciare la pietra degli 11 trilioni bruciati sull’altare della transizione energetica è Amin Nasser, amministratore delegato di Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera al mondo (480 miliardi di dollari i ricavi 2024). Certo, non un arbitro neutrale, ovviamente parla pro domo sua, e lo fa con l’eleganza di chi ha appena chiuso un trimestre record grazie ai prezzi del greggio, dopo avere distribuito 31 miliardi di dividendi nel primo semestre. Ma tra le pieghe della sua requisitoria contro l’ideologia verde si annida un’amara verità che anche i più ferventi sostenitori del Green Deal europeo non possono più ignorare: questa transizione, così com’è stata pensata, ha inequivocabilmente fallito.
Il dogma che le rinnovabili avrebbero rapidamente rimpiazzato le fonti fossili si è infranto contro la realtà. Più che una transizione, stiamo assistendo a una gigantesca espansione del sistema energetico, dove le rinnovabili si sommano agli idrocarburi, ma non li sostituiscono. La domanda globale di energia è esplosa – più 40 milioni di barili equivalenti al giorno in dieci anni – e due terzi di questa crescita è stata coperta da fonti fossili. Non da pannelli eolici piazzati in mezzo al mare. Nel frattempo, l’Europa – mosca bianca nel panorama mondiale – si è imposta regole sempre più draconiane, proibizioni ideologiche e obiettivi climatici scollegati dalla realtà. Il Green Deal, nato come strumento di leadership ambientale, si è trasformato in una zavorra industriale. Chi sta pagando il conto? I cittadini europei – gli italiani in particolare – con bollette stellari, blackout annunciati, deindustrializzazione strisciante e proteste agricole che non sono affatto un capriccio reazionario ma il sintomo di un sistema relativamente al quale la parola collasso è sempre più frequente.
Anche gli Stati Uniti, sotto la patina green dell’amministrazione Biden, hanno mantenuto e anzi incrementato la produzione di petrolio e gas. E la Cina? Inarrestabile nella costruzione di centrali a carbone, mentre guida anche la produzione globale di pannelli solari e batterie, grazie a supply chain dominate da Pechino e lavorazioni ben poco green.
E adesso arriva l’ennesima sorpresa: i data center e l’intelligenza artificiale. Secondo stime indipendenti, entro il 2030 i consumi elettrici globali dell’IA potrebbero superare quelli di tutte le auto elettriche del mondo messe insieme. L’Europa, in evidente affanno, si sta forse attrezzando? No. Ancora discute se bandire o meno le caldaie a gas nel 2029.
Nasser, pur nel suo evidente conflitto di interessi, enuncia tre verità che nessuno osa dire a Bruxelles: 1) le rinnovabili integrano, non sostituiscono; 2) petrolio e gas resteranno indispensabili per decenni ancora; 3) i governi stanno invertendo la rotta, costretti a riconoscere la distanza tra ideologia verde e realtà energetica. È esattamente ciò che l’Europa dovrebbe fare: tornare con i piedi per terra. Riconoscere che non esiste transizione se prima non c’è sicurezza energetica, indipendenza strategica, e sostenibilità economica. Continuare a insistere su un’agenda ambientale scritta nei salotti progressisti e non nei laboratori tecnici, significa solo accelerare il declino industriale del continente.
Questo non significa abbandonare le rinnovabili, ma abbandonare l’integralismo. È ora di rivedere il Green Deal prima che ci travolga. Puntare su un mix energetico che includa gas, nucleare e rinnovabili, incentivare tecnologie a emissioni ridotte senza demonizzare ciò che oggi ancora alimenta le nostre industrie e riscalda le nostre case.
Anche perché gli errori commessi da Bruxelles cominciano a pesare sui bilanci pubblici. Secondo l’European Court of Auditors, tra il 2014 e il 2020 l’Unione ha speso oltre 216 miliardi di euro per azioni climatiche, spesso senza verificare l’efficacia reale dei progetti finanziati. Il famigerato Fit for 55, con i suoi divieti e le sue rigidità, rischia di costare all’industria europea fino a 500 miliardi entro il 2030, secondo le stime di BusinessEurope. L’imposizione delle auto elettriche entro il 2035, per esempio, ha già causato una fuga di investimenti verso Usa e Cina, con la produzione di batterie europee scesa all’1,4% del totale globale. A tutto ciò si aggiunge il blocco ideologico sul nucleare in paesi chiave come la Germania, che ha chiuso gli ultimi reattori nel 2023, salvo poi aumentare l’importazione di carbone e gas.
Il mondo cambia, ma non nei tempi da favola dei piani quinquennali europei. E mentre noi giochiamo a fare i virtuosi del clima, il resto del mondo corre. È tempo di ricordarlo a Bruxelles, prima che l’inverno in arrivo ci ricordi, a modo suo, da dove viene davvero l’energia.
© Riproduzione riservata