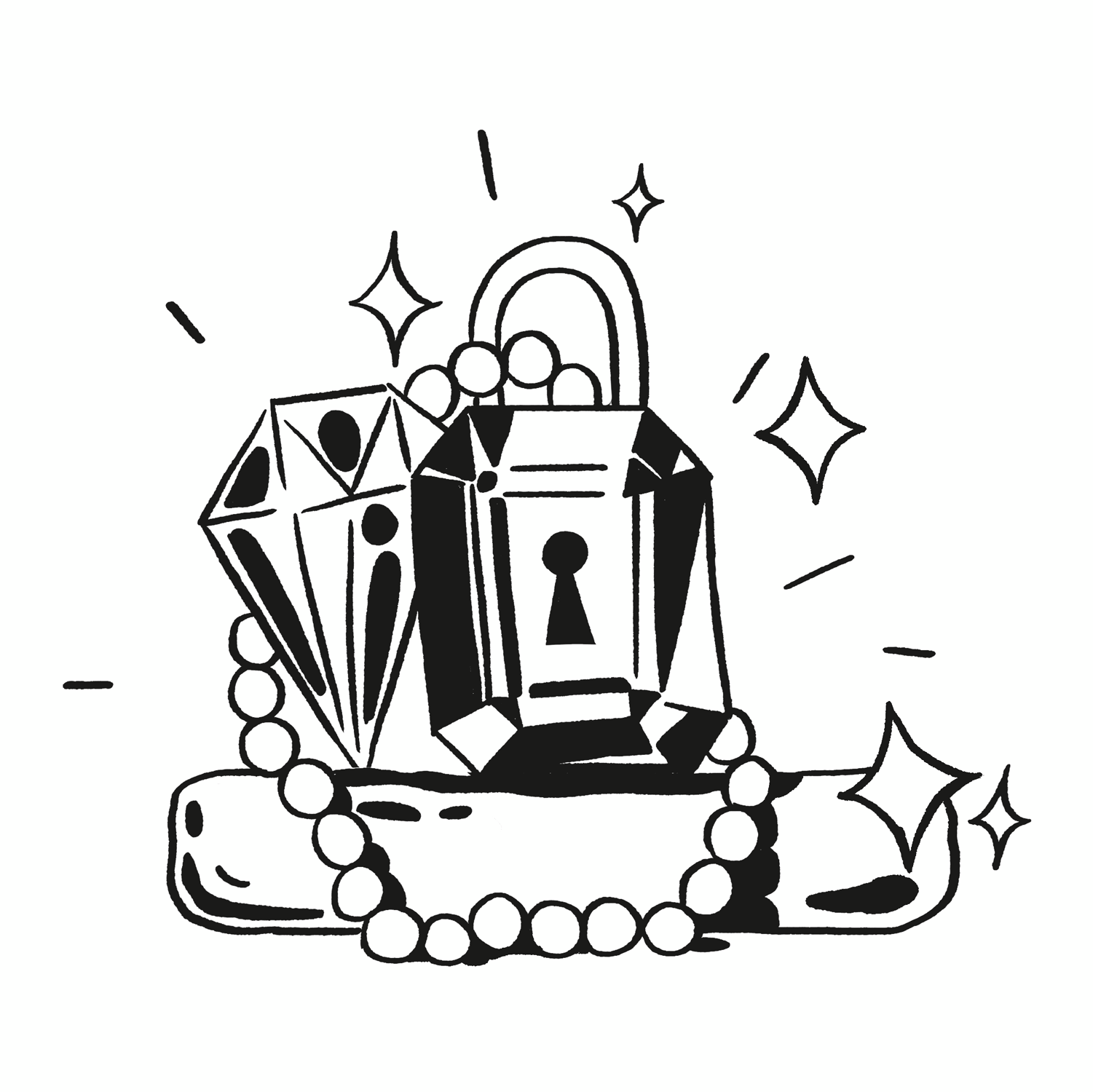Dall’estate 2024 il mercato dei mutui in Italia mostra segnali di recupero, sostenuto dalla serie di tagli ai tassi decisi dalla Banca centrale europea. Tra giugno 2024 e settembre 2025, lo stock complessivo dei mutui alle famiglie è cresciuto di oltre 12 miliardi di euro, passando da 423,1 miliardi a 435,7 miliardi, invertendo la tendenza dei due anni precedenti. L’incremento triennale dal gennaio 2022, che include la fase di stretta monetaria, supera i 25 miliardi, pari a +6,2%.
La trasmissione della politica monetaria dalle banche alle famiglie resta però incompleta. Nonostante i tassi ufficiali della Bce siano scesi dal 4,50% del 2023 al 2,00% nell’autunno 2025, i tassi medi sui mutui si sono stabilizzati tra 3,6% e 3,8%, con un Taeg medio a settembre 2025 pari al 3,71%. Il differenziale tra il costo del denaro e i tassi bancari rimane quindi di circa 171 punti base, contro uno spread praticamente nullo un anno prima. Le banche hanno scelto di mantenere margini elevati, frenando la riduzione dei tassi sui nuovi finanziamenti. La motivazione è duplice: tutelare la redditività dopo anni di volatilità e gestire l’incertezza legata a scenari macroeconomici e geopolitici ancora instabili.
Leggi anche:
Una trasmissione monetaria asimmetrica
Tra luglio 2022 e novembre 2023, durante la fase restrittiva, i tassi bancari hanno superato rapidamente i 4,9%, più che raddoppiando in meno di due anni. In confronto, i ribassi successivi, iniziati con il primo taglio Bce a giugno 2024, hanno impiegato oltre un anno per stabilizzarsi attorno al 3,7%. La cinghia di trasmissione appare quindi allentata: la politica monetaria espansiva non si traduce pienamente in costi del credito più bassi per le famiglie.
Il risultato è un mercato dei mutui in lenta ripresa: dai 420,8 miliardi di maggio 2024 si è passati a 435,7 miliardi a settembre 2025, con un incremento medio di oltre un miliardo al mese. La domanda resta selettiva e concentrata su finanziamenti di durata più breve, mentre la prudenza delle famiglie limita l’espansione dei mutui a lungo termine.
“Il quadro del credito in Italia mostra segnali contrastanti, ma anche elementi di fiducia. Le famiglie continuano a gestire con responsabilità le proprie finanze, adattandosi a una fase economica complessa. Si riducono gli impegni a lungo termine, mentre crescono i finanziamenti di durata più breve, legati a esigenze concrete e quotidiane”, spiega il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. “È un comportamento prudente, che riflette attenzione e consapevolezza. Il mercato dei mutui, dopo anni di forte rallentamento, potrà ripartire solo se la discesa dei tassi decisa dalla Banca centrale europea si tradurrà in condizioni più favorevoli per chi vuole comprare casa. È fondamentale che la trasmissione della politica monetaria funzioni fino in fondo, raggiungendo famiglie e imprese”, aggiunge.
“Le misure che governo e Parlamento si accingono a mettere in campo, con la legge di bilancio, per potenziare le garanzie pubbliche, sostenere i giovani e facilitare l’accesso al credito vanno nella direzione giusta. L’acquisto della casa deve tornare a essere un obiettivo possibile, non un privilegio per pochi. Il credito è un elemento essenziale di fiducia e di crescita: deve tornare a rappresentare una leva di sviluppo e non soltanto uno strumento di gestione delle difficoltà. Il sistema bancario, insieme alle istituzioni, ha oggi l’occasione di accompagnare la ripresa economica con equilibrio e responsabilità sociale. In questa fase, le banche hanno un compito che va oltre il profitto: devono accompagnare la società nella ripresa, favorendo la coesione e la fiducia. Ogni scelta di credito è anche una scelta di responsabilità verso il Paese. Mantenere un equilibrio tra risultati economici e impegno sociale è la condizione per rafforzare la reputazione del settore e sostenere la crescita reale dell’economia”, conclude.
Leggi anche:
Credito alle famiglie: crescita moderata e mutamenti strutturali
I dati aggiornati a settembre 2025 mostrano andamenti divergenti tra le varie forme di credito. Il credito al consumo registra un aumento annuo di 5,1 miliardi (+4,14%), trainando la crescita complessiva, mentre i mutui crescono di 12,8 miliardi (+3,03%) e i prestiti personali calano di 4,8 miliardi (–4,05%). Su base triennale, il credito al consumo segna un +16,88%, i mutui +6,19% e i prestiti personali un calo del 20,8%.
L’incertezza sui tassi e i prezzi delle abitazioni nei grandi centri urbani frenano l’accesso a mutui di lungo periodo, mentre il calo dei prestiti personali evidenzia una selettività crescente nell’indebitamento. Nel complesso, la crescita complessiva del credito rimane contenuta (+1,98% su base annua, +2,20% triennale), indicando una fase di adattamento più che di rilancio.
© Riproduzione riservata