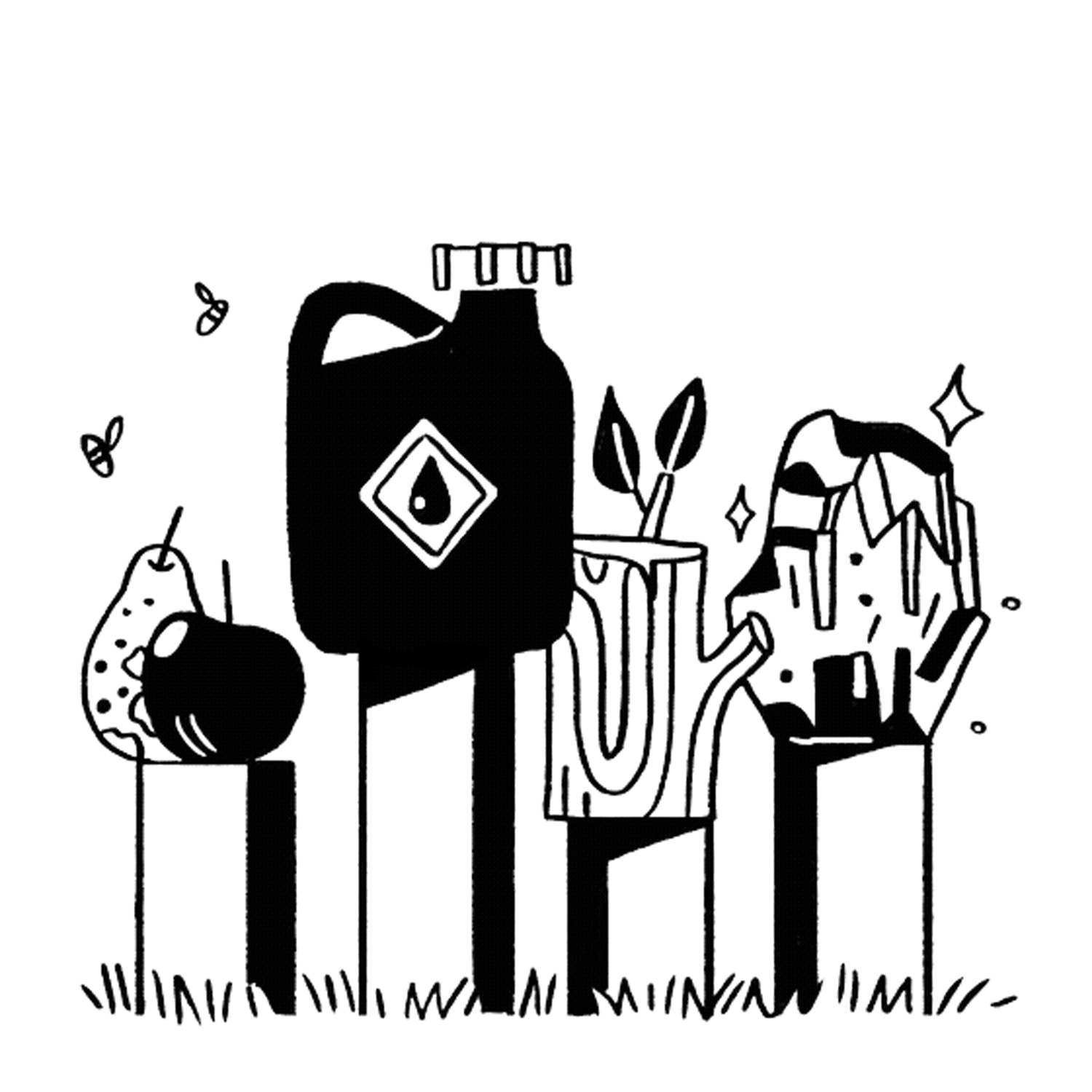La crisi dell’ex Ilva non è una fatalità: è un crack annunciato e scientemente costruito. Un monumento alle irresponsabilità incrociate che, per anni, hanno trasformato la grande acciaieria di Taranto con ramificazione a Genova, in un laboratorio di errori politici, giudiziari, sindacali e di governo. Tutti complici, tutti colpevoli.
Leggi anche: Ultima Colata
Politici locali che hanno usato la fabbrica come trofeo da agitare a ogni tornata elettorale. Magistrati che hanno trattato un colosso industriale come un fascicolo qualunque, imponendo vincoli e stop che un sistema già fragile non poteva sopportare. Sindacati che hanno confuso la difesa dei lavoratori con la rincorsa a posizioni ideologiche incompatibili con la realtà metallurgica. Governi che avevano il dovere di decidere e hanno preferito temporeggiare, rimandare, coprire le crepe con slogan vaporosi ma sempre più vuoti.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un impianto che vive per inerzia, una produzione al lumicino, altoforni che sembrano respirare solo per abitudine. Si parla ancora di “transizione verde” quasi fosse una scorciatoia magica, quando la verità è che senza impianti funzionanti non c’è né transizione né futuro. Solo declino.
Leggi anche:
Manovra. Dopo il rigore serve coraggio
L’ultima rottura tra governo e sindacati avvenuta in settimana è la replica esatta di una scena recitata troppe volte. Il governo annuncia una riduzione della cassa integrazione programmata come fosse una conquista; i sindacati gridano al tradimento; intanto, nell’indifferenza generale, la grande fabbrica si svuota, pezzo dopo pezzo, turno dopo turno. E nessuno ammette l’evidenza: non è una fase di passaggio, è una lenta eutanasia industriale.
Di questa tragica vicenda, Moneta si è occupata più volte nei mesi scorsi, arrivando a quantificare il grave danno (circa 50 miliardi) che lo sfacelo tarantino ha provocato al Paese in tredici anni. E più volte abbiamo parlato di responsabilità di questo sfacelo, spiegando che non è un concetto astratto. Ha nomi, volti e ruoli ben precisi. Politici che hanno cavalcato la paura ambientale per raccattare voti, senza preoccuparsi di costruire un’alternativa credibile. Magistrati che hanno agito talvolta come potere legislativo surrogato, con una supponenza che grida vendetta, intervenendo senza considerare gli effetti economici e occupazionali delle proprie scelte. Sindacati che hanno oscillato per anni tra trattative inconcludenti e posizioni massimaliste, dimenticando spesso che senza produzione non esiste lavoro. Infine, governi che hanno fatto della parola “piano” un sinonimo di “rinvio”, trasformando la più grande acciaieria d’Europa in una struttura buona per un museo di archeologia industriale.
Paradossalmente, oggi la situazione potrebbe prendere una direzione diversa. Nel momento in cui il governo vive una fase di relativa stabilità e i conti pubblici sono in fase di riordino, il Paese avrebbe finalmente la possibilità di fare ciò che non ha mai voluto: assumersi la responsabilità piena del destino di Taranto e di Genova. Invece si continua a parlare di partner in arrivo, si fanno i nomi di fondi o di soggetti che emergono e poi s’immergono, come se il mondo fosse pieno di investitori pronti a buttarsi in un impianto depotenziato, in un territorio esasperato e in una storia piena di veleni istituzionali.
Leggi anche:
La verità è che, dopo decenni di tentativi falliti, non c’è più spazio per l’illusione che qualcuno arrivi da fuori a salvarci. E chi ha ridotto l’ex Ilva così male, in particolare le autorità del territorio, non può essere lo stesso soggetto chiamato oggi a rimetterla in piedi. È il momento di dire le cose come stanno: serve una cordata italiana, con partecipazione diretta dello Stato, non come ritorno allo statalismo dei decenni neri, ma come intervento straordinario in un settore strategico che non possiamo permetterci di perdere.
Lo Stato deve entrare direttamente, contribuire a mettere ordine, dettare tempi e obiettivi, finanziare la messa in sicurezza e la ripartenza produttiva, imporre una governance efficiente e poi – solo poi – lasciare che la cordata di privati, selezionata in base alle potenzialità industriali, prosegua l’attività. L’acciaio non è un settore tra i tanti: è il presupposto delle infrastrutture, della manifattura, della sicurezza economica nazionale. Rinunciarvi significa diventare un Paese industrialmente irrilevante. È uno “sgarro” alle convinzioni liberali di una vita? Sì. Ma è lo sgarro giusto. Perché qui non stiamo scegliendo tra pubblico e privato: stiamo scegliendo tra avere un futuro industriale e non averne più. Taranto non può restare la capitale degli alibi, della propaganda, delle sentenze preventive e dei rinvii senza fine. Deve tornare a essere ciò che era: un pilastro dell’Italia produttiva. E per farlo, serve una decisione chiara, netta, definitiva.
P.S. La sindaca di Genova Silvia Salis, con cipiglio da guerriera, grida in comizio: «Il ministro Adolfo Urso venga a Genova a dare risposte a chi le merita». Giusto, ma la Salis dovrebbe invitare nella sua città anche i ministri del suo partito che negli anni hanno occupato la poltrona di Urso chiedendo anche a loro conto dello sfacelo. Soprattutto a loro.
Leggi anche:
Ilva, gli operai occupano lo stabilimento di Genova
In casa Marchi torna lo spettro Veneto Banca
© Riproduzione riservata