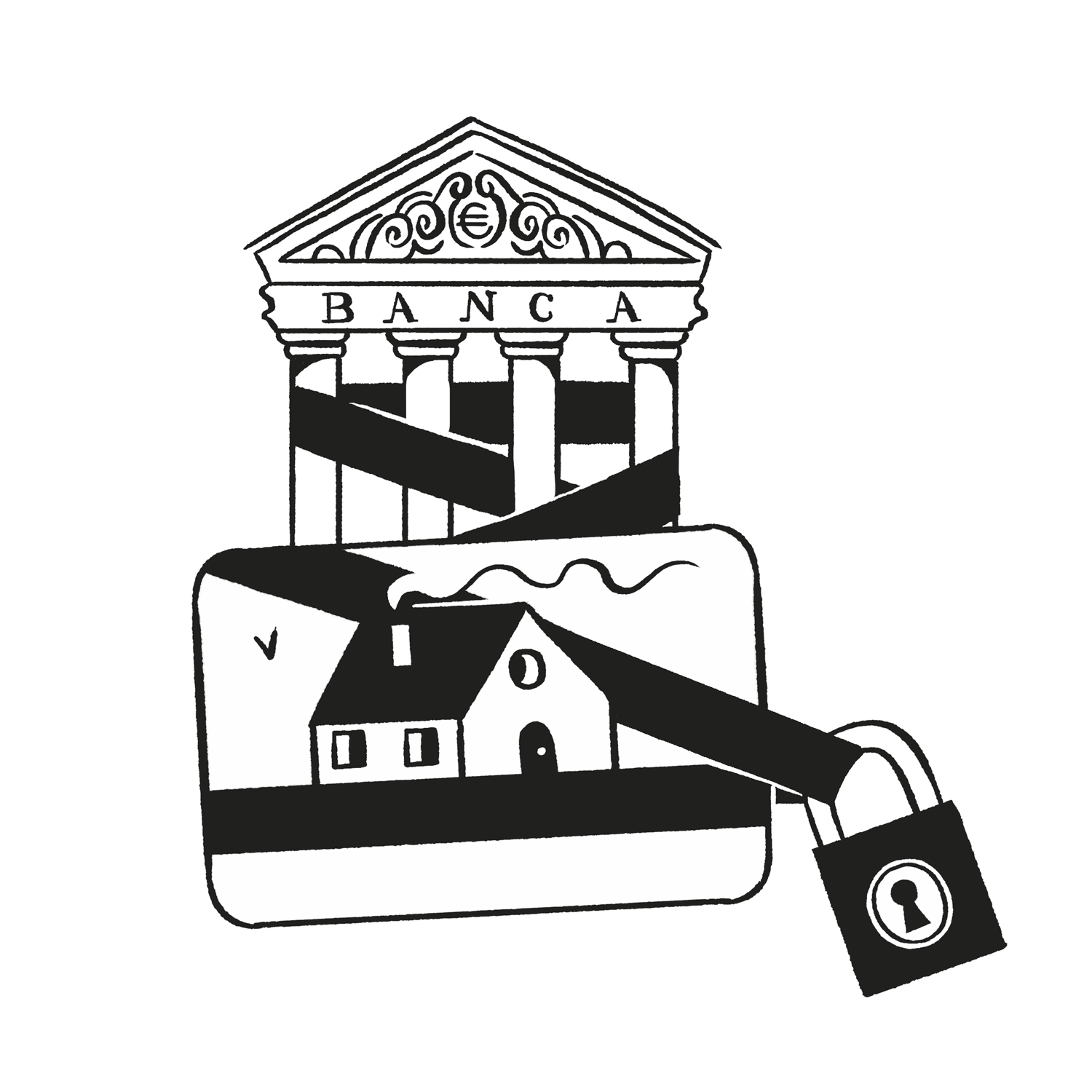Figlia del Green Deal, la decarbonizzazione – ovvero la riduzione dell’uso di combustibili fossili e l’aumento dell’uso di energie rinnovabili – sulla carta poteva anche essere la rivoluzione auspicata. Di fatto, a cinque anni di distanza dal piano, le strategie messe in atto dall’Europa si stanno rivelando una fissazione poco efficace e anti-economica che nemmeno 15 miliardi di sussidi riescono a rendere finanziariamente sostenibile. Non è un caso che, anche di fronte a miliardi di sovvenzioni pubbliche grandi aziende come Arcelor Mittal inizino a fare dietrofront sui progetti, così come disegnati dalle norme europee. Norme che nel caso più delicato del momento, quello dell’Ilva di Taranto, potrebbero essere una definitiva pietra tombale.
L’impegno finanziario messo in campo fin qui dall’Europa è davvero notevole, ma dati alla mano, tutti questi sforzi potrebbero essere un gigantesco buco nell’acqua. Secondo l’analisi di GMK Center, negli ultimi sei mesi i sussidi governativi per la decarbonizzazione dell’industria siderurgica europea sono aumentati di 500 milioni di euro, raggiungendo un totale di 15,1 miliardi di euro. Un ulteriore sostegno proviene da prestiti agevolati, tra cui 700 milioni stanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per tre progetti siderurgici nel periodo 2024-2025.
Quasi il 90% di questi sussidi pubblici è destinato a progetti Dri-Eaf (Direct Reduced Iron-Electric Arc Furnace), il principale percorso di decarbonizzazione adottato dalle aziende siderurgiche europee. Nonché l’obiettivo di una nuova futuribile Ilva.
La Germania è leader nei sussidi, contribuendo con il 46% (sette miliardi di euro) del totale dei contributi europei, una cifra sproporzionata rispetto alla sua quota del 35% nella produzione europea di acciaio basico da forno a ossigeno (confronto con UE-27 + Regno Unito).
Ma dove sono concentrati tutti questi sussidi? I Paesi Bassi saranno al secondo posto della classifica (vedi grafico) una volta finalizzato il finanziamento previsto di 3 miliardi di euro per Tata Steel IJmuiden. Inoltre, tra dicembre 2024 e giugno 2025, il ministero delle Imprese e delle Politiche Agricole italiano ha stanziato 97 milioni di euro ad Arvedi Ast nell’ambito di un Contratto di Tutela Ambientale.
Il Parlamento polacco punta 230 milioni di euro per l’ammodernamento dell’altoforno di ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. La Romania si è impegnata a stanziare 150 milioni di euro per ridurre le emissioni di Liberty Galati. La Spagna ha approvato 60 milioni di euro per il complesso Dri-Eaf di Hyndum Steel a Puertollano.
E attenzione. Dei 30 progetti di decarbonizzazione annunciati, solo 7 non hanno ricevuto sovvenzioni statali. Inoltre, nonostante i consistenti sussidi, solo 8 dei 23 progetti approvati hanno avviato i lavori. Ma perché? I produttori di acciaio citano come principali ostacoli i bassi prezzi dell’acciaio, gli elevati costi energetici e la domanda insufficiente di acciaio a basse emissioni di carbonio.
In soldoni, l’acciaio decarbonizzato non tira sul mercato. Tutti fattori che stanno mettendo in dubbio la fattibilità dei progetti a forno Dri-Eaf in Europa nel prossimo decennio. Non si dovrebbero infatti ignorare i vantaggi in termini di costi dei concorrenti extra-Ue e la scarsa prontezza del mercato. L’enorme contraddizione è rappresentata dal fatto che l’industria europea, in particolare l’industria di base (come acciaio, chimica, carta, vetro, cemento, fonderie) rappresenta meno del 3,5% delle emissioni globali, le quali crescono invece in tutto il mondo del 3,5% all’anno.
Nel marzo 2025, la Commissione Europea ha presentato il suo Piano d’azione per l’acciaio e i metalli, che include misure volte a: rafforzare il Cbam; limitare le esportazioni di rottami metallici per garantire materie prime accessibili per la produzione basata su forni Eaf; introdurre incentivi per la domanda di acciaio a basse emissioni di carbonio; espandere i sussidi per i costi energetici per alleviare le pressioni operative.
Ma il problema è che le questioni riguardano la sostenibilità finanziaria di tutto questo. Non è un caso che poche settimane fa, il produttore di acciaio ArcelorMittal abbia rinunciato a 1,3 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per la costruzione di un impianto di produzione di acciaio a impatto climatico zero, basato sull’idrogeno, nei suoi siti di Brema ed Eisenhüttenstadt. «A nostro avviso, le condizioni quadro non consentono un modello di business resiliente e sostenibile», ha dichiarato a Handelsblatt Reiner Blaschek, ceo di ArcelorMittal Europe Flat Steel.
Ciò significa che uno dei progetti più importanti per la trasformazione dell’industria siderurgica tedesca è fallito. Secondo i piani del governo, ArcelorMittal avrebbe dovuto investire in impianti in grado di produrre acciaio utilizzando l’idrogeno in modo climaticamente neutro. «Tuttavia, la somma di tutti i fattori di rischio è così significativa che non possiamo giustificare questo investimento».
Una cancellazione che potrebbe avere un impatto significativo sul piano governativo di potenziamento della filiera dell’idrogeno. L’azienda siderurgica ha svolto un ruolo centrale nei piani governativi, essendo uno dei principali consumatori di idrogeno.
Decisioni cruciali rimangono in sospeso inoltre per Tata Steel IJmuiden e Acciaierie d’Italia che, secondo quanto ricostruito dal Giornale, vede sfumare i piani di decarbonizzazione a Taranto con un probabile spostamento della produzione green presso i siti di Acciaierie d’Italia a Genova.
© Riproduzione riservata