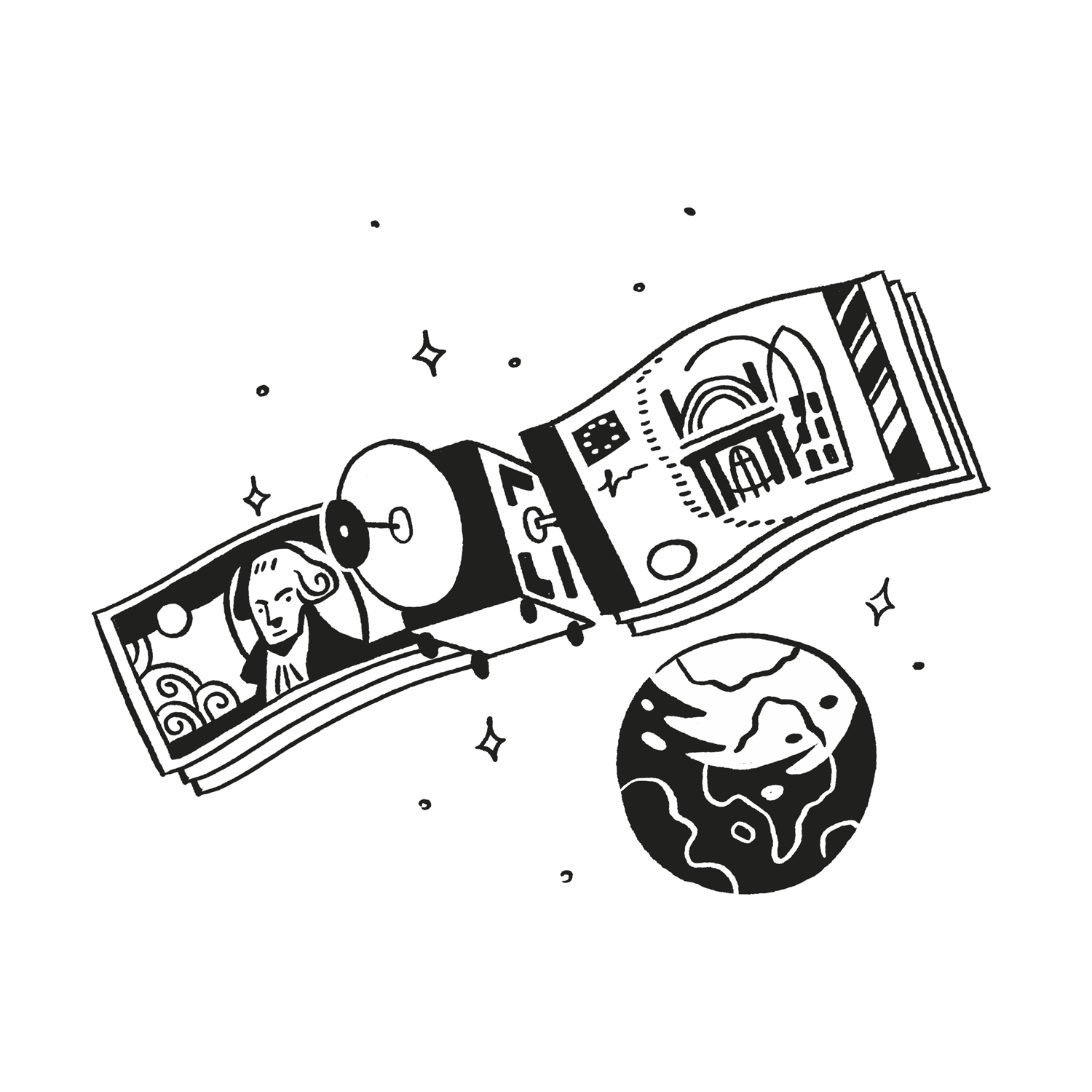In attesa di conoscere l’esito dello scontro sul destino del Banco Bpm, dove ciascun protagonista si propone sempre più agguerrito nel far valere le proprie ragioni – che si tratti del Banco, di Unicredit oppure del governo – merita di affrontare una questione parallela, finora lasciata forse troppo ai margini del dibattito sull’argomento, che in certa misura spiega perché si è giunti a tali violente contrapposizioni. Riguarda Unicredit, sempre in veste di potenziale soggetto aggregatore ma inquadrato in tutt’altra scenografia.
Un passo indietro. Nel luglio 2012, in piena crisi del debito sovrano e con un euro sull’orlo dell’implosione, la Germania si fece promotrice di un progetto che avrebbe dovuto rappresentare la risposta sistemica dell’Europa alla fragilità della sua rete finanziaria: l’Unione bancaria. Una costruzione a tre pilastri (vigilanza unica, risoluzione/ristrutturazione unica, garanzia unica dei depositi), pensata per superare la frammentazione nazionale del credito e prevenire nuove crisi.
Tredici anni dopo, la grande architettura è solo a metà. I primi due pilastri sono stati posizionati, il terzo – la garanzia europea sui depositi – è lettera morta. I motivi? Ufficialmente mancano le «condizioni di fiducia reciproca». Tradotto in chiaro: Berlino non si fida delle banche italiane, né dei sistemi di vigilanza del Sud Europa. Eppure, paradossalmente, è proprio la Germania che oggi chiede di sospendere le regole comuni nel momento in cui una banca italiana, Unicredit, esprime interesse per un istituto tedesco. Al punto che il ministro delle Finanze, Lars Klingebeil, non esita a minacciare di ritorsioni Unicredit se non abbandonerà ogni velleità su Commerzbank, ritenuta “sistemica” per la Germania. Una pretesa che esprime una sconcertante contraddizione politica e culturale e un atto di sfiducia nell’Europa delle regole condivise. Proprio il concetto di sistema bancario integrato implica infatti che le banche sistemiche, grandi o piccole, non siano solo tedesche, francesi o italiane, ma anche europee. E se le banche sono europee, come da anni ci viene predicato dalla Bce e dai banchi dell’Eurogruppo, allora è legittimo – e persino auspicabile – che un gruppo paneuropeo come Unicredit possa valutare operazioni strategiche su scala continentale. Tanto più che la banca guidata da Andrea Orcel vanta una presenza radicata in Germania da decenni, attraverso HypoVereinsbank, e opera già sotto la vigilanza Bce oltre che della Bundesbank. Ma tutto questo ai tedeschi non basta.
In sostanza, la Germania chiede che le regole europee valgano solo quando fanno comodo a lei. Vale per le banche, e vale per molto altro. Un esempio plastico è l’operazione Lufthansa-Ita Airways: la compagnia di bandiera tedesca ha acquisito il controllo della ex Alitalia con il pieno assenso del governo italiano, che ha accettato di sacrificare un pezzo importante della propria sovranità industriale anche in nome di un’Europa più integrata. Roma ha accettato la logica del mercato comune. Berlino non ne vuol sapere.
Qui non si tratta di pretendere trattamenti di favore per un gruppo italiano. Né di invocare un impossibile bilanciamento geopolitico delle operazioni industriali. Si tratta di rispettare le regole comuni, quando ci sono. E di non reinterpretarle in chiave domestica appena una decisione strategica mette in discussione il proprio predominio nei settori ritenuti “sensibili”.
Che il ministro delle Finanze tedesco entri a gamba tesa nella vicenda, evocando rischi sistemici che non spettano a lui valutare, è un atto di politicizzazione del sistema bancario che contraddice ogni principio dell’Unione. È la versione aggiornata del “Deutschland über alles” finanziario, declinata in salsa prudenziale. Non è un caso che la Germania sia da sempre la maggiore oppositrice a qualsiasi meccanismo europeo che implichi condivisione del rischio. Non vuole la garanzia comune dei depositi, non vuole mutualizzare il debito, non vuole un ministro del Tesoro europeo. Detta in breve, preferisce un’Europa dove i vantaggi sono condivisi, ma le responsabilità restano nazionali. Argomenti che dicono molto su quale Unione abbia davvero in mente Berlino.
L’Europa a due velocità, che si diceva superata, è invece più viva che mai. E in ambito bancario, la prima classe è sempre riservata alla Germania. Peccato che ciò avvenga nel silenzio o nell’imbarazzo delle istituzioni europee, che sembrano aver rinunciato a far rispettare le regole comuni quando a violarle è il Paese più forte. Il caso Unicredit-Commerzbank è emblematico perché mette a nudo l’asimmetria strutturale dell’Europa economica. I Paesi del Sud devono aprirsi, liberalizzare, aggregare. Quelli del Nord possono permettersi di chiudere, frenare, difendere. Il tutto nel nome di un europeismo selettivo, che vale solo quando coincide con l’interesse nazionale tedesco. In questa logica, l’Unione bancaria diventa un progetto a senso unico: le banche possono diventare europee solo se parlano tedesco. E qualsiasi iniziativa che metta in discussione il primato di Berlino viene immediatamente neutralizzata da ragioni “sistemiche”.
È giunto il momento di porre fine a questa ipocrisia. Se vogliamo davvero un mercato finanziario unico, allora le operazioni transfrontaliere devono essere valutate con criteri tecnici e sotto l’occhio di autorità indipendenti, non affossate da veti politici o da richiami all’interesse nazionale quando questo oggettivamente non viene minacciato.
Qual è il nesso tra questo lungo ragionamento e l’incipit dell’articolo sul destino del Banco Bpm? È presto detto: se si disponesse di una vera Unione bancaria, con regole certe ed equilibrate, probabilmente il riposizionamento in atto in Italia e in Europa nel settore del credito si svolgerebbe con minore concitazione e più ordine e sicuramente più trasparenza. L’auspicio è che il Far West cui stiamo assistendo, che in misura diversa coinvolge tutti i principali partner dell’Unione, sia di monito ai vertici di Bruxelles affinché finalmente si facciano promotori della tanto auspicata Unione bancaria. Perché non saranno gli “avvertimenti“ sul Golden Power, vergati da qualche zelante euroburocrate che evidentemente non conosce i limiti del suo mandato, a rendere migliore il nostro sistema creditizio.
© Riproduzione riservata