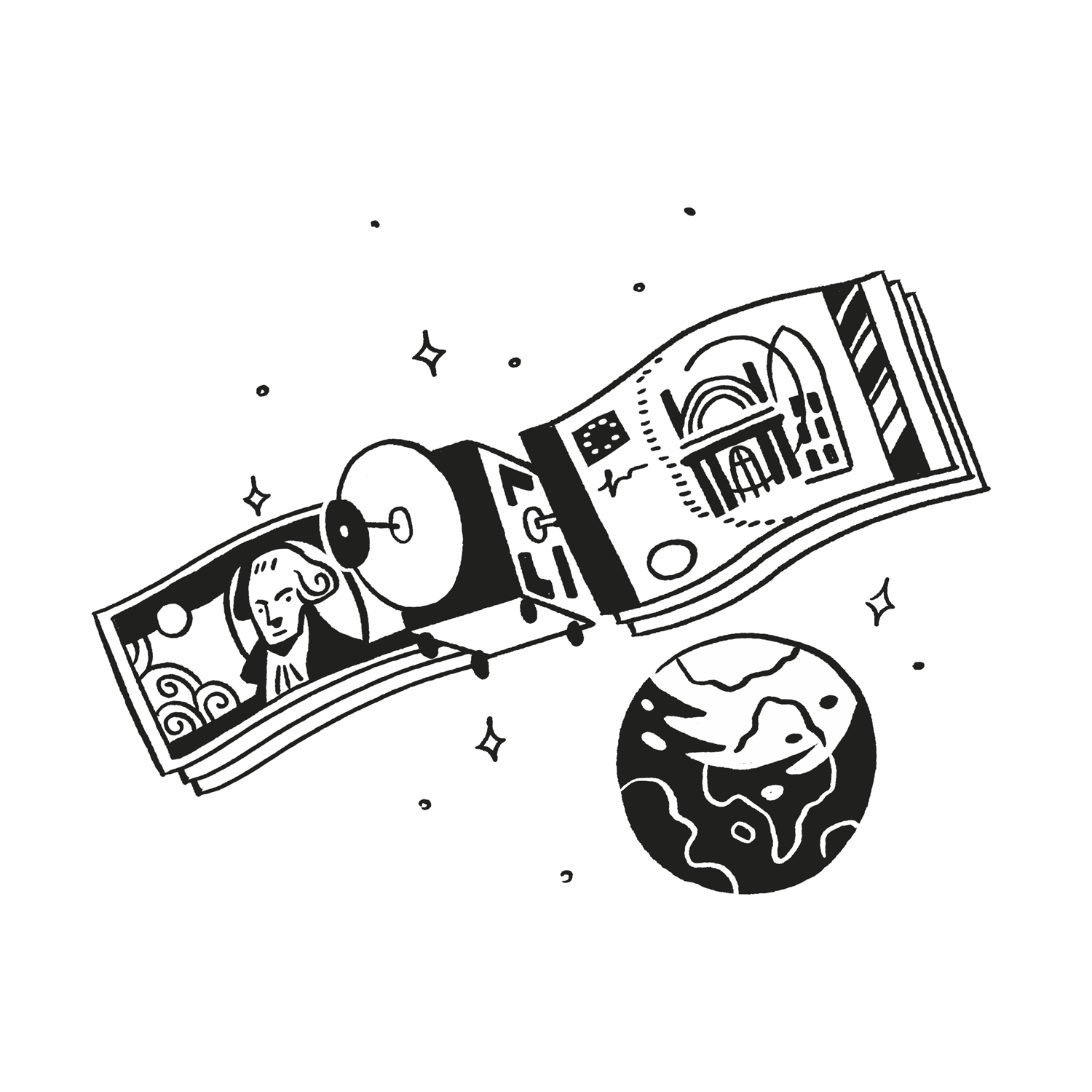Non solo luoghi di vendita di prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero, ma anche centri di cultura e di salvaguardia dell’identità enogastronomica nazionale. Dall’Italia agli Stati Uniti, i mercati dei contadini stanno diventando dei luoghi educativi a 360 gradi, come accade ad esempio nella Capitale, nel cuore dell’area archeologica, dove questi presìdi raccontano con i prodotti la storia del comune più agricolo d’Italia. Sempre più eventi si svolgono infatti all’interno dei farmers market, occasione di incontri e dibattiti sul tema alimentare in primis e molto altro ancora.
Una tendenza che ha contagiato anche gli Stati Uniti. Il National Mall di Washington, per esempio, ospiterà questa estate il Great American Farmers Market con stand di produttori dei 50 Stati, durante la Settimana Nazionale dei Mercati Agricoli. Un grande mercato contadino per offrire a cittadini e turisti – dal 3 all’8 agosto – i profumi e i sapori unici che nascono dal lavoro degli agricoltori nelle campagne statunitensi di tutti gli Stati. Prodotti agricoli come opere d’arte, dunque, per festeggiare il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza. Una iniziativa voluta dal Segretario Brooke L. Rollins, che guida il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) fondato dal presidente Abraham Lincoln, che rimane l’unica agenzia federale situata nell’area del National Mall, a testimonianza della centralità dell’agricoltura anche per il Paese di Donald Trump. Negli Usa il lavoro degli agricoltori viene valorizzato così: accanto ai colossi dell’industria e della distribuzione alimentare, crescono i farmers market gestiti direttamente dai produttori, custodi di quelle tradizioni alimentari sane che fanno fronte alla deriva dei cibi ultraformulati, contro i quali si è scagliato il segretario alla Salute Robert Kennedy jr, in accordo con l’amministrazione Trump.
Da fenomeno residuale, che sembrava destinato a scomparire, gli acquisti diretti dal produttore agricolo sono divenuti una importante realtà economica ed occupazionale in molti Paesi, più o meno sviluppati. La vendita diretta, in forma singola o aggregata, con i mercati contadini offre nuove opportunità alle aziende agricole ma anche ai consumatori. In Italia quasi due cittadini su tre (64%) fanno la spesa a chilometro zero direttamente dal produttore in fattorie e mercati, secondo l’ultima analisi di NotoSondaggi.
A essere apprezzate sono, nell’ordine, la qualità dei prodotti (38%), il rispetto della stagionalità (27%) e il rapporto prezzo/qualità (19%). Una opportunità che è entrata profondamente nelle abitudini di consumo delle famiglie, che trovano dunque negli acquisti diretti dall’agricoltore risposte al bisogno di genuinità, freschezza dei prodotti e garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare. Senza dimenticare le motivazioni di carattere ambientale e di impegno sociale a favore delle realtà locali.
Un ritorno al passato che ha favorito lo sviluppo in Italia della rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica, con oltre 10mila aziende e 1200 mercati contadini per un valore pari a 4 miliardi di euro e 15 milioni di consumatori raggiunti. Un “sistema” presente lungo tutto il territorio nelle piccole e grandi città con il 50% dei mercati degli agricoltori concentrati al nord (dove sul podio salgono Lombardia, Piemonte e Veneto), il 30% al sud con in testa la Campania e il 20% nel centro Italia dove guida la Toscana.
Le ultime aperture di quest’estate hanno riguardato proprio Firenze, all’interno dei locali restaurati dell’ex Cartiera Verdi, sotto Porta San Frediano, in un’area di oltre mille metri quadrati dedicata alla filiera corta, alla vera cucina contadina e allo street food, e Bari in Via Bernardini, su una superficie di 1500 metri quadrati. L’Italia può oggi contare sul circuito di vendita diretta dei prodotti agricoli con unico marchio più grande nel mondo, divenuto un modello preso a riferimento all’estero.
Grazie alla vendita diretta il consumatore può scegliere in modo consapevole di premiare un tipo di visione socio-economica, che punta sul sostegno alle aree agricole del proprio territorio e, con esse, alla conservazione del paesaggio e della biodiversità agricola e naturalistica. Un argine importante alla standardizzazione per la tutela della biodiversità con oltre 1.500 prodotti in via di estinzione, i “Sigilli di Campagna Amica”, che sono stati recuperati per essere venduti nei mercati.
Tra i “Sigilli” si possono trovare varietà di legumi antichi, cereali dimenticati, ortaggi dal sapore inconfondibile e salumi di razze a rischio di estinzione. La loro presenza nei mercati di Campagna Amica non solo offre ai consumatori prodotti di altissima qualità e dal gusto autentico, ma educa anche all’importanza della diversità e alla sostenibilità delle pratiche agricole. Nei farmers market si trovano venditori indipendenti con prodotti del territorio, offerti nel rispetto di precise regole comportamentali e di un codice etico e ambientale, sotto la verifica di un sistema di controllo.
Non manca l’aspetto educativo che aiuta a fare scelte di acquisto più informate insegnando a conoscere la stagionalità e la territorialità delle diverse produzioni. Sono sempre più diffusi, infatti, aule didattiche, orti urbani, classi di cucina contadina e corsi per conoscere oli, vini e formaggi. E per questo vengono spesso fissati appuntamenti mirati con il coinvolgimento delle scuole. «Aver creato un sistema di distribuzione del cibo locale mette l’Italia anche nella condizione di affrontare con una opzione in più l’instabilità dei mercati internazionali per le guerre commerciali legate al fenomeno dell’aumento dei dazi», afferma Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica, nel sottolineare che «lo sviluppo di questa rete consente di ragionare sempre di più dell’importanza del cibo locale il cui consumo dovrà essere ancora più presente nella ristorazione pubblica a partire dalle scuole, ospedali e carceri per assicurare da un lato alimenti buoni e sicuri e dall’altro favorire lo sviluppo del Made in Italy agro alimentare».
Una opportunità che aiuta peraltro a combattere anche lo spreco alimentare che, secondo l’Ispra, scende dal 40-60% per i sistemi alimentari di grande distribuzione ad appena il 15-25% per gli acquisti diretti dal produttore agricolo. Chi fa la spesa esclusivamente tramite reti alimentari alternative spreca meno perché i cibi in vendita sono più freschi, durano di più e non devono percorrere lunghe distanze con le emissioni in atmosfera dovute alla combustione di benzina e gasolio. È stato calcolato infatti che un chilo di ciliegie dal Cile per giungere sulle tavole italiane deve attraversare quasi 12mila chilometri con un consumo di 6,9 chili di petrolio e l’emissione di 21,6 chili di anidride carbonica, mentre un chilo di mirtilli dall’Argentina deve volare per più di 11mila chilometri con un consumo di 6,4 kg di petrolio che liberano 20,1 chili di anidride carbonica e l’anguria brasiliana, che viaggia per oltre 9mila chilometri, brucia 5,3 chili di petrolio e libera 16,5 chili di anidride carbonica per ogni chilo di prodotto, attraverso il trasporto con mezzi aerei.
Una attenzione all’ambiente dunque che contribuisce anche alla lotta al degrado di interi quartieri della città che i mercati contadini rivitalizzano. La Confcommercio ha evidenziato che in 12 anni «tra il 2012 e il 2024, in Italia sono spariti quasi 118mila negozi al dettaglio e 23mila attività di commercio ambulante, con un trend più visibile nei centri storici piuttosto che nelle periferie, ma comune sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno».
Al contrario si moltiplica nelle grandi e piccole città la presenza dei mercati contadini, in forma stabile e ambulante, che sono un presidio a difesa dell’identità alimentare nazionale che rischia di sparire dalle strade e dalle piazze delle città italiane dove ha rappresentato per secoli un valore aggiunto inestimabile dal punto di vista storico, culturale e turistico ma subisce ora il pressing di kebab, sushi e caldarroste fuori stagione. Valorizzare la cultura alimentare locale nei centri storici è importante per gli abitanti ma anche per i tanti turisti italiani e stranieri che si aspettano di mangiare prodotti della tradizione locale, vera forza della vacanza Made in Italy, conquistata con la distintività, la biodiversità e il legame con il territorio
© Riproduzione riservata