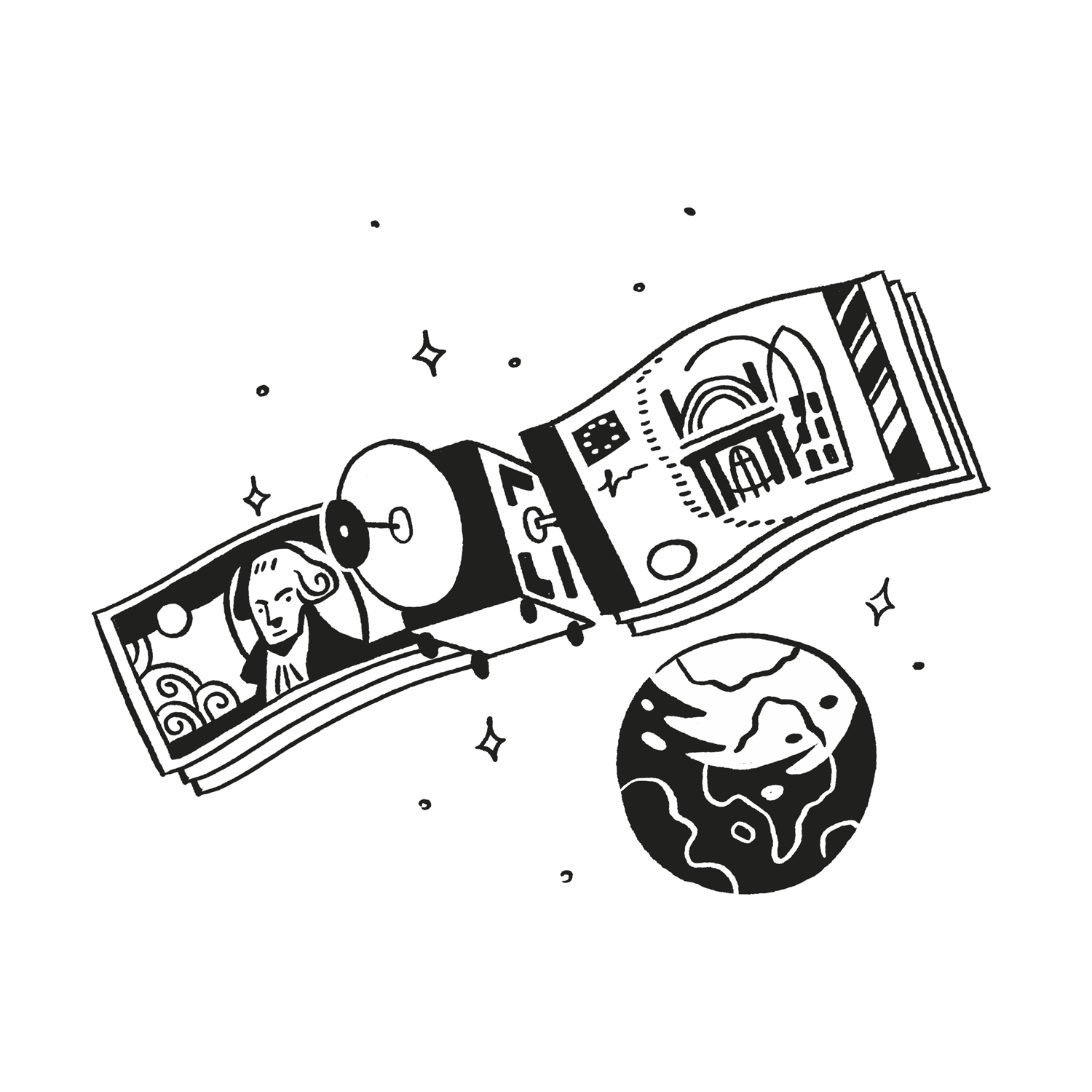“Entro fine mese il ddl delega sul nucleare dovrebbe chiudersi con il parere della Conferenza Unificata e poi immediatamente trasmesso in Parlamento che calendarizzerà al mese di Settembre”. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto detta il cronoprogramma che riporterà l’Italia a produrre energia dall’atomo.
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri è un disegno di legge delega. Non è un provvedimento immediatamente operativo: prima deve essere esaminato, ed eventualmente modificato, sia dalla Camera sia dal Senato. Al suo interno, il disegno di legge contiene una serie di princìpi che, dopo l’approvazione del testo da parte del Parlamento, il Governo dovrà seguire per reintrodurre la produzione di energia nucleare in Italia. Per questo motivo si parla di “delega”: con l’approvazione del disegno di legge, il governo è delegato a intervenire sul tema del nucleare grazie al via libera del Parlamento.
Una mission con cui il Governo punta di andare a meta nel più breve tempo possibile. Nella cornice legislativa – di cui circolano al momento solo bozze – si prevede, tra le altre cose, che sia una newco con imprese a controllo pubblico a riorganizzare lo sviluppo energetico nazionale da atomo.
Enel, Leonardo e Ansaldo Nucleare, sono state ingaggiate per lo studio della tecnologia migliore, di nuova generazione, affinché i reattori possano essere prodotti in Italia e installati a servizio delle imprese e del sistema energetico. La newco è stata costituita il 14 maggio 2025 e si è data un mandato esplorativo di 18 mesi.
La delega del decreto prevede, in parallelo, che il Governo adotti una serie di decreti legislativi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, per disciplinare in maniera organica l’intero ciclo di vita della nuova energia sostenibile, attraverso la stesura di un Programma nazionale: dalla sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio dei nuovi moduli, al tema della fabbricazione e riprocessamento del combustibile, tutto sarà affrontato in una visione di economia circolare. Si interverrà anche sulla disattivazione e smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti e del combustibile esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione, la riorganizzazione di competenze e funzioni.
Inoltre sarà necessaria l’istituzione di una Autorità indipendente per sicurezza, vigilanza e controllo. La delega servirà anche a prevedere strumenti formativi e informativi, formare nuovi tecnici e figure professionali del settore, e individuare benefici per i territori interessati.
“Il nucleare – ha affermato Pichetto – può contribuire in maniera importante alla decarbonizzazione, essendo una fonte decarbonizzata già a monte, ma anche ad abbassare le bollette. Dal punto di vista tecnico-economico, come riportato nelle analisi del PNIEC, si è verificato che l’inserimento della quota nucleare porterà ad un risparmio minimo per il sistema di 17 miliardi di euro.
Pichetto ha poi aggiunto che “tutte le valutazioni, insieme ad ulteriori analisi macroeconomiche di dettaglio, quali l’impatto sull’occupazione e sul PIL, per citarne alcuni, saranno dettagliate nell’aggiornamento della Strategia di Lungo Termine, da finalizzare entro l’anno prossimo per l’invio a Bruxelles. Insomma, il calendario del prossimo anno è fitto e il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha precisato che “ci vorrà ancora qualche anno, verosimilmente 9-10 anni, prima di vedere una produzione industriale significativa” in Italia .
Tra il vecchio e il nuovo nucleare una distanza di oltre mezzo secolo.
Considerando che il nuovo nucleare potrà tornate in Italia negli anni 2030, ci sarà una distanza siderale tra le due tecnologie, quella vecchia e quella nuova.
Soltanto a partire dal 1955, con il programma “Atomi per la Pace” voluto dal presidente USA Eisenhower, all’Italia in qualità di Paese ex nemico degli Stati Uniti venne concessa la possibilità di varare ufficialmente un programma nucleare, ma senza la possibilità di utilizzare uranio arricchito, quindi unicamente per le esigenze energetiche nazionali (la paura era che potesse essere usato per realizzare armamenti). Così nel 1963 a Latina vide la luce il primo reattore, seguendo la tecnologica britannica Magnox.
Nel 1964 fu il turno del reattore di Sessa Aurunca (Caserta) e pochi mesi più tardi quello di Trino (Vercelli), quest’ultimi sviluppati secondo le tecnologie statunitensi BWR e PWR. Nel 1966 l’Italia era il terzo paese produttore al mondo dietro USA e Gran Bretagna, e nel 1970 stava per arrivare il quarto reattore a Caorso (Piacenza).
La crisi petrolifera dei primi anni ’70 cambiò completamente gli scenari italiani. Nel 1975 il nuovo Piano Energetico Nazionale prevedeva la realizzazione di 10 centrali nucleari, senza però indicare i luoghi dove sarebbero sorte.
Il piano in realtà non vide mai la luce: venne deciso di realizzare un secondo reattore a Trino e uno nuovo a Montalto di Castro (Lazio), ma nel frattempo cominciarono a delinearsi nuovi problemi legati alla sicurezza, fomentato anche dall’esplosione del reattore di Three Mile Island, in Pennsylvania, nel 1979. Il terremoto in Irpinia nel 1980 portò due anni più tardi alla chiusura del reattore di Sessa Aurunca. Il disastro di Chernobyl fu un altro fattore che portò la maggior parte della popolazione a rifiutare l’idea di investire nel nucleare.
I referendum abrogativi del 1987 non determinarono la chiusura delle centrali, ma rispondevano a tre quesiti chiari: il primo abrogava gli “oneri compensativi” per gli enti delle sedi individuate per le nuove centrali, il secondo impediva al CIPE di individuare siti in mancanza di un accordo, il terzo impediva all’ENEL di partecipare alla costruzione di centrali all’estero.
Di fatto però la fine del nucleare in Italia era segnata: con le centrali di Latina e Trino a fine vita, quella di Caorso venne chiusa dopo 10 anni e nel 1990 l’Italia divenne un paese denuclearizzato, con i lavori al sito di Montalto di Castro riconvertiti in una centrale idroelettrica. Dal 1999 i siti delle centrali nucleari italiane dismesse sono di proprietà di SOGIN, che si sta occupando a tutt’oggi anche del definitivo smantellamento delle scorie, attualmente stipate nel centro Areva di Le Hague, in Francia, dove verranno riprocessate nel 2025.
© Riproduzione riservata