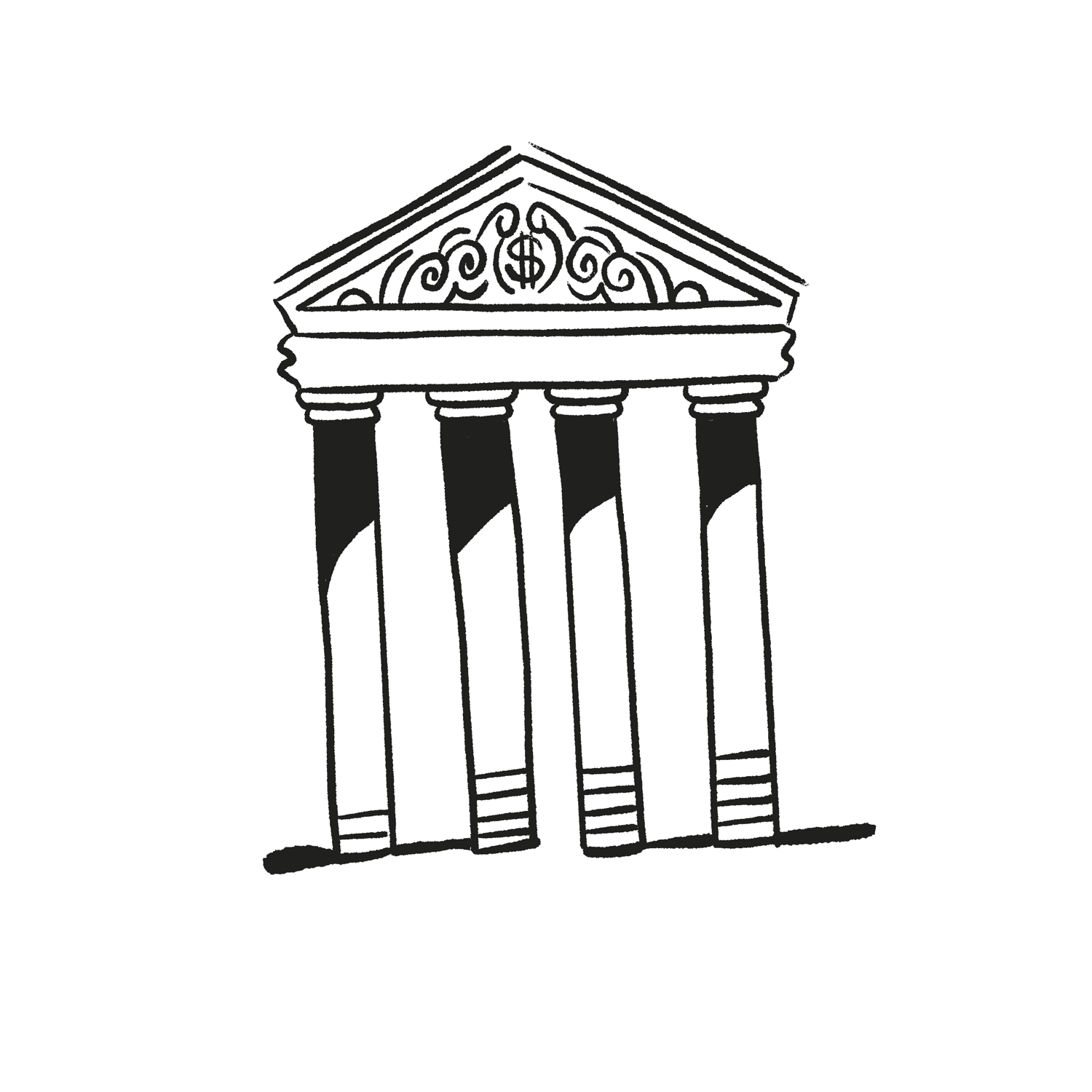“Quella di Mirafiori è una storia incredibile, fin dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1939 alla presenza di Benito Mussolini e del senatore Giovanni Agnelli, il nonno dell’Avvocato. Da allora, tutti coloro che hanno gestito questo enorme complesso – a quei tempi di 100 ettari, 3 milioni di metri cubi edificati e con 22mila operai – hanno sempre avuto il disagio causato dalle dimensioni dell’intero complesso”.
La storia del polo industriale torinese di Mirafiori, piombato ultimamente in una crisi nera, è costellata di momenti di gloria e altri di grandi difficoltà. Ne parliamo con Paolo Rebaudengo, 78 anni, nel gruppo Fiat dal 1973 al 2014, che ha chiuso la sua carriera come direttore delle relazioni industriali. Cesare Romiti, Paolo Cantarella, Gabriele Galateri di Genola, Alessandro Barberis, Giuseppe Morchio e Sergio Marchionne gli amministratori delegati che si sono alternati in quegli anni.
E’ lo stesso polo di Mirafiori che nel primo semestre di quest’anno ha prodotto solo 15.315 vetture, in calo del 21,5% rispetto alle 19.510 del 2024. Di queste, 15.175 sono Fiat 500 elettriche (un errore l’aver puntato tutto su questo modello nel recente passato), mentre le Maserati GranCabrio e GranTurismo hanno segnanto un crollo quasi totale. Per rilanciare lo stabilimento, Stellantis scommette ora sulla 500 ibrida, al via da novembre: la stima, a regime, è di oltre 100mila unità prodotte.
E pensare che negli anni ’60 e ’70 la capacità produttiva era alla saturazione: 5mila auto al giorno, ovvero più di 1 milione l’anno. Era il periodo della Fiat 500, nata nel 1957 e il cui successo continua dopo la riedizione nel 2007, e poi della 600, della 850 e della 127 per citare solo alcuni modelli. Il picco degli occupati fu raggiunto nel 1980 con 57.700 addetti contro i 2.100 attuali del reparto carrozzerie.
Mirafiori, di fatto, ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo economico di Torino sia dal punto di vista economico sia sotto l’aspetto sociale. Fu il simbolo dell’industria automobilistica italiana e del boom economico del Dopoguerra. “Era una città nella città – ricorda Rebaudengo – che dava lavoro a un terzo dei dipendenti di tutto il gruppo. Al suo interno c’erano anche un efficiente pronto soccorso per i dipendenti e chilometri di binari ferroviari”.
I momenti difficili giungono al culmine all’inizio degli anni Ottanta: scende la produzione e si riducono i lavoratori. Allo stesso tempo la dirigenza perde significativamente il controllo della fabbrica. “C’erano gruppuscoli che organizzavano cortei interni alla ricerca del capo da punire – spiega Rebaudengo -: addirittura c’era, tra gli operai, chi ordinava al suo responsabile di pulire il macchinario sporco perché lui non era pagato per farlo. Una prima svolta si ebbe quando i vertici annunciarono 61 licenziamenti, un numero destinato a rimanere impresso. La reazione della sinistra, compreso il “moderato” Giorgio Napolitano, determinò dopo una settimana, su disposizione del Tribunale, il reintegro degli operai. Ma quell’atto fece emergere la volontà della Fiat di dover assolutamente cambiare atteggiamento”.
E così partì la ribellione, meglio conosciuta come la “Marcia dei 40mila”. “Tutto cominciò dai capi, in quanto il rischio era la non gestibilità di Mirafiori. In pratica, una manifestazioni di autodifesa che nessuno si sarebbe mai aspettato, compreso il sindacato Fiom che ha sempre pensato di detenere il potere assoluto all’interno del polo produttivo, ma che successivamente ha dovuto ricredersi, visto che a prevalere alle elezioni delle Rsa sono stati la Fim e le altre organizzazioni metalmeccaniche”.Tante e difficili da ricordare tutte le vicende che hanno accompagnato la storia di Mirafiori, ora ai minimi storici, tanto che lo stesso Rebaudengo ritiene una chiara mancanza di attenzione verso la città lo svuotamento della palazzina di corso Agnelli 200 per spostare le attività in via Plava, e lo stesso vale per la vendita del Lingotto e della struttura di corso Marconi che ospitava il quartier generale dell’azienda. “Personalmente – afferma – sono riuscito a coinvolgere la Soprintendenza per scongiurare la cessione del Centro storico Fiat, dove è custodita tutta la storia del gruppo, ora affidato al Museo nazionale dell’automobile di Torino”.Ma ci fu un altro momento determinante nella storia di Mirafiori. È il 2004 con Sergio Marchionne da pochi mesi amministratore delegato della Fiat. “Tra i primi provvedimenti presi – le parole di Rebaudengo – quello di responsabilizzare tutti i capi del personale, rei, secondo Marchionne, di aver scelto le persone sbagliate. Un giorno, e qui veniamo al dunque e torniamo alle dimensioni di Mirafiori, l’allora numero uno di Fiat Auto, il viennese Herbert Demel, disse che Mirafiori sembrava una caserma con tutti quei cancelli, eccetera eccetera. Affermazione che mi mandò su tutte le furie. Risposi: ma lei non sa che cosa c’era qui dentro, lei non conosce la storia di questo sito. E a quel punto tutti ne presero atto. Era comunque emblematico che Mirafiori incutesse paura a chi doveva occuparsene per la sua enormità.
La possibile soluzione? Organizzai, con il supporto di Tom Dealessandri, ex sindacalista Fim e in quegli anni vicesindaco di Torino, un incontro tra Marchionne e il primo cittadino Sergio Chiamparino. Quindi, successivamente, con l’allora presidente della Provincia, Mercedes Bresso, la quale non era a conoscenza del precedente contatto avuto da Marchionne con il collega Chiamparino. Risultato: via libera alla cessione di 300mila metri quadrati all’interno di Mirafiori destinati al progetto “Torino Nuova Economia”. Il patto era che con il ricavato dalla cessione, Marchionne si impegnasse a produrre un nuovo modello, ovviamente a Mirafiori. E così nacque l’Alfa Romeo MiTo, un vero gioiellino, ed è un peccato che negli anni il gruppo non ci abbia più creduto”.
Intanto, sette mesi dopo l’uscita di Carlos Tavares, alla guida dell’attuale Stellantis è arrivato l’italiano Antonio Filosa, cresciuto in casa Fiat e a capo del mercato Usa, che Rebaudengo promuove senza mezzi termini. “Innanzitutto – dice l’ex manager – mi chiedo perché ci siano voluti sette mesi per nominarlo. Si è perso tantissimo tempo. Era infatti lui il predestinato in caso di scelta interna, come poi è fortunatamente avvenuto. In Sud America ha risollevato l’azienda subentrando alla gestione di Stefan Ketter che aveva portato al ridimensionamento della quota di mercato. In quella parte del mondo, il marchio Fiat è così tornato a essere leader come dimostrano anche i dati del primo semestre di quest’anno. Positiva, da parte di Filosa, anche la decisione di ricreare una squadra di successo attingendo dalle risorse locali, con la riassunzione di Massimo Cavallo, inserito nella prima linea di dirigenti. A lui il compito di guidare il personale del gruppo in America Latina”.Rebaudengo conclude il suo racconto guardando al futuro di Mirafiori, “polo torinese che dovrà sempre rappresentare la storia dell’auto italiana: dalla progettazione alla produzione; è l’emblema della Fiat, quello che ha rappresentato il vero modello industriale del Paese”. “Ora però – avverte – il compito è complicatissimo alla luce del quadro economico, delle decisioni politiche europee e dei conseguenti errori commessi in questi ultimi anni”.
Il destino ha voluto che lo stabilimento che ha visto nascere l’iconica Fiat 500, punti a ripartire proprio dalla sua erede con motore ibrido, come il mercato chiede. Una scommessa che dovrà essere vinta a tutti i costi.
© Riproduzione riservata