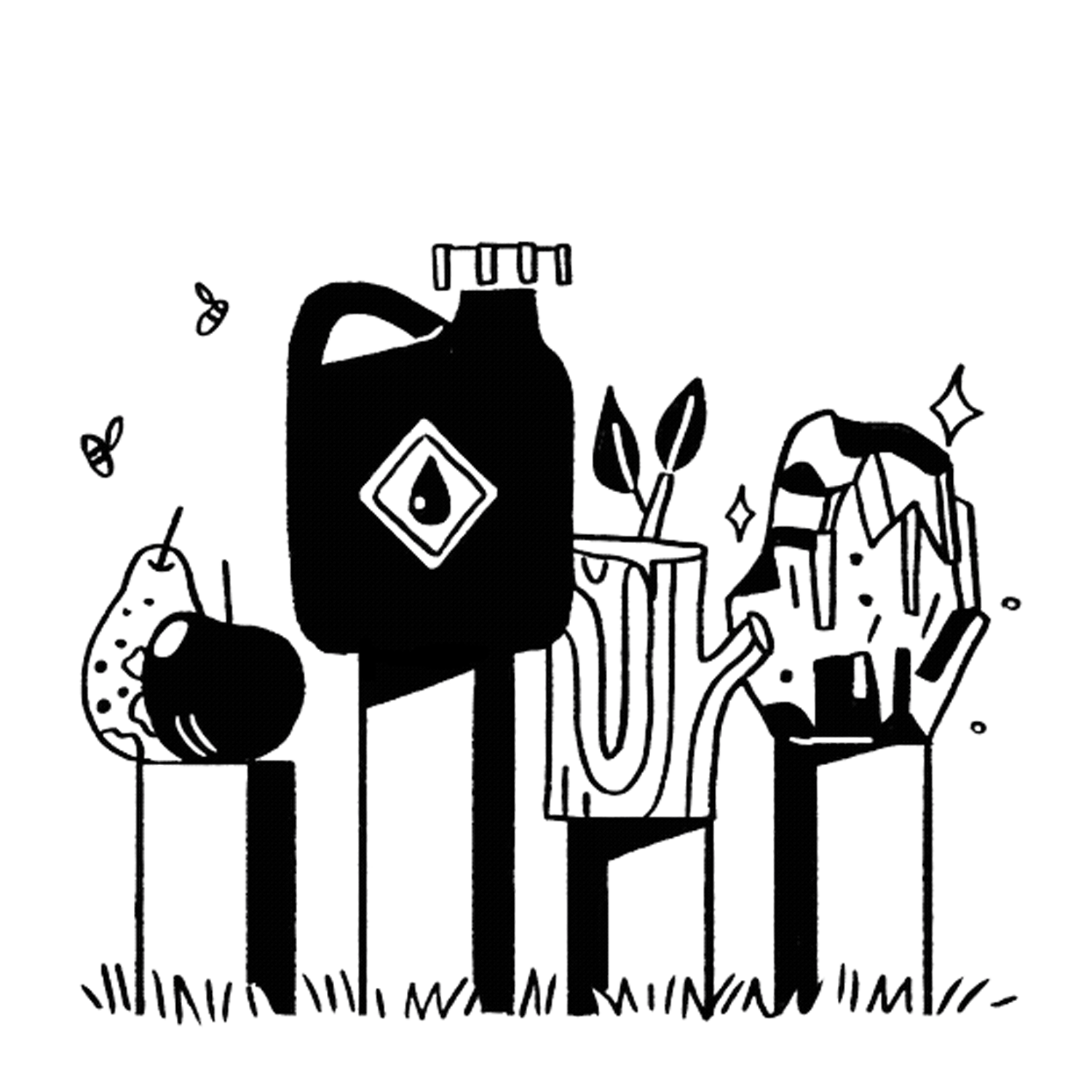In tempi di magra, anche i liberali – quelli veri, non i selfie con la giacca blu – devono fare i conti con la realtà. E la realtà, oggi, dice che lo Stato italiano, per chiudere una manovra finanziaria dai contorni più acrobatici che contabili, vuole mettere una tassa sui buy-back, in particolare delle banche. Il tutto, con la faccia seria di chi ha scoperto il segreto della redistribuzione giusta. Reazione immediata: urlo in falsetto degli azionisti, sdegno dei banchieri, corridoi di Bruxelles preoccupati per la stabilità del credito. Ma sotto sotto, anche qualche liberale onesto che, tra un caffè e un bilancio, ammette: forse, forse non è del tutto follia.
Il buy-back, per chi ha saltato le ultime puntate di “Finanza Creativa”, è quel meccanismo in cui un’azienda, invece di investire, innovare o semplicemente risparmiare, riacquista le proprie azioni sul mercato, alzandone il valore e, di riflesso, premiando gli azionisti e naturalmente i propri manager. Il tutto, in modo legale. Anzi, elegantemente tecnico. Ma profondamente, va detto chiaro, inefficiente per la collettività.
Non serve fare nomi, nel mirino ci sono quasi tutte le banche quotate e qualche grande company. Milioni, anzi miliardi, destinati a programmi di riacquisto titoli, mentre nel Paese reale si fatica a pagare il mutuo che lievita anche quando i tassi scendono. Nessun illecito, sia chiaro. Solo una gestione patrimoniale furba, ottima per gonfiare le stock option del management e tenere allegri gli investitori di breve termine. Peccato che nel lungo termine – quello in cui, secondo Keynes, siamo tutti morti – resti solo un patrimonio bancario impoverito e un sistema produttivo che si nutre di autopromozione più che di credito.
È qui che la famosa “tassa sul buy-back” cambia sapore. Non è più un attacco all’impresa, né un tic statalista da baraccone. Ma diventa un doveroso segnale di civiltà fiscale, che chiede a chi ha avuto molto (grazie, va detto, anche al rialzo dei tassi garantito dalla Bce) di restituire un po’ al sistema che lo ha reso ricco. Non tutto, solo una piccola parte, un “pizzicotto“ secondo il lessico del ministro Giancarlo Giorgetti. Un “grazie” con ricevuta, diciamo noi.
I difensori del libero mercato – quelli di scuola vecchia, con la copia di von Hayek sul comodino – sobbalzeranno. Eppure, anche nel manuale del perfetto liberale c’è un principio semplice: senza responsabilità sociale, la libertà d’impresa è solo un privilegio. E i buy-back, almeno come oggi vengono praticati, di responsabile hanno poco. Perché, diciamolo chiaro: il buy-back non è solo un modo per premiare l’azionista, è una scappatoia per il management, che anziché guadagnarsi il rispetto con i numeri, se lo compra in Borsa con il denaro dell’azienda. Un’autopromozione, insomma, più teatrale che meritocratica. E anche se il sistema li premia, la società civile – quella che paga le imposte, chiede mutui, apre aziende – spesso resta con il tradizionale pugno di mosche.
Qui, allora, la tassa – purché disegnata con intelligenza – diventa un argine. Non una punizione, ma un promemoria: che il capitale privato vive dentro un ecosistema fatto di regole comuni, di investimenti pubblici, di fiducia collettiva. E che se decidi di usare gli utili per far contenti i tuoi azionisti di passaggio, invece di rafforzare la banca o sostenere l’economia reale, allora un piccolo contributo straordinario lo puoi pure versare. Non per punizione, ma per decenza.
Naturalmente, la misura deve avere senso. Non si può colpire alla cieca. Deve essere proporzionata, trasparente, deducibile se reinvestita in capitale o credito. Insomma: non una mazzata ideologica, ma un meccanismo incentivante che scoraggi la finanza autoreferenziale e premi chi lavora per il lungo periodo.
E non si venga a dire che è un attentato alla competitività bancaria. Salvo qualche lodevole eccezione, le banche italiane – che pure fanno utili record – non si sono certo distinte per generosità con il Paese. Né con il credito a imprese e famiglie né con la tecnologia a favore del cliente. I bilanci crescono, ma gli sportelli chiudono. Le commissioni aumentano, ma spesso i servizi restano da anni Novanta. In compenso, i buy-back miliardari volano. Un paradosso? No, una scelta. Una scelta che va corretta con un piccolo, sobrio, prelievo simbolico.
E sia chiaro: non si tratta di demonizzare il profitto. Ma di domandare: che tipo di profitto vogliamo? Quello fondato sull’efficienza, sull’innovazione, sul servizio, o quello che si autoalimenta nei corridoi dei consigli d’amministrazione? Perché quando il secondo diventa la norma, la finanza smette di essere motore dell’economia e diventa solo un grande spettacolo di prestigio. Applaudito dai mercati, ma fischiato dalla realtà.
Ecco perché, alla fine, anche il liberale serio – non il caricaturale libertario che urla “Stato sovietico” ogni tre parole – può sostenere questa tassa. Non con entusiasmo, ma con lucidità. Non come soluzione, ma come gesto educativo. Non come ideologia, ma come antidoto a un capitalismo miope e autoreferenziale, che così facendo rischia di distruggere se stesso dall’interno.
© Riproduzione riservata