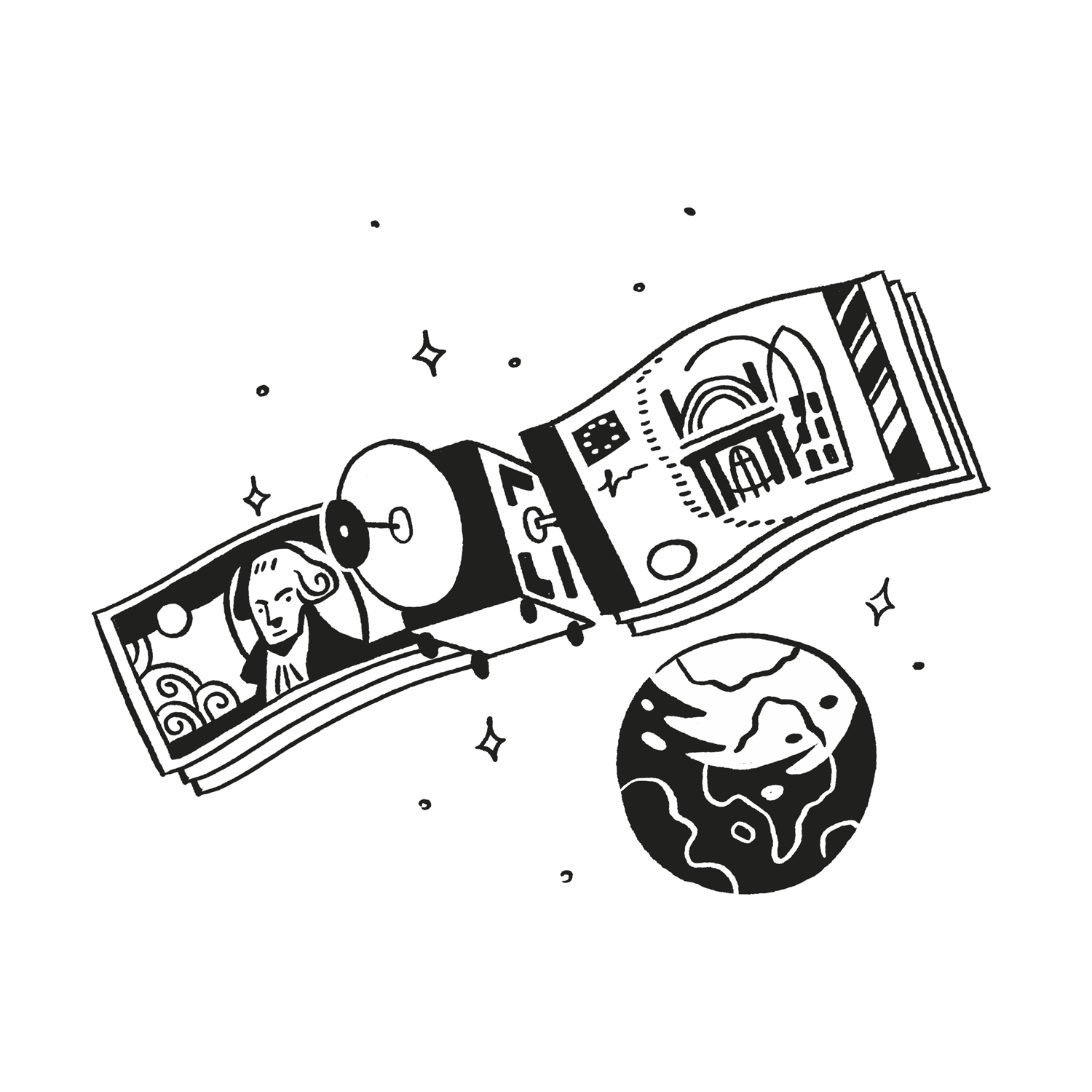I mandorli che fioriscono al Nord, dove sono emigrati anche gli ulivi e i pomodori, la raccolta dei grappoli di uva che parte a luglio, la rivoluzione climatica ha ridisegnato la geografia produttiva agricola del Bel Paese, che tra picchi di calore e piogge torrenziali, tanto bello rischia di non essere più. La vendemmia non è stata mai così anticipata come quest’anno lungo la Penisola, dove i primi grappoli di uve di Pinot Grigio e Chardonnay sono stati tagliati già a metà luglio in Sicilia, ben oltre due mesi prima rispetto alla scadenza tradizionale dell’autunno. Un record che è rappresentativo di come il clima stia cambiando l’agricoltura nazionale e i suoi prodotti più tipici.
Vengono infatti così smentiti i testi scolastici e anche gli antichi proverbi «ad agosto riempi la cucina e a settembre la cantina» e non vale più neanche l’adagio «a San Martino ogni mosto diventa vino» poiché sono diventate estremamente rare le uve non ancora raccolte entro l’11 novembre. A cambiare con il clima sono anche le caratteristiche dei grappoli. Il vigneto Italia produce adesso uve più precoci, meno acide e più dolci rispetto al passato. E il vino Made in Italy è aumentato di oltre un grado negli ultimi 40 anni con la necessità di un maggiore impegno degli enologi in cantina per garantire il rispetto delle caratteristiche e della qualità.
Cambiamenti in corso
Il surriscaldamento provoca il cambiamento delle condizioni ambientali tradizionali per l’invecchiamento delle bottiglie ma anche per la stagionatura dei salumi o l’affinamento dei formaggi. Una situazione che di fatto mette a rischio il patrimonio di prodotti tipici Made in Italy, che devono le proprie specifiche caratteristiche essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico e alla combinazione di fattori naturali e umani. E il caldo ha cambiato anche la distribuzione sul territorio dei vigneti che tendono ad espandersi verso l’alto con la presenza della vite a quasi 1200 metri di altezza come nel comune di Morgex e di La Salle, in provincia di Aosta, dove dai vitigni più alti d’Europa si producono le uve per il Blanc de Morgex et de La Salle Dop. A essere modificata è infatti anche la mappa delle coltivazioni in Italia. Se i frutti tropicali si sono espansi al Sud, i prodotti più tradizionali del Made in Italy come vino e olio sono saliti al Nord con la Pianura Padana che si è popolata nel tempo di colture tipicamente mediterranee, come grano duro e pomodoro da salsa, che per quasi la metà viene coltivato proprio nel settentrione. Si è assistito infatti nel tempo a un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale anche di alcune colture come l’ulivo che è spuntato alle pendici delle Alpi.
È infatti in provincia di Sondrio, oltre il 46esimo parallelo, l’ultima frontiera dell’olio d’oliva italiano. Si contano ormai oltre 100 ettari di ulivi con un trend in crescita e un interesse sempre maggiore alla produzione di olio extravergine d’oliva. Con le nuove stagioni al centro nord è arrivata anche la coltivazione del mandorlo, tipicamente siciliana, mentre si trova in difficoltà il mais, alimento base degli allevamenti, che ha bisogno di acqua per svilupparsi.
In Italia la raccolta 2024 ha confermato ancora una volta lo stato di sofferenza del comparto con rese in calo, pari in media a meno di 10 tonnellate all’ettaro, e superfici ridotte che hanno fatto segnare il nuovo minimo storico degli ultimi 160 anni con circa 495mila ettari, secondo l’analisi del Crea-Centro di Ricerca di Cerealicoltura e Colture Industriali. Senza dimenticare l’invasione di insetti e organismi alieni nelle campagne, nei boschi e nei vivai italiani, favorita dalla globalizzazione degli scambi e dagli scarsi controlli alle frontiere Ue. Si moltiplicano gli arrivi di formiche rosse, granchio blu, cimice asiatica, cinipide del castagno e popillia japonica. Quest’ultimo è un coleottero giapponese, altamente polifago che infesta e distrugge i tappeti erbosi, defoglia i vigneti e le piante da frutto ed ornamentali in parte del Piemonte e della Lombardia. I rischi maggiori li corrono il mais, il pesco, il melo, la vite e la soia.
È sufficiente una manciata di giorni per radere al suolo migliaia di metri quadri di colture. Se il granchio blu proveniente dall’ Atlantico dell’America sta cingendo d’assedio le coste italiane sterminando vongole veraci, cozze, altri pesci e molluschi, la “cimice marmorata asiatica” arrivata dalla Cina è particolarmente pericolosa per l’agricoltura perché con le punture rovina i frutti rendendoli inutilizzabili. Il caldo ha favorito anche la moltiplicazione degli insetti killer del bosco nell’arco alpino dove si è diffuso il Bostrico Tipografo, un coleottero che ama il clima arido ed asciutto ed è capace di infilarsi sotto la corteccia degli alberi scavando intricate gallerie che interrompono il flusso della linfa in particolare agli abeti rossi, ma anche al larice, l’abete bianco e il pino silvestre, uccidendoli nel giro di poche settimane.
E danni sta facendo anche la Drosophila suzukii il moscerino killer, molto difficile da sconfiggere, che ha attaccato ciliegie, mirtilli e uva dal Veneto alla Puglia. Gli inverni rigidi del passato riducevano le popolazioni dei parassiti delle piante che per effetto del clima più mite ora sopravvivono e diventa più difficile proteggere le coltivazioni. «Con il cambiamento climatico sotto accusa è il sistema di controllo dell’Unione Europea con frontiere colabrodo che lasciano passare materiale vegetale infetto e parassiti vari», afferma Lorenzo Bazzana, agronomo della Coldiretti. Una politica europea troppo permissiva che – precisa – consente l’ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell’Ue senza che siano applicate le cautele e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati con estenuanti negoziati e dossier che durano anni. Un danno pesante che si aggiunge a quello provocato dagli eventi climatici estremi sempre più frequenti su un territorio nazionale che per oltre un quarto (28%) è a rischio degrado e desertificazione per il calo della disponibilità di acqua che secondo Ispra si è fatto sentire soprattutto nelle regioni del Sud
L’agricoltura italiana è l’attività economica che più di ogni altra vive quotidianamente le conseguenze dei fenomeni meteo avversi ma è anche un settore oggi molto impegnato per contrastarli. Un obiettivo che richiede un sostegno da parte delle istituzioni per accompagnare l’innovazione che spazia dall’agricoltura 5.0 con droni, robot e satelliti fino alla nuova genetica green no ogm, che è in attesa del via libera dalle autorità di Bruxelles.
Sfide e opportunità
«Penso sia il momento di concludere l’iter di approvazione del regolamento sulle Tea e rendere operativa una normativa Ue che permetta di valorizzare le straordinarie opportunità offerte dalle nuove tecniche di evoluzione assistita, con l’obiettivo di metterle a disposizione degli agricoltori italiani ed europei per combattere i cambiamenti climatici e ridurre l’uso di input chimici», afferma Vincenzo Gesmundo, segretario generale della Coldiretti.
Ma servono anche investimenti per la manutenzione, il risparmio, il recupero e la regimazione delle acque in una situazione in cui l’Italia perde ogni anno l’89% della pioggia che cade sul territorio. Oggi infatti la maggior parte dell’acqua piovana va a finire nei 230mila chilometri di canali lungo il Paese e viene persa in mare. Da qui l’obiettivo di potenziarne la raccolta intervenendo sulle infrastrutture. Coldiretti con l’Anbi, l’Associazione nazionale delle bonifiche, ha elaborato un progetto immediatamente cantierabile per la realizzazione di una rete di bacini di accumulo con pompaggio. Anche quest’anno infatti il conto del caldo è stato pesante nelle campagne. In Puglia ad esempio, dove si coltiva il pomodoro per 1/5 dei pelati, passate e polpe nazionali, le alte temperature e la scarsità di acqua hanno tagliato del 30% la produzione di pelati. Ma in difficoltà sono tutte le produzioni agricole lungo la Penisola, a partire dal grano, la coltivazione più diffusa a livello nazionale. Negli ultimi tre anni i danni provocati all’agricoltura italiana dal caldo tropicale e dalle bombe d’acqua e grandinate hanno superato i 20 miliardi di euro. Per questo il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha accolto positivamente l’annuncio del vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, di finanziare direttamente la gestione idrica, attraverso le risorse comunitarie dei fondi di coesione, per la realizzazione dei bacini di accumulo. «Si tratta – ha affermato Prandini – di una svolta attesa da tempo, che ci consentirà finalmente di investire in infrastrutture fondamentali per trattenere l’acqua nei periodi di pioggia e renderla disponibile durante le fasi di emergenza. I bacini di accumulo rappresentano una delle grandi battaglie di Coldiretti per contrastare la siccità e garantire l’approvvigionamento idrico. Anche l’Europa riconosce oggi che l’acqua è un bene strategico, essenziale non solo per il futuro dell’agricoltura, ma per la crescita economica dell’intero Paese».
© Riproduzione riservata