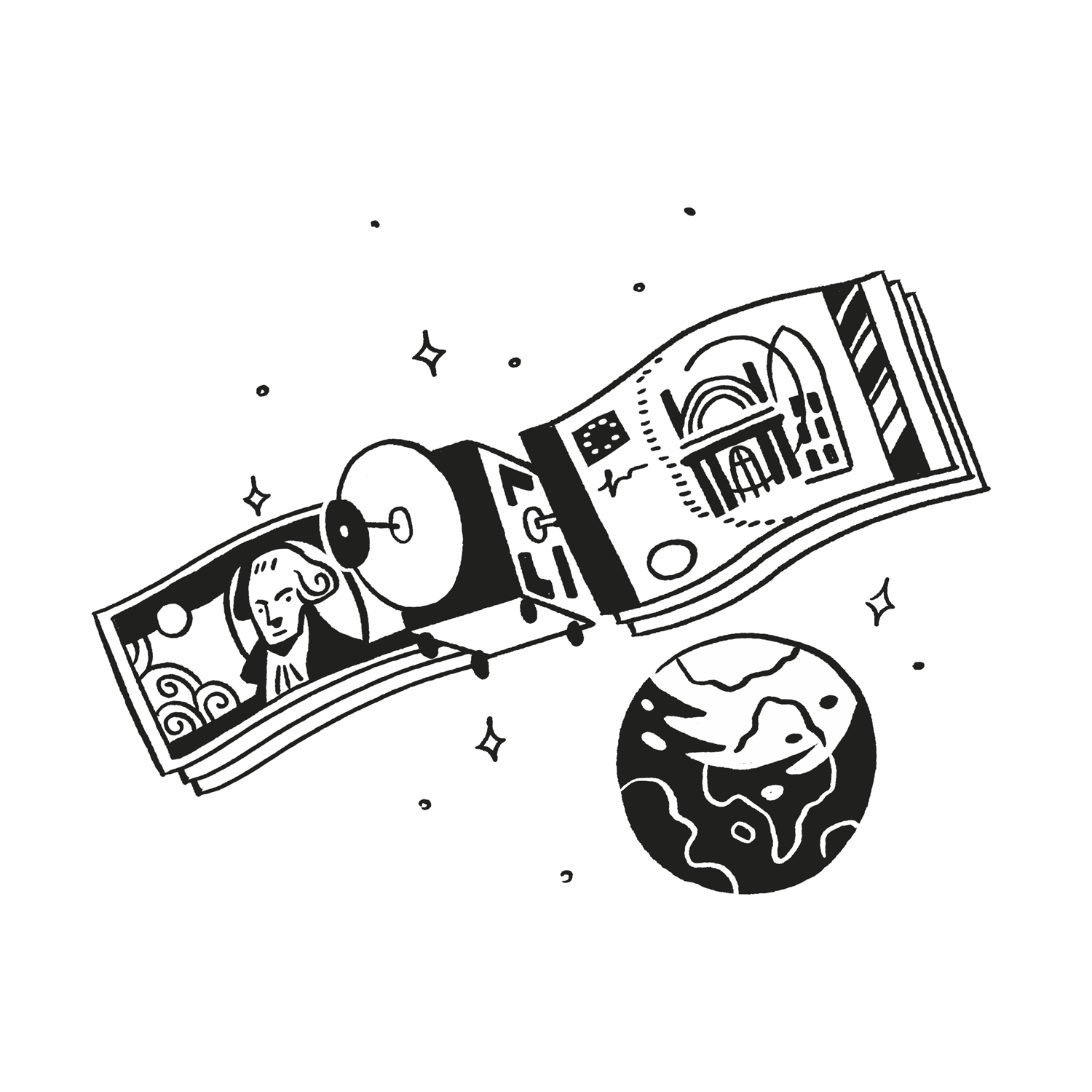Ci voleva la mano fredda del tribunale di Torino per strappare via l’ultima maschera a quella che per decenni è stata la “famiglia reale” italiana: gli Agnelli. John Elkann, erede di quel potere e di quella leggenda, è stato costretto ad ammettere – nei fatti, non nelle parole – una delle colpe più volgari per chi si definisce liberale e imprenditore: avere frodato l’Agenzia delle entrate. Ha patteggiato per evitare il processo, versando nelle casse del fisco 183 milioni e accettando, con sobrietà calcolata, un anno di servizi sociali. Questo è ciò che resta, oggi, dell’onore industriale della dinastia Agnelli.
Per cinquant’anni – lo diciamo senza retorica – la Fiat ha rappresentato l’Italia. Non una semplice fabbrica, ma un sistema-paese. Con tutti i suoi limiti, fu la locomotiva della seconda metà del Novecento: quasi un milione di lavoratori tra dipendenti diretti e indotto, città cresciute attorno alle fabbriche, università fondate per fornire ingegneri, famiglie intere sollevate dalla povertà contadina per entrare nel cuore pulsante dell’industria. Era un potere, sì. Ma un potere che creava valore e appartenenza, con tutte le sue imperfezioni, che non erano poche.
In meno di dieci anni, quel patto implicito – tra impresa e Paese – è stato stracciato, calpestato, trasformato in qualcosa di peggiore: un’eredità svuotata, usata per alimentare un patrimonio personale, una cassaforte olandese, una strategia di disimpegno. E qui sta la sconfitta della politica industriale italiana: l’avere smesso, a partire dagli anni Duemila, di esercitare un ruolo attivo nella costruzione e nella difesa della sovranità produttiva. La Fiat, in forti difficoltà, è stata lasciata sola quando invece serviva accompagnarla verso nuovi mercati. E poi è stata abbandonata dalla proprietà, svenduta, disintegrata quando ha scelto la strada più facile – quella della fusione con la francese Psa – senza un contrappeso nazionale.
Piaccia o meno, un tempo lo Stato italiano aveva una strategia industriale. Dalla legge Sabatini ai fondi per la meccanizzazione, dai contributi per la ricerca all’Iri, dalla concertazione tra sindacati e imprese fino ai vincoli nelle dismissioni. Oggi la parola “politica industriale“ è scomparsa dal lessico dei ministeri e se ne parla poco anche sui giornali. Così si è dissolto anche il principio che una grande impresa, se sostenuta dalla collettività, deve rispondere alla collettività.
Ma quella di Elkann non è solo una frode fiscale. È un tradimento morale. Di fronte a centinaia di milioni sottratti al fisco italiano grazie a una residenza fittizia in Svizzera – non da un imprenditore marginale, ma da uno dei volti del capitalismo nazionale – il silenzio della classe dirigente è assordante. Nessuna parola di scuse. Nessun segno di vergogna. Solo l’arroganza di chi si ritiene intoccabile. È lecito allora interrogarsi su cosa ha lasciato davvero Gianni Agnelli. Un patrimonio, certo. Pure una memoria patinata e molti amici nei salotti; e potremmo discutere all’infinito sull’entità vera dei miliardi che lo Stato ha versato nelle casse del gruppo torinese, diventato grande non solo per meriti imprenditoriali. Ma non possiamo ignorare il lascito di un’idea che l’Avvocato, pur con tutte le sue contraddizioni, non ha mai tradito: che l’impresa ha un compito civile e che la grandezza industriale deve portare con sé responsabilità e stile in un legame profondo con il Paese.
Lo smantellamento
Oggi tutto questo è stato sostituito da una nuova cultura: quella del family office, della finanza svincolata dal territorio, della rendita. Dopo la morte di Sergio Marchionne – l’ultimo a parlare di «dovere industriale» – la dinastia Elkann ha accelerato lo smantellamento dell’identità Fiat. Marchionne non era un santo né un sentimentale. Ma aveva una visione. E soprattutto un principio saldo: l’impresa deve produrre valore, non solo dividendi. Fu lui, con lucidità brutale, a salvare la Fiat da un destino di declino, a puntare sull’auto americana quando tutti cincinschiavano, a chiudere stabilimenti improduttivi per salvarne altri. Fu lui a dire, nel pieno della crisi, che «lo Stato deve essere rispettato perché siamo ancora in Italia, anche se operiamo nel mondo». E fu sempre lui a costruire, mattone dopo mattone, la base di quel gigante industriale che oggi porta il nome Stellantis. Un nome dietro cui Elkann ha nascosto il disimpegno, la fuga, la smobilitazione. Quel che Marchionne costruì con il sacrificio anche personale, Elkann oggi lo amministra come un fondo patrimoniale. Con il fisco aggirato, i doveri cancellati, l’Italia lasciata indietro. È un tradimento non solo dell’impresa, ma della memoria di un uomo che aveva rimesso in piedi un colosso e che credeva nel valore del lavoro.
La cessione a Psa, celebrata come alleanza, è stata in realtà una svendita. La governance è francese. I centri decisionali sono lontani. La parola “Italia” nel nuovo impero Stellantis è poco più di un marchio storico da sfruttare. Gli operai di Pomigliano, di Mirafiori, di Melfi – un tempo orgoglio nazionale – oggi vivono nell’incertezza, tra tagli e cassa integrazione. Mentre i dividendi milionari viaggiano verso l’Olanda o i trust familiari. Chi ha beneficiato per decenni di miliardi di lire in aiuti pubblici, garanzie, salvataggi, protezioni? Chi ha ricevuto dallo Stato e ora rinnega ogni dovere verso lo Stato?
Non è solo una questione economica, ma anche etica. Il capitalismo liberale presuppone merito, rischio, trasparenza, e restituzione alla comunità. Qui abbiamo avuto l’esatto opposto: un’élite cresciuta anche con i soldi dello Stato, che si comporta come una dinastia feudale, priva di senso civico. La guerra intestina tra Elkann e la madre Margherita – per il controllo dell’enorme eredità – è lo specchio di questo degrado. Non più industria, non più visione, solo spartizione del bottino.
La parabola Elkann non è solo vicenda personale. È un monito per l’intero sistema Italia. Se la nostra borghesia imprenditoriale ha smesso di pensarsi come classe dirigente, se considera lo Stato un ostacolo e non un interlocutore, se non sente più il dovere morale di costruire, ma solo quello di proteggere se stessa, allora l’Italia ha perso molto più di una fabbrica.
© Riproduzione riservata