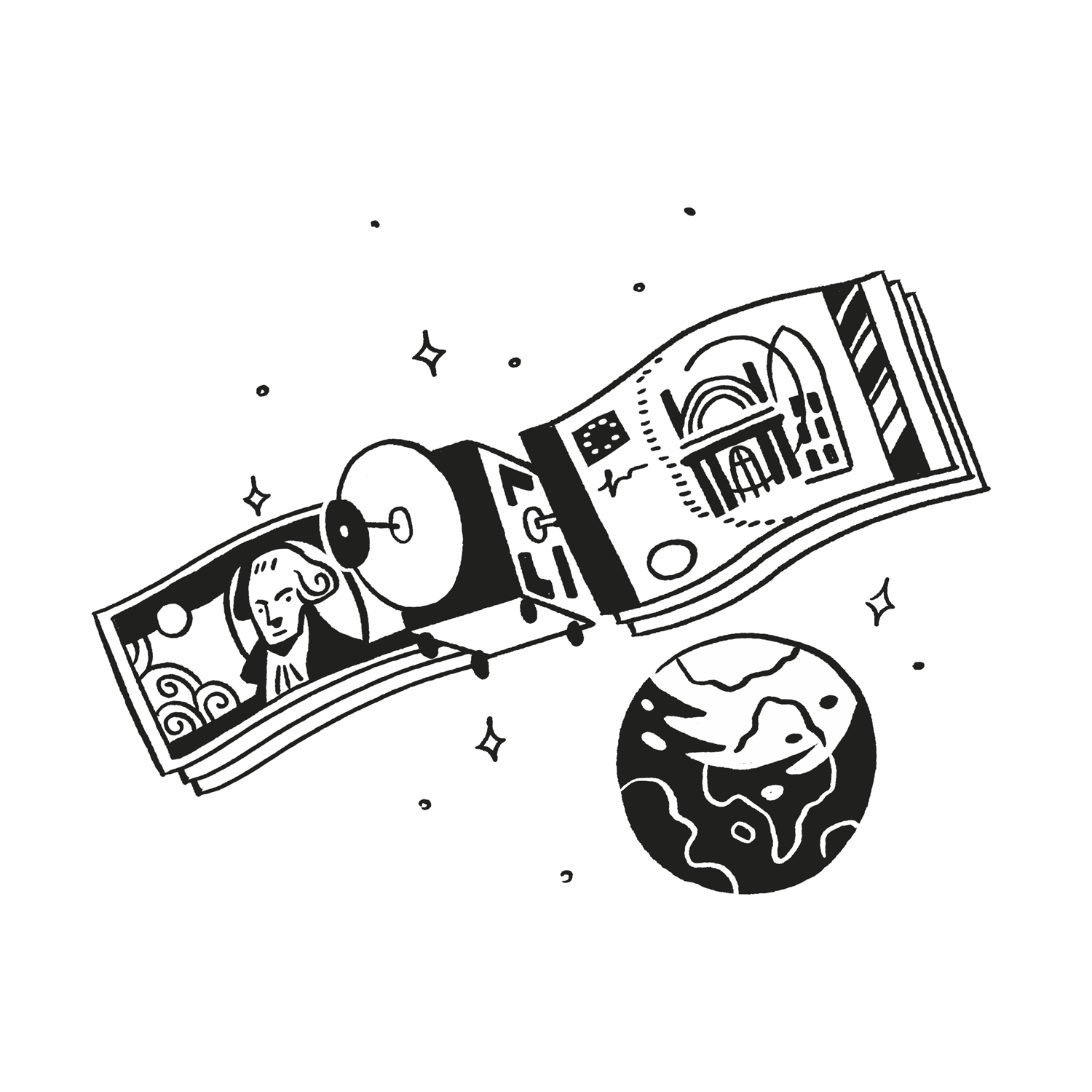La vicenda è di questi giorni e ha come teatro Kenwood House, villa-museo nella campagna a nord di Londra, dove è stata nei giorni scorsi inaugurata la bizzarra mostra intitolata “Double vision Vermeer”; ovvero, in chiave enigmistica, trova le differenze e indovina qual è il Vermeer “buono”. In realtà non vi sarebbe alcun intento provocatorio nella messa a confronto delle due versioni di uno dei più celebri dipinti del maestro fiammingo, “La suonatrice di chitarra”, opera datata 1672. Secondo gli esperti sarebbero entrambi autentici capolavori, salvo il fatto che l’opera ospite, “The Lady with a guitar”, in prestito dalla John G. Johnson Colletcion del Museo di Philadelphia, è stata per lungo tempo considerata l’originale; almeno fino a quando, nel 1927, non apparve la gemella di Kenwood che per qualità e stato di conservazione fu con certezza attribuita a Vermeer.
Ed ecco spuntare la parola magica che detta le sorti del paradossale sistema dell’arte: attribuzione o, come in questo caso, re-attribuzione, azione che classifica l’autenticità o meno di un’opera d’arte determinandone, spesso in modo drastico, prezzo e valore. Una questione non da poco le cui sorti sono nelle mani dei cosiddetti esperti, storici e critici, ma spesso anche degli eredi che fanno e disfano archivi non sempre adamantini. E se per quanto riguarda le opere antiche oggi viene in soccorso l’alta tecnologia per stabilire falsità o autenticità, per l’arte contemporanea (più facilmente falsificabile) spesso il marasma è totale.
Inquietanti, in merito, sono alcuni report secondo cui almeno un terzo delle opere in circolazione (musei compresi) sarebbe falsa o di incerta attribuzione. Ma escludendo il mercato dei falsi dolosi che, secondo l’Interpol, garantisce al crimine organizzato profitti globali per 67,4 miliardi di dollari, esiste un’immensa “zona grigia” (di cui fa parte anche la chitarrista di Vermeer) composta dal mercato delle copie storicizzate e da quello, florido e legale, delle riproduzioni d’arte, il cui valore globale ha superato nel 2024 i 40 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 77 miliardi entro il 2032.
Questo vivacissimo segmento commerciale include sia dipinti realizzati a mano, i più apprezzati per “autenticità” e fedeltà tecnico-estetica, sia le riproduzioni digitali che dominano per volumi d’acquisto in virtù della loro precisione e dei costi contenuti, sia le opere cosiddette “tecno-ibride”, frutto di combinazioni tra stampa digitale e ritocchi manuali.
Qui, lo ripetiamo, non si parla di falsi ma di riproduzioni, anche se possono sussistere criticità legate a infrazioni del copyright, in un mercato che sta letteralmente volando grazie alla forte domanda di decorazioni artistiche accessibili da parte di privati e di catene alberghiere (specie dai Paesi emergenti), ma anche in virtù della presenza di piattaforme online specializzate come Saatchi Art, Art.com, Redbubble, ICanvas. Le sfide principali per questo settore riguardano, come si diceva, questioni legate agli abusi sul diritto d’autore con l’eventuale diffusione di riproduzioni non autorizzate, e poi i costi elevati per attrezzature di stampa ad alta tecnologia.
Ma intanto il mercato viaggia a gonfie vele, capitanato dal Nord America, grazie al dominio nell’e-commerce e nel mercato degli arredi, seguito a breve distanza dall’area Asia-pacifico con la Cina leader; più cauto il mercato europeo che, anche per ragioni culturali e di difesa del patrimonio artistico, tende a privilegiare le riproduzioni artigianali.
A proposito di Cina, tradizionalmente regina mondiale della contraffazione e del mercato di prodotto “tarocco”, merita sottolineare il caso della città di Shenzhen che ha trasformato la produzione di falsi in una gigantesca forza lavoro. Parliamo del “villaggio” di Dafen dove oltre 7.000 artisti e 1.200 gallerie sfornano in continuazione copie di capolavori della storia dell’arte, da Michelangelo a Van Gogh. Tutto assolutamente legale.
E d’altra parte è anche onesto ricordare come la copia di capolavori, ovvero “dipingere alla maniera dei maestri”, rappresenti un’arte consolidata fin dall’antichità, per ragioni di studio, divulgazione e di conservazione delle opere; artisti come Rubens, Rembrandt e Velasquez, per intenderci, furono illustri copisti di Tiziano e Raffaello. Ma anche nel mondo degli old masters il carosello delle attribuzioni ha generato migliaia di “casi”, alcuni clamorosi: come la copia seicentesca della Gioconda appartenuta all’antiquario francese Raymond Hekking e venduta all’asta da Christie’s alla bellezza di 2,9 milioni di dollari, in virtù di una leggenda ben orchestrata dal suo proprietario, secondo cui al Louvre ci sarebbe soltanto… una copia.
Leggi anche:
1. Destino dell’arte confiscata: il recupero dell’evasione può essere incorniciato
2. Arte, mercato ancora in flessione: pesano guerre e IA
© Riproduzione riservata