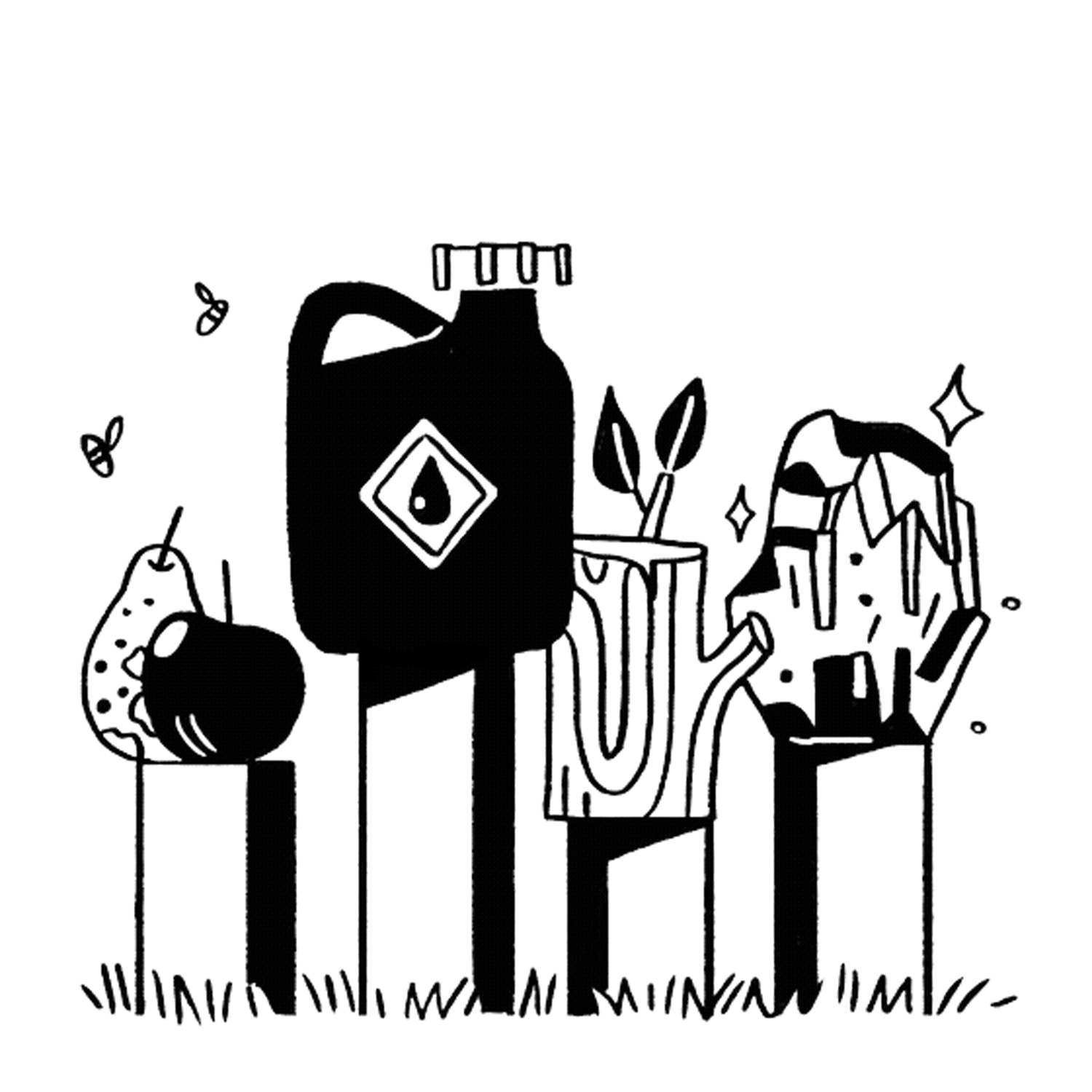C’è un errore che si ripete ogni volta che la storia accelera: confondere la correlazione con la causa. Gli statistici lo sanno bene, i politologi molto meno. Vedere due eventi che si muovono insieme non significa che uno abbia provocato l’altro. Spesso c’è una terza forza non immediatamente percepibile che agisce su entrambi gli eventi condizionandoli.
Questa riflessione torna utile leggendo uno studio del Consiglio Europeo per le Relazioni Estere che punta il dito contro il presidente americano Donald Trump, accusandolo di essere la scintilla che ha acceso l’ascesa della destra in Europa. È la tentazione tipica di un certo centro moderato, che non capendo fino in fondo le dinamiche in corso, cerca un capro espiatorio immediatamente visibile per placare con una risposta quale che sia, pur di placare l’ansia del vuoto.
La storia insegna
È la stessa illusione che circolava nel 2008, quando la crisi finanziaria globale esplose e molti si convinsero che bastasse trovare «il gruppo di banchieri malvagi» responsabile del disastro. Col passare del tempo, gli storici hanno chiarito che non si trattò di un complotto di pochi banchieri voraci, ma di politiche sbagliate portate avanti dall’amministrazione centrale: deregolamentazione selvaggia, supervisione bancaria inefficace, eccesso di leva finanziaria. I comportamenti individuali, certo, hanno avuto un ruolo. Ma la vera causa fu sistemica.
Oggi siamo di fronte a un fenomeno analogo. L’avanzata della destra non nasce da un singolo uomo o da una singola strategia politica. E se vogliamo attribuire tutto a Trump, allora la domanda successiva è inevitabile: che cosa ha causato il fenomeno Trump?
I grandi terremoti politici, come comunismo e fascismo nel Novecento, hanno sempre avuto radici economiche e sociali profonde. E così oggi. A nostro avviso, saranno ricordate come decisive le scelte macroeconomiche degli ultimi decenni: una fede cieca nel libero scambio e in una politica monetaria che ha favorito bolle speculative, mentre intere comunità industriali venivano abbandonate.
Il fattore economico-sociale
La deindustrializzazione ha svuotato città e regioni, alimentando rabbia e sfiducia. Il Quantitative Easing ha ridistribuito la ricchezza in modo traumatico come nessun’altra misura nella storia. Chi non vive in queste aree – nelle città fantasma della Rust Belt americana, nei quartieri abbandonati della Germania orientale, nei centri industriali decadenti del nord dell’Inghilterra – fatica a comprendere quanto profondo sia il disagio. Ma basta allontanarsi di pochi chilometri da Londra o New York City per toccarlo con mano.
Non sorprende allora che partiti nati come fenomeni locali, come l’AfD tedesca, stiano espandendosi a Ovest, o che figure come Nigel Farage trovino consensi trasversali. Persino Trump ha raccolto voti inattesi in roccaforti democratiche come lo Stato di New York.
La politica anti-innovazione
In Europa, a peggiorare il quadro, c’è la mancanza di innovazione. Il Vecchio Continente è rimasto intrappolato in settori a medio contenuto tecnologico, con produttività stagnante. A sua volte la politica, anziché liberare energie, ha imposto regole che hanno finito per soffocarle: Gdpr, norme sull’intelligenza artificiale, Green Deal. Tutte espressioni di un consenso progressista che, pur animato da buone intenzioni, ha condannato l’Europa a restare indietro rispetto a Paesi come Stati Uniti e Cina.
Oggi, paradossalmente, sono proprio le stesse élite che hanno sostenuto queste scelte a voler spiegare l’ascesa della destra con la favola dei «cattivi che ingannano i semplici». È una narrazione comoda, ma sbagliata. Perché la crisi che stiamo vivendo non nasce dalle menzogne di un leader carismatico, bensì da decenni di politiche miopi che hanno eroso la fiducia, distrutto comunità e alimentato la percezione di un futuro senza prospettive. Trump non è la causa: è il sintomo. Ed è proprio questo che fa più paura
© Riproduzione riservata