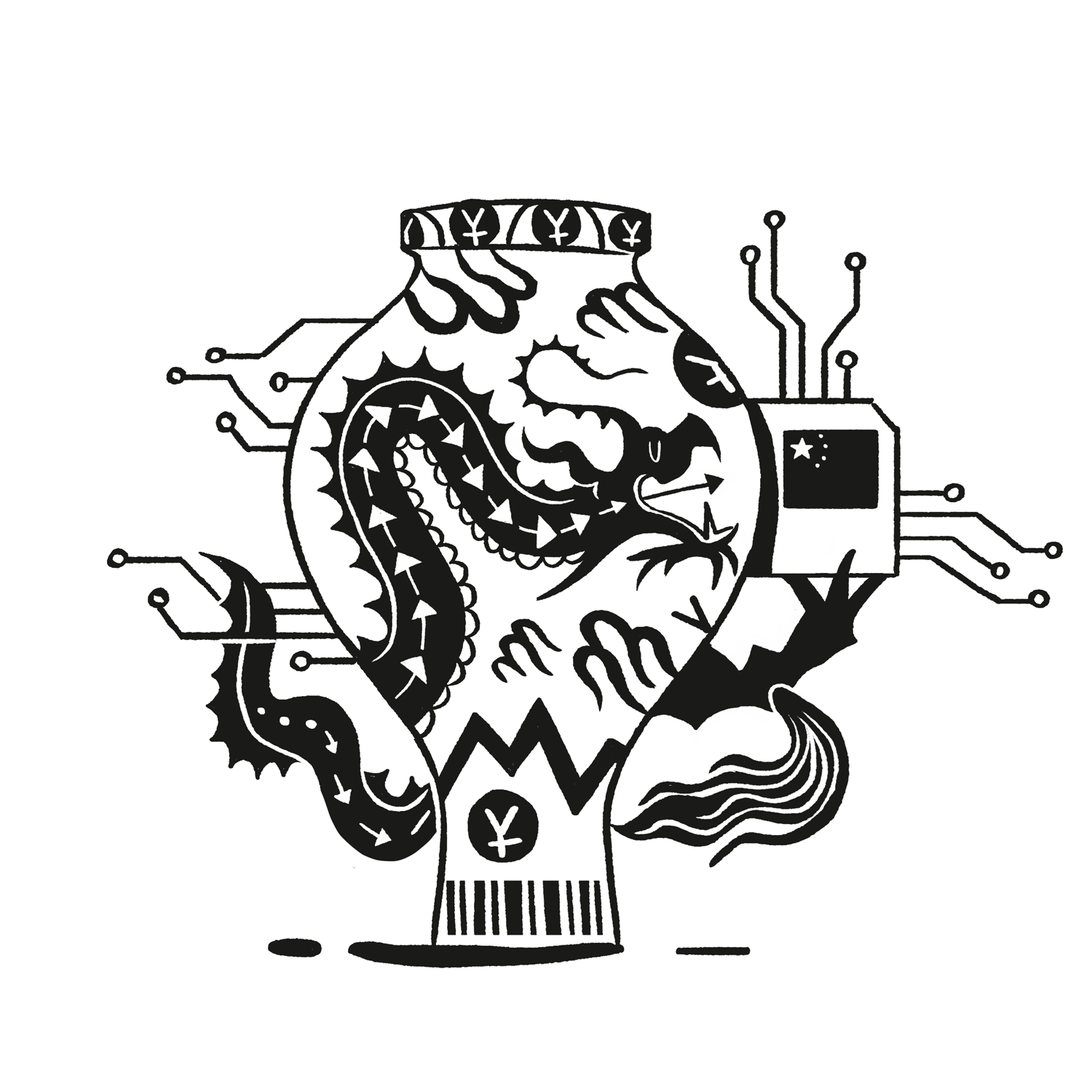Si parte da un’immagine. Un carro armato da milioni di dollari abbattuto da un drone che ne costa poche migliaia. È la metafora che secondo il teologo e filosofo francescano Padre Benanti racconta la nostra epoca, in cui l’intelligenza artificiale ha rotto gli argini delle regole sottese ai rapporti economici e sociali.
All’evento del Giornale in collaborazione con Moneta – “La nuova Rivoluzione industriale” – il filosofo spiega che le nuove tecnologie hanno cambiato la natura degli oggetti e del modo in cui li scambiamo. Il loro valore non risiede più soltanto nella loro fisicità, ma nella componente immateriale che li governa.
«Perché quando, guardando quello che sta succedendo sui campi di battaglia, ci siamo accorti che un carro armato da 300 milioni di dollari può essere sconfitto da un drone da 1.500 euro, abbiamo messo in atto o abbiamo reso visibile e non più negabile quello che sta succedendo di fatto dall’avvento della digitalizzazione, cioè che cambiamo la natura degli oggetti che abitano il nostro mondo».
E non muta solo la natura, ma anche il valore di quel bene e il concetto stesso di proprietà e di scambio economico. Una bottiglia è un oggetto definito, che può avere anche un doppio uso e diventare arma, proprio per questo non si possono portare bottiglie chiuse negli stadi. Ma la digitalizzazione incalzante altera questa linearità. «Quando comprate uno smartphone, voi pagate quei mille euro uno strumento top di gamma per un hardware, ma quello che gli consente realmente di funzionare è il software. Ma il software voi non lo comprate, ce l’avete solo in licenza. E con un aggiornamento può cambiare radicalmente che cosa fa e come agisce quell’oggetto». È quello che hanno scoperto in Ucraina, dove i droni vengono aggiornati ogni cinque minuti e diventano armi sempre diverse. E qui emerge una difficoltà enorme per il legislatore, abituato a normare oggetti solidi e definiti. «Un oggetto che può cambiare improvvisamente la sua natura in una maniera fluida e con un aggiornamento del software come lo normiamo?».
Cambia quindi anche il contenuto che noi assegniamo al concetto di proprietà di un bene. Benanti ricorda come nel diritto romano il possesso fosse definito da tre diritti: usus, abusus e fructus. «Usus significa che io lo posso usare. Abusus che lo posso distruggere. E fructus che ne posso guadagnare dei frutti di utilizzo». Le nuove tecnologie hanno provocato il crollo di questa tripartizione. L’abusus è quasi incoraggiato, se rompiamo uno smartphone ne compriamo un altro. L’usus non è garantito, perché dipende da vincoli esterni, dalle regole commerciali e geopolitiche che limitano le funzioni disponibili, come il Digital act europeo che limita alcune funzioni delle grandi piattaforme statunitensi. «È come se voi compraste una macchina e vi dicessero: no, qui non va per strada perché non ci piace il vostro codice della strada. Ma è mia, no?».
Ma ciò che ci è veramente sottratto è il fructus, perché i soldi, cioè il valore che creiamo con quell’oggetto, «vanno alle grandi piattaforme software che abitano sul nostro telefonino». Sorge una domanda inquietante: se il processo di creazione di valore passa sempre più attraverso sistemi digitali e intelligenza artificiale, siamo sicuri che i frutti rimarranno nei Paesi dove il valore viene prodotto? «Se la catena produttiva con l’IA si trasforma a tal punto da renderla ineluttabile, quello che oggi noi produciamo in Italia lascerà ancora il fructus in Italia?», si chiede il filosofo.
Ad essere in pericolo, prima ancora del concetto di proprietà, è il lavoro. Lo sappiamo, l’intelligenza artificiale riesce a svolgere gran parte delle funzioni umane – soprattutto quelle alte – molto meglio di noi. «Una calcolatrice solare che risolve una radice quadrata costa 78 centesimi – spiega Benanti -, ma una mano robotica capace di aprire una maniglia arriva a 150 o 200 mila euro». Il problema sta tutto nel capire che cos’è l’umano: «Noi pensiamo che stia solo nella mente. In realtà noi siamo incarnati, quindi anche il nostro corpo ci aiuta a pensare.
Un bambino di quattro anni, se non stiamo attenti, apre la porta di casa e scappa in strada, per fare una radice quadrata deve avere almeno 12-13 anni». Questo significa che le funzioni cognitive sono quelle più a rischio, proprio perché possono essere facilmente sostituite dalla macchina.
Il fenomeno è già visibile nel settore del delivery, dove la forza muscolare della bicicletta resta all’umano, ma l’organizzazione – la parte che decide chi consegna cosa e a chi – è interamente in mano a un sistema digitale. «Questo ha un effetto sociale che se non gestito è detonante, perché presto l’intelligenza artificiale andrà a mangiare i lavori meglio pagati nella società».
Non scompaiono solo i lavori, muore una traiettoria sociale. Se un tempo si entrava nel mercato del lavoro con l’aspettativa di far carriera, oggi i ruoli apicali sono facilmente rimpiazzabili dall’IA. «Saremo una serie di personale che svolge i compitini a cui l’intelligenza artificiale non arriva», avverte.
Per questo di vitale importanza è una politica che si faccia carico dei problemi che si porta dietro l’utilizzo delle nuove tecnologie. «L’intelligenza artificiale che vogliamo è quella che consente alle persone di fare meglio il mestiere, di fare meglio il loro lavoro».
Ma perché questo accada, occorre muoversi su più fronti: garantire agli studenti competenze umane adeguate, aiutare i lavoratori già inseriti a vivere la transizione tecnologica, e più di tutto sostenere le imprese italiane perché non diventino semplici esecutrici di modelli elaborati altrove.
«Alcune eccellenze italiane negli anni hanno dimostrato, anche nel corso del boom del dopoguerra che l’innovazione e lo sviluppo possono andare insieme. Abbiamo bisogno di nuove forme di questo tipo di innovazione che diventa sviluppo perché dobbiamo nuovamente scrivere un contratto sociale», conclude Benanti.
Leggi anche:
© Riproduzione riservata