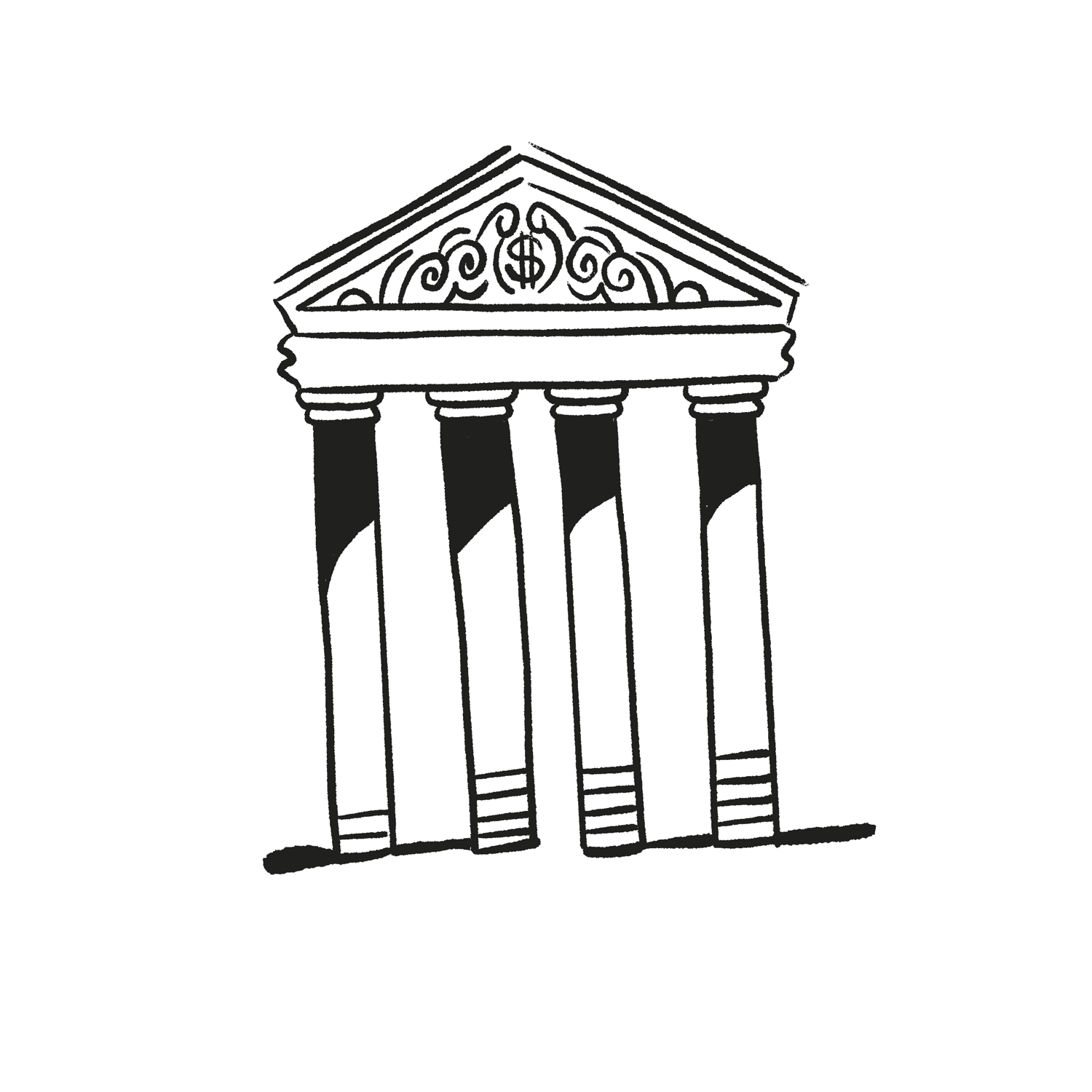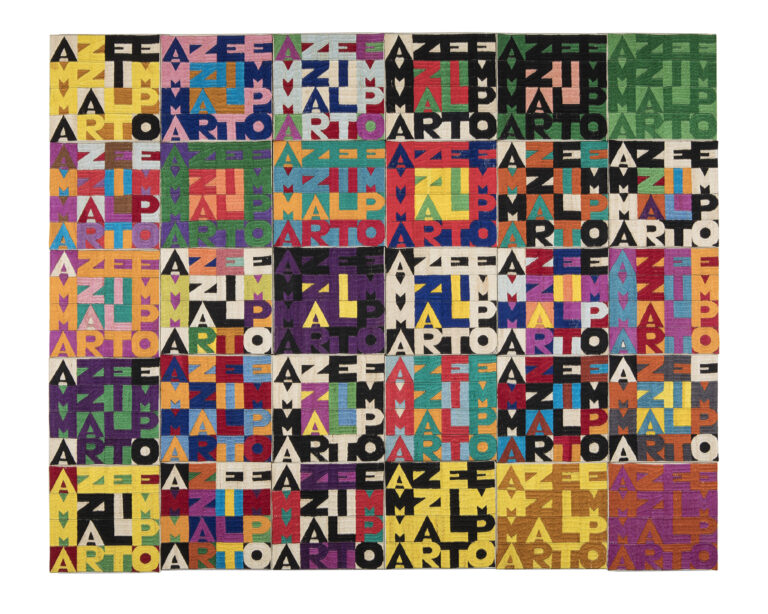Chi ama la storia dell’arte sa benissimo che a farla non sono stati solo gli artisti ma anche tutti quei collezionisti che li hanno riconosciuti e aiutati quando valevano poco o erano addirittura rifiutati dal mercato. Personaggi come Peggy Guggenheim, Gertrude Stein, Leo Castelli, Herbert e Doroty Vogel, Domenico Gnoli e molti altri sono i grandi collezionisti rimasti agli annali per le loro raccolte finite nei più prestigiosi musei del mondo, frutto di una ricerca appassionata, dell’amicizia con gli artisti e di ore di studio. In era contemporanea, mediamente e salvo rare eccezioni, i grandi collezionisti 2.0 si approcciano all’arte con lo stesso spirito con cui si accostano ai listini delle Borse internazionali, acquistando opere che non sempre hanno visto da vicino ma affidandosi anima e corpo ai cosiddetti “art advisor”, figure sempre più diffuse e ormai quasi imprescindibili nelle compravendite significative.
La ragione è semplice: questi particolari consulenti, quasi sempre esperti con un forte background artistico e un grande portafoglio di relazioni con gallerie, musei e case d’asta, si assumono l’onere di consigliare e valutare l’acquisto di un’opera e la sua congruità, in un mondo dell’arte sempre più difficile e infarcito di trappole. Gli art advisor valutano per conto del collezionista il prezzo di un’opera, la sua autenticità, il suo stato di conservazione, il suo posizionamento nel mercato, la sua libera circolazione internazionale e talora – formula magica per l’arte nell’epoca della sua riproducibilità finanziaria – la sua convenienza come investimento.
Non è un caso, del resto, che dopo la metà degli anni ’90 l’art advisory sia un servizio strutturato messo a disposizione anche dalle banche, finalizzato a valutare il patrimonio artistico del cliente supportandolo per evitare passi falsi e cogliere le migliori opportunità offerte dal mercato. In questo calderone hanno avuto buon gioco anche società fondiarie che offrono la comproprietà di un’opera milionaria frazionandola in quote con l’obiettivo di rivenderla sul mercato nel medio-lungo periodo.
Un’aberrazione che probabilmente farà rivoltare nella tomba Peggy Guggenheim, ma che ben fotografa il mondo con cui oggi si confrontano gli art advisor, figure che hanno il dovere etico di esercitare un ruolo super partes, ovvero non avere conflitti di interesse nelle compravendite; il loro compenso deve infatti essere riconosciuto soltanto dall’acquirente e non da chi vende, galleria, casa d’asta o privato che sia.
Tutto semplice? Mica tanto, e infatti le zone grigie sono ampissime, così come numerosi sono nel mondo dell’arte gli intermediari che si spacciano per consulenti solo per ottenere laute percentuali. Ma del resto esistono società private serissime che collaborano anche con istituzioni pubbliche, ed enti internazionali che si avvalgono di professionalità accreditate come la Association of Professional Art Advisors (Apaa). Questi soggetti svolgono un’attività complessa come sempre più complesso è un mondo dell’arte avventatamente equiparato da molti operatori e collezionisti a quello finanziario. La riprova è un mercato che negli ultimi due anni sta attraversando una brusca flessione sia nelle fiere che nelle aste. «L’arte non è un investimento, è un lusso», ama da sempre ripetere il grande antiquario italiano Fabrizio Moretti, e probabilmente ha ragione. Clarice Pecori Giraldi, una lunghissima carriera alla dirigenza delle maggiori case d’asta mondiali e oggi executive member dell’Apaa, cerca di mettere un po’ d’ordine: «Per diventare art advisor bisogna avere una profonda conoscenza del mercato di riferimento, che si acquisisce solo con anni di lavoro; i rischi per i collezionisti derivano principalmente dalla mancata regolamentazione di questo settore in cui in molti si improvvisano. L’Apaa, di cui faccio parte, stabilisce però precise regole di comportamento e vigila sulla professionalità e sulla correttezza dei propri membri. Per quanto riguarda la frenata del mercato, invece, in fondo me ne rallegro perché si era di fronte a una bolla speculativa di derivazione americana che non aveva nulla a che fare con il contenuto delle opere e con il valore degli artisti. Nella mia lunga carriera non ho mai raccomandato l’acquisto di opere d’arte come investimento, perché l’investimento in arte, se c’è, è soltanto emozionale».
© Riproduzione riservata