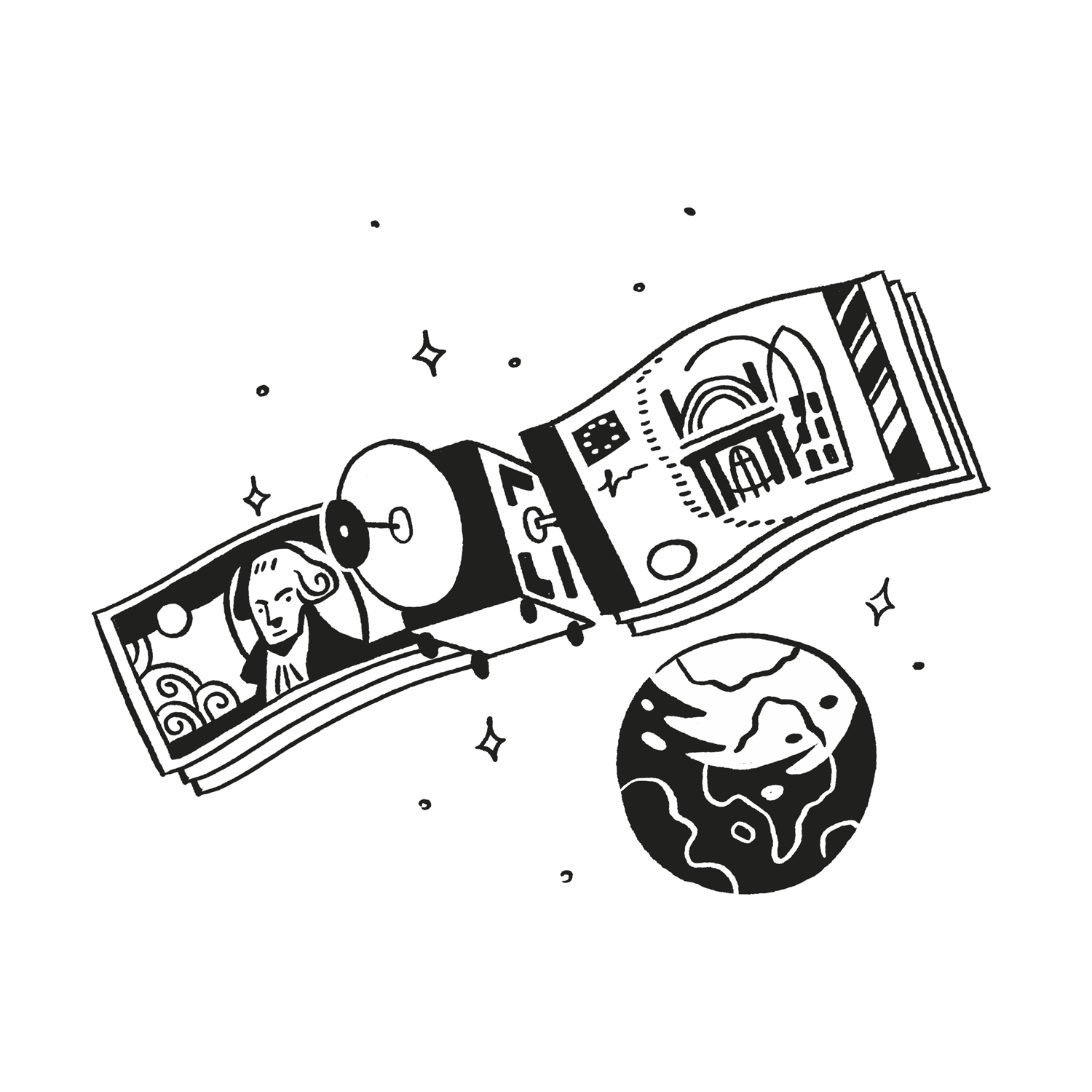C’è chi ne lamenta l’eccessiva prudenza, chi ne sottolinea l’inerzia. Per noi è semplicemente un esercizio di realismo. La legge di Bilancio che il governo Meloni propone al Parlamento per il 2026 è una manovra sobria, ancorata ai binari del rigore europeo, con un disavanzo che si ferma sotto il fatidico 2,8%. Una soglia che non è solo un numero, ma il confine psicologico tra affidabilità e azzardo. Dopo anni di deficit espansi, bonus a pioggia e illusioni contabili, tornare alla normalità dei conti è un merito, non un difetto.
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, non ci entusiasma, ma ci convince. Non accende il motore della crescita, ma evita di farlo grippare. E, in tempi di tassi ancora relativamente alti e geopolitica in fibrillazione, la prudenza non è codardia: è igiene fiscale. Chi si scandalizza per una manovra da appena 18,7 miliardi dimentica che la virtù, nei conti pubblici, non è spendere tanto ma spendere bene. Il censore Carlo Cottarelli lo ha detto con chiarezza, senza sofismi: manovra coerente, non fa danni, sebbene non risolva i nodi strutturali. E ha ragione. Questa non è la manovra del rilancio, ma quella che mette il sigillo sul risanamento, che consente di archiviare la procedura d’infrazione in Europa, chiudendo il ciclo dell’emergenza permanente. Dopo di essa, se davvero vogliamo uscire dalla palude di una crescita da prefisso telefonico, dovrà arrivare la manovra del coraggio. Perché l’Italia è ferma da trent’anni non per penuria di soldi, ma per mancanza di scelte. Burocrazia pachidermica, giustizia lenta, spesa pubblica fuori controllo, un sistema fiscale che punisce chi lavora e premia chi aspetta. Da decenni sappiamo dove intervenire, ma non troviamo mai il bisturi.
È su questo terreno che torna in gioco la spending review, quella vera, non l’esercizio di maquillage che si ripete da dieci anni a colpi di slide. Il governo dovrà perciò mettere mano al cuore della spesa pubblica: enti inutili, sovrapposizioni amministrative, incentivi duplicati, 120 miliardi di trasferimenti a pioggia. Il welfare non si smantella, si razionalizza. Si può tagliare senza togliere, basta eliminare ciò che nel tempo è diventata pura rendita di posizione. Ed è un atto dovuto, perché la spesa pubblica italiana è oggi sei punti di Pil più alta rispetto alla metà degli anni ’90, ma i servizi non sono migliorati. È questo il paradosso. L’Italia non ha un problema di risorse, ma di allocazione. Finché non si colpirà l’inefficienza, ogni riduzione fiscale resterà effimera, ogni riforma zoppa: il taglio dell’Irpef è un gesto coerente, ma ancora insufficiente. Alleggerire il lavoro e le imprese è possibile solo se si riduce stabilmente la spesa. Altrimenti, ogni sgravio diventa l’anticamera di nuove tasse.
Leggi anche:
Patuelli (Abi) al governo: “Le banche meritano più rispetto”
Orsini: “In manovra servono misure poderose”
A proposito di tasse, il capitolo banche merita chiarezza. Con un capolavoro di creatività, Veronica De Romanis l’ha battezzata «tassa sulla stabilità», così esaltando un concetto paradossale: tassare la solidità per premiare l’equilibrio dei conti. Il governo ha scelto di chiedere un contributo straordinario a un settore che, da quattro anni, registra utili record. È comprensibile, noi per primi abbiamo condiviso questa scelta, pur sollecitando l’una tantum secca, senza tanti fronzoli, e in pieno accordo con le banche. Ma andrebbe anche ricordato che tra il 2012 e il 2016 quelle stesse banche hanno perso oltre 70 miliardi e smaltito 300 miliardi di crediti inesigibili (lo raccontiamo all’interno nel servizio di Nautilus), sostenendo senza aiuti dello Stato il prezzo della più grave crisi finanziaria della storia repubblicana. Sicché, chiedere un sacrificio temporaneo è legittimo; trasformarlo in un rituale politico, decisamente no. Soprattutto se, come è accaduto, si sente un vicepremier minacciare di alzare l’aliquota «a sei o sette miliardi» se gli istituti non si mostrano abbastanza riconoscenti. È un linguaggio che appartiene ai talk show, non all’economia di governo. Il profitto non è un peccato da espiare, è la condizione della stabilità stessa. E la stabilità non si tassa: si difende, con regole certe e non con proclami elettorali.
Questa volta le banche hanno accettato (a denti stretti) in silenzio, le imprese si sono adeguate, i sindacati hanno sospeso il giudizio. Non perché tutti credano nell’austerità, ma perché tutti hanno capito che Giorgia Meloni è qui per restare. È la legge della politica: quando non c’è alternativa, si coopera (più o meno esplicitamente). Ma la cooperazione non può sostituire la visione.
L’Italia ha rimesso in ordine i conti, e questo è già molto. Ma se ora non userà questa credibilità per liberare energie produttive, la stabilità rischierà di diventare un monumento all’immobilismo. Servono riforme, non ringraziamenti. E serve coraggio, perché la prudenza, da sola, non fa crescere nessuno. E proprio qui si apre il nodo politico. La prossima manovra cadrà nell’anno delle elezioni. È il momento in cui, di norma, la disciplina lascia il posto alla generosità e il rigore alle promesse. Ma sarebbe un errore sprecare il dividendo di credibilità guadagnato oggi per comprare consenso domani. Si può essere rigorosi e allo stesso tempo espansivi, se si sposta la spesa dal passato al futuro: meno sussidi e più investimenti, meno bonus e più produttività. L’occasione è irripetibile. Con i conti in ordine e un debito finalmente sotto controllo, l’Italia può permettersi di crescere senza sbandare. A patto che la politica resista alla tentazione di tornare al “vecchio mestiere” del consenso a debito. È possibile fare l’una cosa e l’altra: mantenere il rigore e finanziare la crescita. Serve metodo, non magia. E serve la volontà di governare il tempo elettorale come un alleato, non come un alibi.
La stabilità è stata conquistata. Ora deve diventare movimento.
© Riproduzione riservata