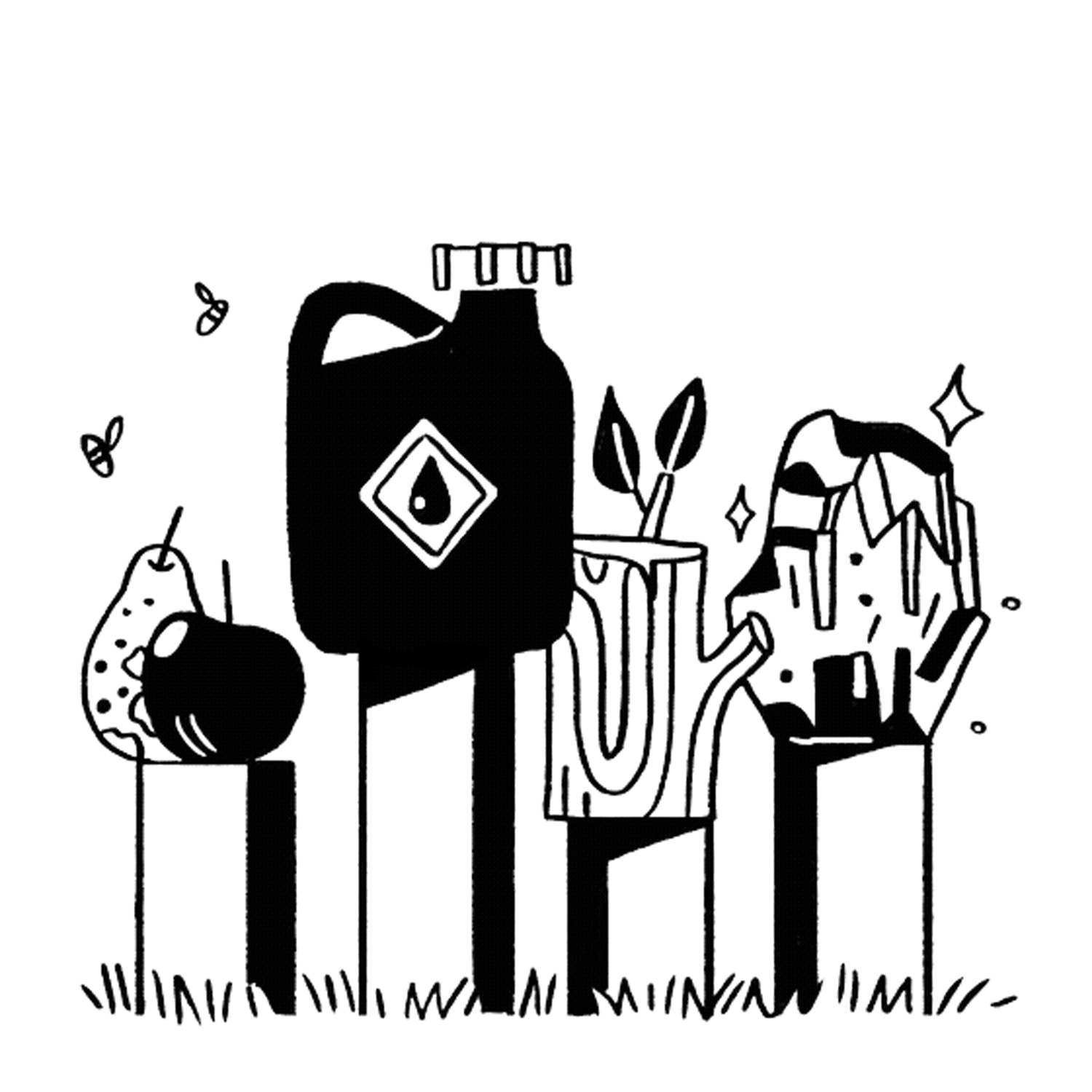In un mondo che vive ormai di shock continui — guerre, scontri commerciali, crisi energetiche, tensioni valutarie — l’Italia si scopre più solida di quanto molti si aspettassero. Mentre altri Paesi europei faticano a contenere l’inflazione e a gestire i bilanci pubblici, Roma ha riportato ordine nei conti, centrando obiettivi che tre anni fa sembravano irraggiungibili. Non è il caso di sventolare gonfaloni, perché le ricadute sono sempre possibili, ma non v’è dubbio che il governo Meloni, pur tra scosse politiche e vincoli esterni, abbia imboccato la via della disciplina. Soprattutto, è tornata una certa coerenza nella politica economica: meno bonus e più scelte strutturali, meno improvvisazioni e più programmazione.
Il saggio
Eppure, come osservano Paolo Balduzzi e Andrea Bignami, la disciplina da sola non basta. Nel loro illuminante saggio «Il prezzo della guerra», i due economisti partono da una constatazione semplice e terribile: ogni conflitto è una gigantesca macchina di riallocazione delle risorse. Non solo soldati e armamenti, ma capitali, tecnologie, priorità industriali, perfino abitudini di consumo vengono riscritte dallo stato di emergenza permanente che le crisi internazionali impongono.
Oggi l’Italia si trova nel cuore di questa trasformazione che si comincia a percepire. Le guerre non si combattono sui nostri confini, ma ne subiamo pienamente i contraccolpi: prezzi dell’energia mai così instabili, inflazione che riemerge, debito pubblico da gestire con mano ferma, e un’industria che deve scegliere se restare manifattura tradizionale o farsi difesa, cyber, energia, chip. Balduzzi e Bignami mostrano come ogni guerra moderna produca un doppio effetto: distrugge ricchezza nel breve periodo, ma nel lungo la ricrea, spesso altrove e con nuovi vincitori. Nell’ambito di questa prospettiva, l’Italia, pur non essendo protagonista militare, rischia di restare schiacciata nel ruolo di spettatore-pagatore. Importiamo l’energia, compriamo buona parte delle tecnologie di difesa, sacrifichiamo la crescita per sostenere famiglie e lavoro, ma non partecipiamo al disegno strategico che ridisegna le catene globali del valore. Dopo l’Ucraina, abbiamo riscoperto il valore della parola “sicurezza”. Ma sicurezza oggi significa anche disponibilità di materie prime, semiconduttori, approvvigionamenti certi. Chi controlla questi snodi detta le nuove regole del gioco. E qui l’Italia arriva con un handicap cronico: un debito vicino al 140% del Pil, una produttività ferma che la Banca d’Italia non cessa di stigmatizzare e una burocrazia cronicizzata che rallenta la riconversione industriale.
La lezione
La lezione della storia è chiara. Dopo ogni conflitto — dalle guerre puniche al secondo dopoguerra — chi ha saputo trasformare l’urgenza in innovazione è rinato più forte. Gli altri hanno pagato la ricostruzione senza beneficiarne. Oggi la sfida è la stessa: non farsi trovare impreparati davanti alla mobilitazione economica che i conflitti moderni impongono. La corsa al riarmo, i piani per la difesa europea, la richiesta di filiere sovrane non sono dettagli tecnici, ma scelte che toccheranno le nostre tasche. Ogni miliardo destinato alla sicurezza è un miliardo in meno per sanità, scuola o welfare, a meno che non si riesca a trasformarlo in investimento produttivo. Ecco perché la politica economica non può più limitarsi a gestire il ciclo di bilancio: deve scegliere un modello di sviluppo coerente con il mondo che cambia.
Emblematico, in questo senso, il verdetto della Corte dei conti sul Ponte sullo Stretto di Messina: una bocciatura che va nella direzione opposta rispetto a quella che servirebbe a un Paese deciso a dotarsi di infrastrutture strategiche. Se il nuovo paradigma globale impone sicurezza, connessioni e resilienza, l’Italia continua a farsi frenare da vizi procedurali e da una burocrazia che fa del controllo merce di scambio. Il rischio è che, mentre il mondo costruisce ponti — materiali e tecnologici — noi restiamo fermi a discutere se sia lecito provarci.
Leggi anche:
Il vero prezzo della guerra, avvertono Balduzzi e Bignami, è la perdita di prevedibilità. L’inflazione non è più un incidente, ma una condizione strutturale. Le catene di approvvigionamento per lungo tempo non torneranno lineari. Le politiche fiscali dovranno convivere con una spesa per la difesa crescente e con l’urgenza di non soffocare la crescita. Per l’Italia la sfida è doppia. Paghiamo la dipendenza energetica e quella tecnologica, e al tempo stesso siamo vincolati da regole di bilancio europee pensate per un mondo di pace e di stabilità. È un paradosso: un Paese che non fa la guerra, ma ne sopporta la contabilità.
C’è tuttavia un margine d’azione, ed è quello che il libro di Balduzzi e Bignami invita a cogliere: investire nella capacità di adattamento. Ecco la vera questione per l’Italia: non quanto spendere, ma dove spendere. Se la riconversione verso una “economia di sicurezza” sarà l’occasione per rinnovare ricerca, energia, logistica, digitale, potremo uscire più forti. Se invece sarà solo un esercizio di spesa pubblica senza strategia, allora il prezzo della guerra lo pagheremo due volte: una sui mercati, l’altra nella perdita di fiducia del Paese nel suo futuro.
Nel nuovo disordine globale, il costo più alto non è quello che si misura in miliardi, ma quello che si paga in miopia. E questa, a differenza della guerra, non conosce tregua.
© Riproduzione riservata