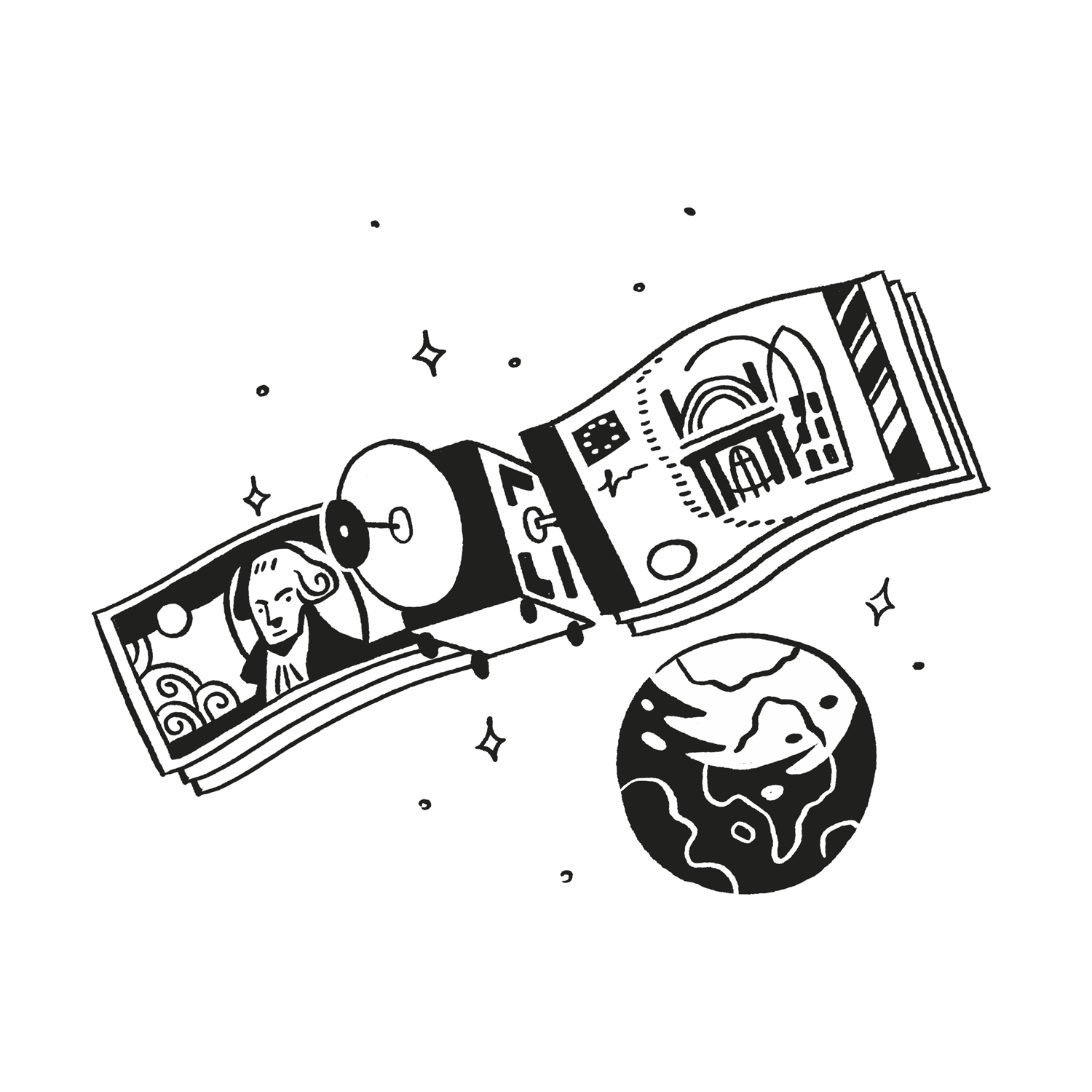Alert bollette. Meno eolico, gas più caro e CO2 in rialzo hanno aumentato la percezione del rischio sul mercato. I prezzi dell’elettricità in Germania sono balzati oltre i 90 euro a megawattora (€/MWh) a ottobre, dopo aver oscillato per mesi nella fascia 70-80 €/MWh tra primavera ed estate. Anche in Italia il contratto di novembre è passato da 105 a 111 €/MWh. Un movimento che ha acceso un allarme tra gli esperti e che avrà ricadute sui prezzi. «Questo movimento è dovuto principalmente a due fattori ben documentati: una minore produzione rinnovabile in Germania (soprattutto eolico) e l’aumento del prezzo del gas naturale in Europa», racconta a Moneta Andrea Ronchi di CO2 Advisor spiegando che «questa riduzione del contributo rinnovabile ha spinto il sistema elettrico tedesco a utilizzare più centrali a gas e a carbone, che hanno costi marginali più elevati e richiedono l’acquisto di permessi di emissione di CO2 per gli obblighi di compliance Eu-Ets (Emission Trading Scheme Europeo)». Parallelamente, il prezzo del gas Ttf olandese – principale riferimento europeo – è salito dai 25-27 €/MWh di agosto-settembre a circa 35-38 €/MWh a ottobre. A influenzare il rialzo sono stati l’avvio dei riscaldamenti, una domanda più alta di gas per la generazione elettrica e l’incertezza legata alle decisioni europee di azzerare le residue importazioni di gas russo, che ha aumentato la percezione di rischio sul mercato.
Combinazione
«Come se non bastasse, anche il prezzo dei permessi di emissione di CO2 (Eua) è cresciuto da circa 70 a 78 euro per tonnellata nello stesso periodo, proprio a causa dell’aumento della generazione termoelettrica che ha fatto aumentare la domanda dei permessi di emissione. La combinazione di questi elementi», secondo Ronchi (meno vento, gas più caro e CO2 in rialzo), «spiega bene il rialzo all’insù del prezzo elettrico tedesco».
In Italia
In Italia, il meccanismo è simile ma meno intenso: «Il sistema elettrico resta fortemente dipendente dal gas, che copre oltre metà della produzione, e quindi risente soprattutto dell’aumento del Ttf e del normale premio stagionale autunnale oltre che dell’aumento dei prezzi dei permessi di emissione, anche se avendo meno carbone l’incidenza di questo ultimo fattore è più bassa che in Germania», chiarisce Ronchi. Quindi, il prezzo della CO2 ha un ruolo importante, ma non è l’unico fattore che spinge i prezzi elettrici. Nel sistema Ets (Emission Trading Scheme) europeo, ogni centrale a gas o a carbone deve acquistare permessi di emissione (Eua – Emission Unit Allowances) per compensare la CO2 generata. Con il prezzo dei permessi di emissione (Eua) salito in questi giorni intorno ai 78 euro per tonnellata, il costo Ets per una centrale a gas è di circa 30 €/MWh, e per una a carbone può superare 70 €/MWh. «Tuttavia, non tutte le ore di mercato sono determinate da queste centrali, e nei momenti in cui prevalgono le rinnovabili o l’import, l’effetto si attenua. In media, ogni aumento di 10 euro nel prezzo della CO2 comporta un incremento di 3-5 euro per MWh nel prezzo dell’elettricità. In questa fase, quindi, la CO2 non è la causa principale del recente rialzo, ma fattore amplificante. È un meccanismo circolare: più gas e carbone entrano in rete, più CO2 si emette, più salgono le quote, più cresce il prezzo dell’elettricità».
L’aumento dei prezzi all’ingrosso si rifletterà solo in parte sulle bollette, e con qualche mese di ritardo. «Nel breve periodo il mercato resta volatile: l’avvio della stagione invernale, i prezzi del gas e il meteo continueranno a pesare. Rispetto alla crisi del 2022 siamo però in una situazione più stabile, con stoccaggi pieni e domanda più bassa», spiega l’esperto. Tuttavia, «nel medio termine i prezzi tenderanno a normalizzarsi, ma resteranno più alti rispetto al passato, perché i costi della CO2 e della transizione energetica sono ormai strutturali».
Leggi anche:
Energia: Descalzi, l’Europa non ha un piano di sicurezza
Energia in cortocircuito per i consumi dell’IA. E l’incubo della bolla contagia il nucleare
Il Carbon Market Outlook, che CO2 Advisor ha realizzato insieme con l’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, mostra che nei suoi primi 25 anni l’Eu Ets ha funzionato: ha ridotto le emissioni dei settori coperti di quasi il 50% ed è stato lo strumento più efficiente e meno costoso della politica climatica europea. Ha dimostrato poi che un mercato ben disegnato può orientare imprese e investitori verso la decarbonizzazione, premiando chi innova invece di imporre obblighi uguali per tutti. «Ma oggi», avverte l’esperto, «il sistema sta deragliando. L’Ets, nato come meccanismo di mercato, sta diventando sempre più una carbon tax sotto mentite spoglie. Le quote gratuite per le imprese stanno scomparendo, le aste generano decine di miliardi di gettito e l’Europa e gli Stati membri li utilizzano spesso in modo poco mirato, finanziando tecnologie costose o sussidi inefficienti. Il rischio è che il sistema perda la sua funzione economica e diventi solo uno strumento di prelievo fiscale (per di più togliendo sovranità fiscale agli Stati e portando la gestione del gettito a livello centrale europeo, infrangendo i trattati comunitari)».
Un allarme doppio visto che «il nuovo Ets2, che dal 2027 estenderà il prezzo della CO2 ai carburanti per trasporti e riscaldamento domestico, oltre che a tutte le emissioni industriali non coperte da Ets1, amplifica ulteriormente questo rischio. Le nostre stime indicano aumenti medi delle bollette del riscaldamento del 20–30% in Europa occidentale e fino al 60–70% in quella orientale, dove è alta ancora l’incidenza del carbone o del teleriscaldamento fossile. Per i carburanti, l’effetto sarebbe equivalente a un rincaro di 0,60–0,80 euro al litro alla pompa. Conseguenze che potrebbero essere socialmente esplosive: basta ricordare che i gilet gialli in Francia nacquero da un aumento di appena 0,03 euro al litro legato alla proposta di carbon tax del 2018».
Il commissario
Le recenti dichiarazioni del commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, non lasciano spazio all’ottimismo: i correttivi (come la riserva di stabilità del mercato – Msr – o il Social Climate Fund, finanziato in gran parte proprio dai proventi delle aste Ets1 ed Ets2) non potranno mitigare realmente l’impatto della misura. «Siamo di fronte a un cambio di paradigma che rischia di compromettere il consenso sociale sulla transizione climatica e di indebolire la competitività industriale europea», denuncia Ronchi auspicando un «cambio di rotta» che riporti l’Ets1 alla sua natura originaria di mercato, riveda l’Ets2 prima che entri in vigore, e soprattutto riapra all’utilizzo dei crediti internazionali di CO2 nei meccanismi di compliance. L’Europa ha creato un sistema che ha funzionato. Ora», conclude, «deve evitare di trasformarlo in un meccanismo punitivo e inefficiente»
© Riproduzione riservata