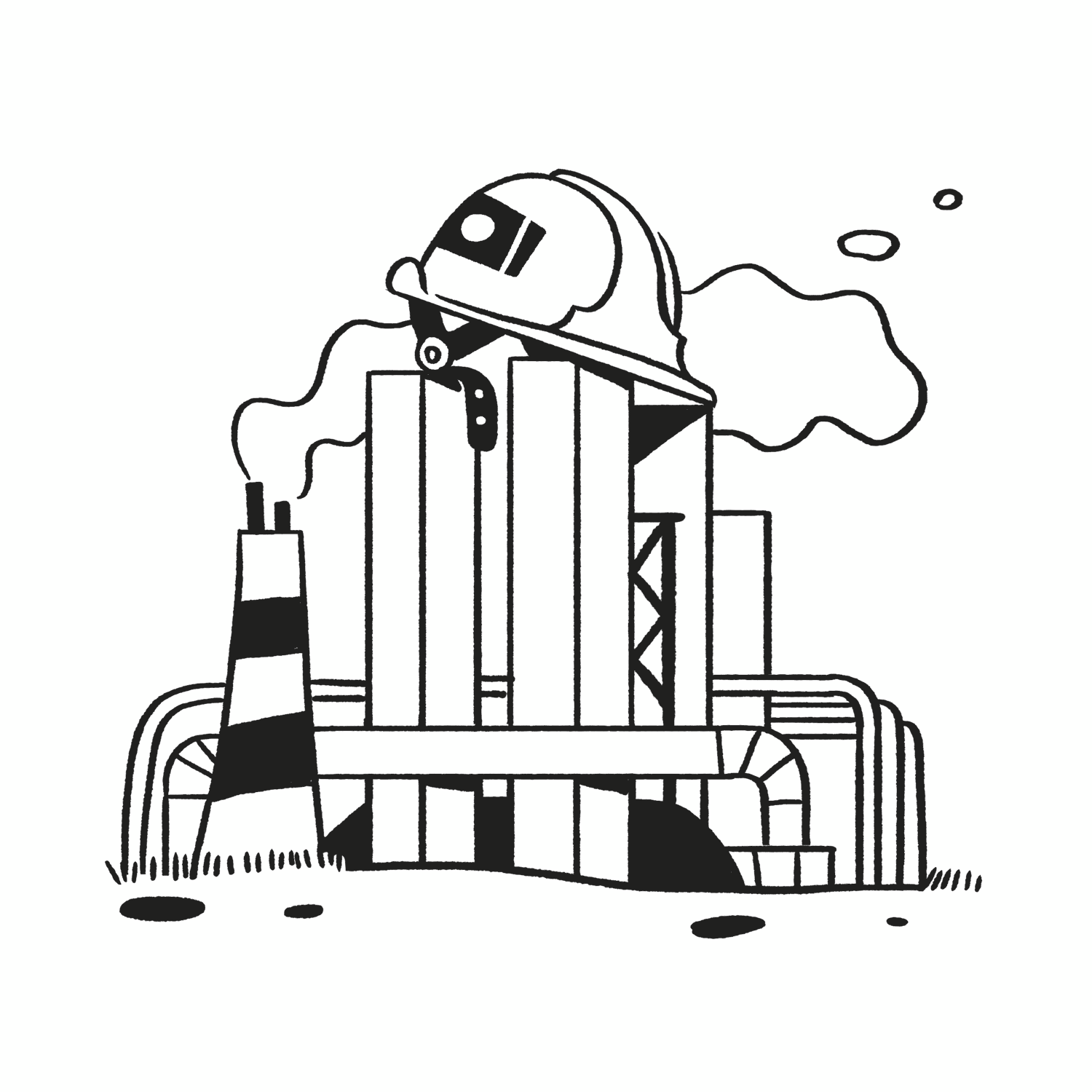C’è un numero che dovrebbe toglierci il sonno: 176 miliardi di euro. Tanto servirà entro il 2030 per tenere in piedi il nostro sistema di welfare, quel grande ombrello che da decenni ci ripara dalle intemperie della vita. Eppure, il Paese continua a comportarsi come se piovesse solo sugli altri. Il Rapporto 2025 del Think Tank “Welfare, Italia”, presentato di recente a Roma ad opera del Gruppo Unipol, fotografa una realtà che non è più allarme, ma emergenza strutturale. L’impegno per il welfare ha ormai raggiunto 669 miliardi, il 60% del totale della spesa pubblica. La previdenza da sola pesa per il 16% del Pil, più di qualunque altro grande Paese europeo. Ma sanità, istruzione e politiche sociali arrancano: spendiamo meno in prevenzione, in formazione e in inclusione di quanto servirebbe a garantire il futuro.
Il futuro, appunto. Quello che non costruiamo mai. Mentre in altri Paesi si investe in capitale umano — bambini, studenti, lavoratori, competenze — noi continuiamo a spendere quasi tutto per gestire il presente, o meglio, per amministrare il declino. Non è notizia di oggi che in Italia si nasce sempre meno (appena 370mila nati nel 2024 e il trend in caduta non vede fine), si studia troppo poco (solo il 31% dei giovani laureati contro il 44% della media Ue) e si fugge troppo (oltre 49mila laureati emigrati nel solo 2024). È come se il Paese avesse deciso di smontarsi lentamente, pezzo dopo pezzo, tra inerzie burocratiche e promesse politiche evaporate. A ciò si aggiunge un welfare che distribuisce, ma non genera. Abbiamo costruito un sistema che premia l’età e penalizza il talento. I giovani, i lavoratori precari, le donne – quelli che dovrebbero sostenere il peso delle pensioni future – si trovano davanti a porte chiuse, carriere in salita, stipendi indegni e zero incentivi.
Vero è che qualcosa si sta muovendo da quando il governo Meloni si è insediato, a cominciare dal riordino dei conti pubblici; ma ciò non basta a spegnere la sensazione che l’Italia sia in una fase di avvitamento, ostaggio di due malattie croniche: una diffusa miopia politica e una colpevole lentezza burocratica. La prima impedisce di pianificare oltre l’orizzonte di una legislatura, la seconda paralizza tutto ciò che somiglia a una riforma. È da vent’anni che si parla di “semplificazione” e “digitalizzazione del welfare”, ma ogni governo ricomincia da capo come se nulla fosse mai stato detto o scritto.
Intanto la popolazione invecchia, e con essa crescono le richieste al sistema sanitario, le pensioni da pagare, i servizi da garantire. Nel 2050 un italiano su tre avrà più di 65 anni. E chi pagherà i conti? Con quale forza lavoro, con quale produttività, con quali nuove entrate fiscali? La verità è che l’equilibrio tra welfare e forza attiva si sta spezzando. Ogni anno la base contributiva si restringe, mentre le prestazioni aumentano. È un circolo vizioso che né il buonismo delle parole né la retorica del “Paese solidale” potranno rompere. Servono scelte nette, impopolari, ma inevitabili: più natalità, più integrazione, più competenze, più lavoro.
E qui arriva l’altro tabù: l’integrazione degli immigrati. Mentre altri Paesi europei li formano, li inseriscono e li fanno contribuire, noi li lasciamo ai margini, intrappolati tra burocrazia, pregiudizi (a destra come a sinistra) e lavori grigi. È una miopia doppia: morale ed economica. Senza una vera politica migratoria – non di emergenza, ma di strategia – il sistema non reggerà. Possiamo parlare di sovranità, ma la verità è che, senza nuovi contribuenti, il nostro welfare non è sovrano di nulla. Il Rapporto 2025 lo dice chiaramente: se l’Italia riuscisse solo ad allinearsi ai parametri europei su occupazione giovanile, femminile e straniera, si genererebbero 2,8 milioni di nuovi occupati e fino a 226 miliardi di Pil aggiuntivo. Non fantascienza, ma semplice buon senso. Solo che il buon senso, in Italia, è sempre un’eresia amministrativa.
Il welfare, in fondo, non è una voce di bilancio: è un patto sociale. Ma un patto si regge solo se le parti si fidano l’una dell’altra. Oggi, invece, i cittadini non si fidano dello Stato, lo Stato non si fida dei cittadini, e la politica non si fida della realtà. Si parla di “riforme strutturali” come se fossero un optional, mentre il Paese si svuota di giovani, di energie, di prospettive. La prevenzione? Solo il 5,6% della spesa sanitaria. L’istruzione? In calo sul Pil. Il capitale umano? Un’espressione da convegno. Così la montagna del debito la si contiene solo a fatica, e con essa cresce il paradosso: spendiamo sempre di più per difendere un modello che si sta sgretolando. Sicché, in assenza di coraggio politico, continueremo a finanziare la nostalgia.
L’Italia ha bisogno di un salto culturale, prima ancora che economico. Ha bisogno di capire che ogni euro speso in istruzione o prevenzione vale più di dieci spesi per curare o riparare. Ha bisogno di capire che un Paese che non investe sui propri figli – naturali o adottivi, italiani o stranieri che siano – non ha diritto di parlare di sostenibilità sociale. E allora, smettiamola di raccontarci che non ci sono risorse. Le risorse non mancano: sono nella testa, nelle mani e nei sogni di chi oggi ha vent’anni e non crede più nella politica. Sta a noi, anzi a loro, decidere se restare o andarsene. Perché se non invertiamo la rotta, il 2030 non sarà una scadenza contabile, ma l’inizio del default sociale di un Paese che ha dimenticato la più elementare delle verità economiche: nessun welfare sopravvive senza il lavoro di chi viene dopo.
© Riproduzione riservata