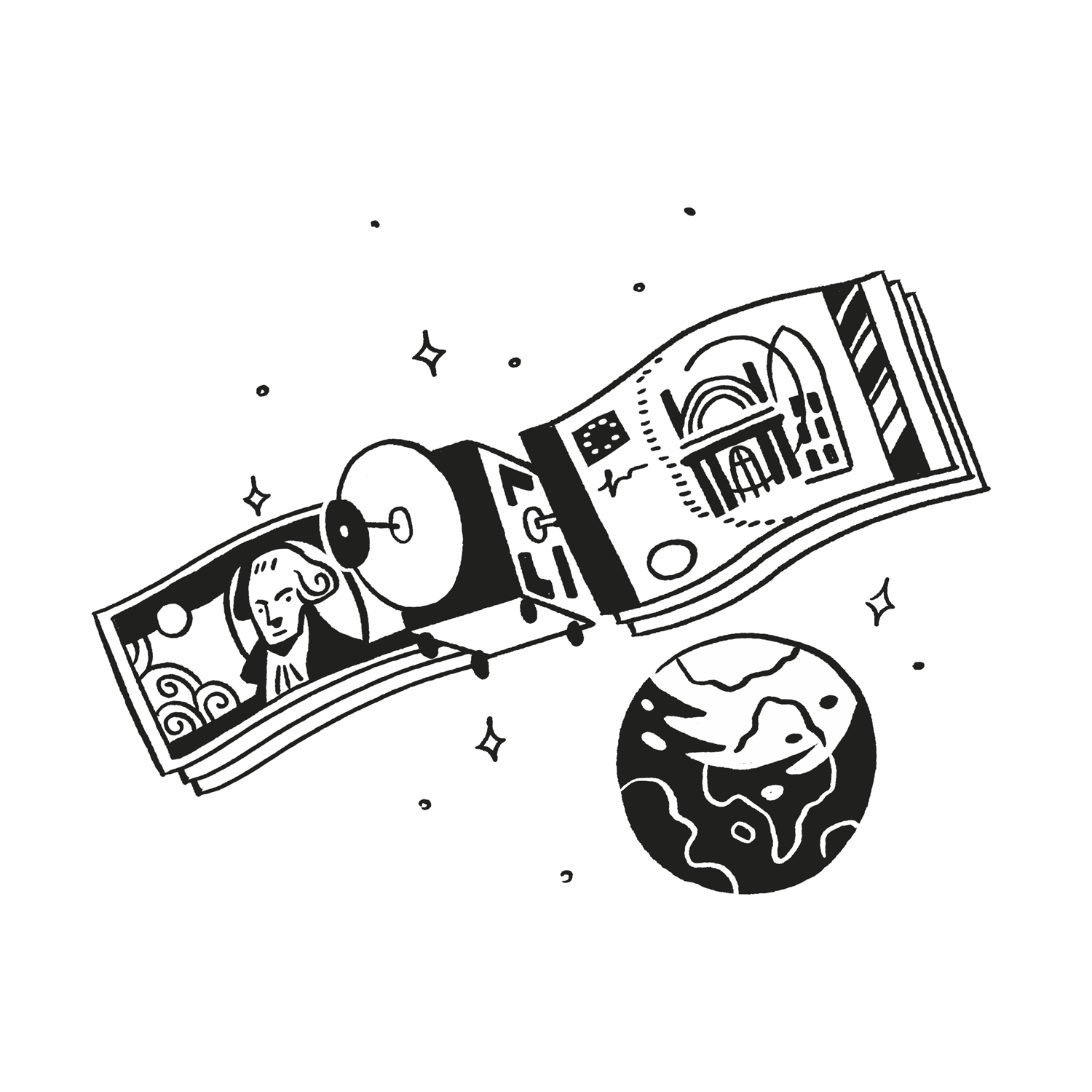La grande sfida globale si gioca sulle infrastrutture. Secondo un nuovo studio di Allianz Trade, colmare il divario infrastrutturale globale richiederà investimenti per oltre 10.500 miliardi di euro entro il 2035, pari al 3,5% del PIL mondiale ogni anno. Un obiettivo mastodontico, ma non più rinviabile. Di questi fondi, circa 7mila miliardi saranno assorbiti dai mercati emergenti, dove i bisogni primari — accesso all’energia, alla mobilità e alle reti digitali — restano ancora lontani dagli standard minimi. Tuttavia, anche l’Europa è chiamata a fare la sua parte. E il punto dolente è che, proprio nel cuore del continente industrializzato, il ritardo infrastrutturale non è solo un problema tecnico: è un limite alla competitività, alla sicurezza e alla transizione energetica.
Il prossimo 6 agosto, con l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, l’Italia proverà a rimettere in moto un simbolo. Ma non basta un cantiere a riscrivere un paradigma. Il nostro Paese deve affrontare una mole di investimenti infrastrutturali senza precedenti, con oltre 90 miliardi di euro necessari entro il 2035 solo per coprire strade, ferrovie, porti, reti idriche e telecomunicazioni. Un fabbisogno distribuito in modo non omogeneo: il Sud e i principali poli urbani sono le aree con il gap più profondo, mentre le connessioni logistiche tra Nord e Sud restano fragili, disomogenee, spesso obsolete.
Leggi anche: Via al Ponte sullo Stretto, ecco come sarà
Il dossier infrastrutture non energetiche è solo metà del quadro. C’è poi la partita energetica, che l’Europa non può più permettersi di rinviare. Per accelerare la decarbonizzazione, servono tra i 100 e i 137 miliardi di euro all’anno in Europa per ammodernare le reti elettriche, potenziare lo stoccaggio e rafforzare le interconnessioni. In totale, l’obiettivo comunitario fissa a 1.800 miliardi di euro il fabbisogno di infrastrutture energetiche entro il 2035. Il 70% di questa cifra dovrà essere impiegato su reti e sistemi di accumulo, i veri snodi critici della transizione.
Leggi anche: L’energia del futuro è decentralizzata: la lezione del blackout spagnolo
La Germania sarà il baricentro della nuova Europa energetica, con oltre 68 miliardi di euro destinati al solo stoccaggio a batteria. Ma anche l’Italia è centrale in questo scacchiere: secondo Allianz Trade, saranno necessari 17,5 miliardi di euro per potenziare lo stoccaggio e 6,3 miliardi per le interconnessioni. Proprio su questo fronte, l’iniziativa RePowerEU sta integrando e rafforzando il nostro PNRR, finanziando progetti per migliorare l’affidabilità e la resilienza della rete, modernizzare la trasmissione e accrescere la capacità di assorbire energia rinnovabile.
Tutto questo, però, rimane sulla carta se non si riesce a spendere in tempo e bene. Tra il 2021 e il 2024, l’Italia ha beneficiato di oltre 122 miliardi di euro dal programma Ngeu, ma ha speso effettivamente poco più di un terzo delle risorse disponibili. Il rischio, ormai concreto, è di perdere fino a 54 miliardi di euro se non verranno completati i progetti entro la scadenza di agosto 2026. Ostacoli burocratici, ritardi autorizzativi e inefficienze — soprattutto a livello locale — stanno frenando un piano che sulla carta potrebbe valere fino a un punto percentuale di PIL ogni anno. Il governo ha già rivisto il Pnrr per correggere la rotta, e ulteriori semplificazioni sono in trattativa con Bruxelles.
Di fronte a questo scenario, è sempre più evidente che il capitale privato sarà decisivo. Gli asset infrastrutturali privati hanno superato i 1.350 miliardi di euro nel 2024, guidati da investimenti in energia pulita, data center e mobilità sostenibile. I rendimenti attesi tra l’8% e il 10% rendono questa asset class una scelta strategica per i fondi pensione, le assicurazioni e i grandi investitori istituzionali.
© Riproduzione riservata