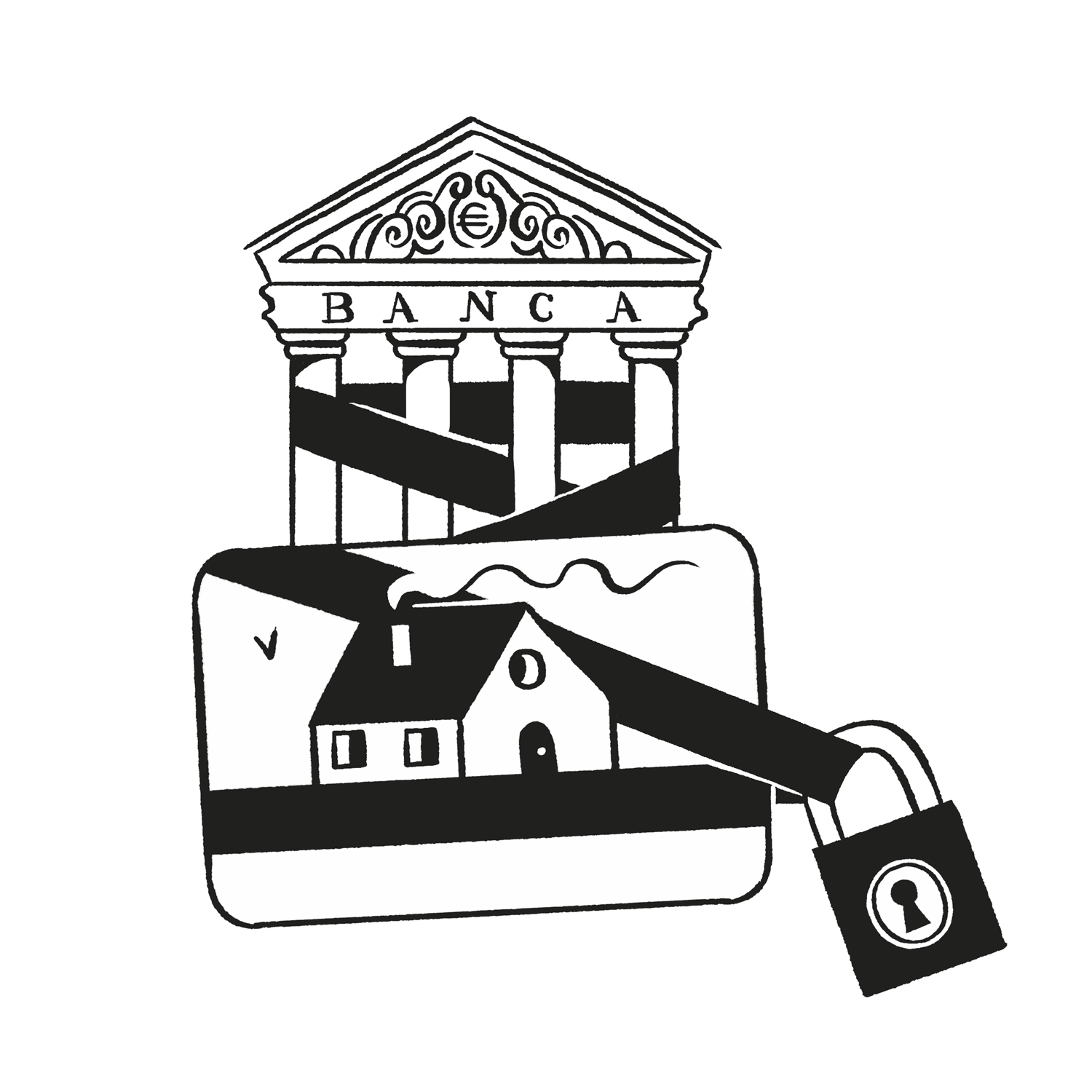Dopo diversi anni di assenza, Confindustria torna a dedicare un rapporto alla manifattura italiana, restituendo l’immagine di un settore che, pur frenato da una produttività debole, continua a sostenere l’economia nazionale grazie alla forza dell’export e al crescente peso delle imprese medio-grandi. Un comparto che rimane “un pilastro dell’economia nazionale e una componente essenziale della competitività del Paese” e che oggi sta attraversando un cambiamento strutturale più profondo di quanto spesso colto nel dibattito pubblico.
Il Centro Studi Confindustria, con una ricognizione articolata in quattro capitoli, descrive una manifattura che, nonostante shock economici, sanitari e geopolitici, ha saputo mantenere nel contesto globale un ruolo di primo piano: ottava al mondo, seconda in Europa, con una quota del 2,1% del valore aggiunto globale e del 13% di quello europeo. Il settore contribuisce al 15% del Pil – quota che raddoppia con l’indotto – e genera il 50% della spesa in Ricerca e Sviluppo. La sua elevata diversificazione resta un punto di forza distintivo, capace di “contribuire a rafforzarne la resilienza agli shock globali”. Le specializzazioni tradizionali – meccanica strumentale, prodotti in metallo, alimentare — continuano a pesare, mentre tessile, abbigliamento e pelletteria mantengono un “peso particolarmente elevato”.
Dinamica internazionale
Se l’Italia industriale resiste, però, è soprattutto grazie alla dinamica internazionale: l’export ha sostenuto il ciclo anche quando la domanda interna rallentava. Tra il 2015 e il 2024 le esportazioni sono cresciute del 2,4% l’anno, superando Francia e Germania e beneficiando dei “diffusi guadagni di qualità dei manufatti italiani”, con punte elevate nella farmaceutica e nei mezzi di trasporto. Una performance che ha compensato il limite strutturale della produttività: la “bassa dinamica della produttività rappresenta una delle principali criticità” e tre decenni di crescita modesta rispetto ai partner europei continuano a pesare sulla competitività complessiva. Lo shock energetico ha colpito l’Italia “più severamente rispetto ad altri Paesi europei”, mentre il fenomeno del labour hoarding (la conservazione della forza lavoro anche in caso di cali di produzione; ndr) ha “meccanicamente determinato un calo della produttività del lavoro” nel 2023-2024.
Leggi anche:
Scatto dell’export, +24% negli Usa. Tajani: “Obiettivo 700 miliardi raggiungibile”
Vino, Italia regina dell’export. Trainano le bollicine
Ma il dato forse più rilevante riguarda la trasformazione della struttura dimensionale del sistema produttivo. La manifattura resta “ancora orientata verso le piccole e micro imprese”, ma nell’ultimo decennio il loro numero è sceso di quasi il 12%. Parallelamente, è aumentata la dimensione media delle aziende maggiori: un cambio di passo che il rapporto definisce “una trasformazione qualitativa significativa”. Non si tratta di un ridimensionamento delle Pmi nel complesso – tra cui restano numerosi campioni, spesso a forte vocazione internazionale – ma di un riequilibrio che favorisce la crescita delle realtà medie e grandi. Un’evoluzione decisiva perché “l’efficienza cresce in modo significativo con la dimensione d’impresa” e proprio le imprese medio-grandi italiane mostrano livelli di produttività superiori alle omologhe francesi e tedesche.
Il sistema industriale ha inoltre rafforzato la propria solidità finanziaria: la quota di capitale proprio sul passivo ha raggiunto il 48,9%, colmando il ritardo rispetto ai concorrenti europei. Una robustezza che conta, considerando che “l’allentamento dei vincoli finanziari è associato ad un aumento della produttività compreso tra il 5% e il 10% in media”.
Leggi anche:
Pace fatta in Confindustria sull’energia
Export italiano di ortofrutta fresca in crescita nel primo semestre
Sul fronte degli investimenti, l’Italia mantiene una propensione elevata, intorno al 25% del valore aggiunto. Restano però due criticità: la distanza dagli altri Paesi negli investimenti immateriali – che “rimane sensibilmente inferiore a quella osservata in Germania e Francia” – e le esposizioni geopolitiche legate alle forniture dalla Cina, soprattutto per semilavorati elettronici e apparecchiature elettriche, nonostante un generale calo delle dipendenze critiche negli ultimi otto anni grazie alla diversificazione energetica.
La competitività futura dipenderà dal mercato del lavoro e dalla capacità di affrontare il declino demografico puntando su “infrastrutture sociali come asili nido e servizi di cura” e sulla diffusione di “buone pratiche manageriali” per accelerare l’adozione delle tecnologie digitali. Sul fronte della politica industriale, Confindustria sottolinea che gli interventi funzionano meglio quando prevalgono “criteri di allocazione oggettivi” rispetto alla discrezionalità politica.
Analisi congiunturale
Infine, l’analisi congiunturale mostra un quadro a macchia di leopardo. Dopo il calo del 2023-2024, che ha “vanificato il rimbalzo del 2021-2022”, il 2025 si è aperto oltre le attese, salvo registrare un nuovo rallentamento nel terzo trimestre. Le imprese indicano i costi dell’energia e l’incertezza geopolitica come principali ostacoli, ma segnalano nella “qualità dei prodotti, nell’elevata specializzazione e nelle competenze tecniche consolidate” i propri vantaggi competitivi. La transizione verde resta “un elemento ambivalente”, capace di offrire opportunità ma anche nuove pressioni concorrenziali.
© Riproduzione riservata