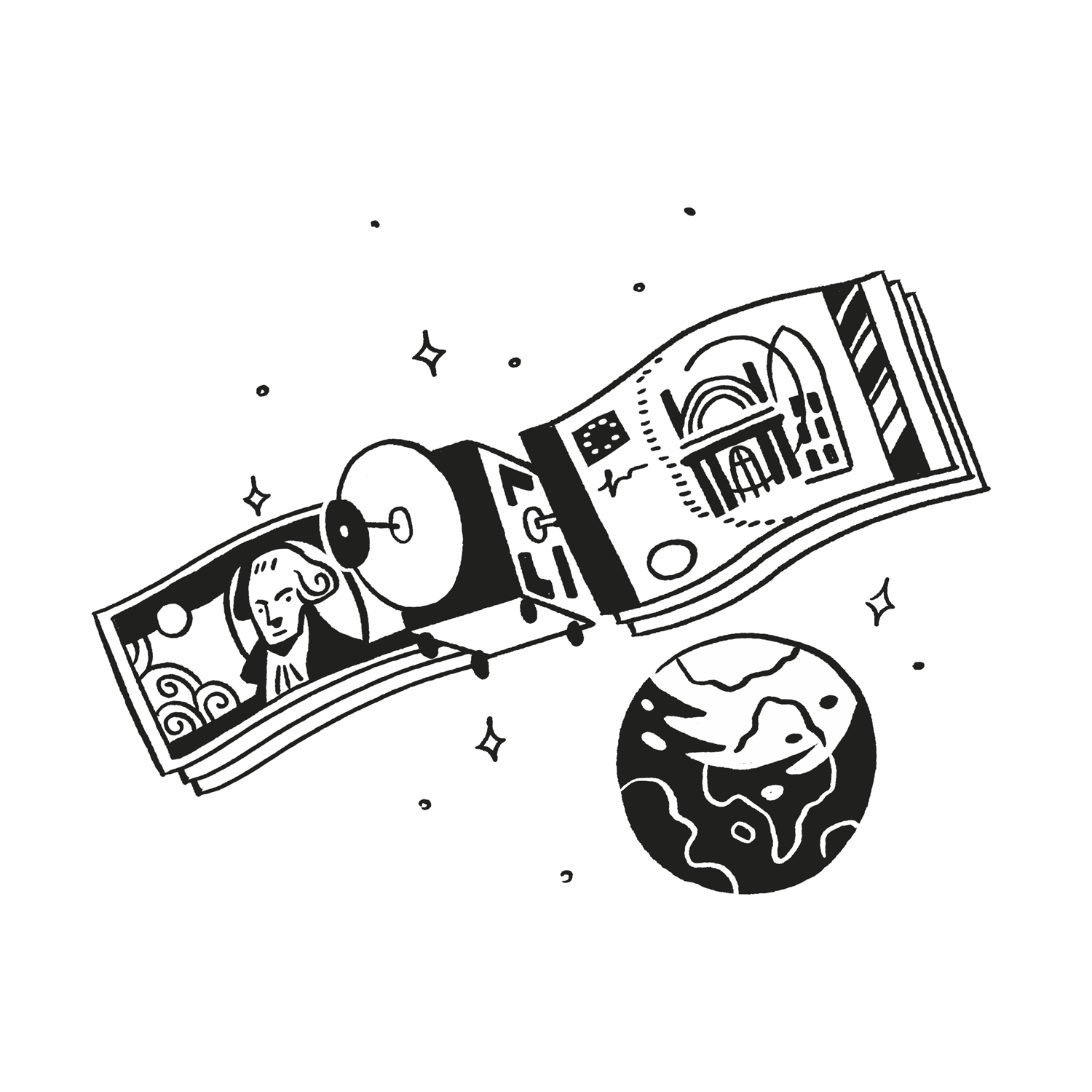Il gruppo franco indiano ArcelorMittal Steel, player privato selezionato nel 2018 dal governo Conte per la guida dell’ex Ilva prima che si arrivasse all’amministrazione straordinaria, ha fatto causa all’Italia intentando una lite miliardaria il cui esito, totalmente indefinito, potrebbe pesare per anni e come un macigno sulla storia del siderurgico e sul Paese.
Nelle 56 pagine della causa che Moneta ha potuto visionare si spiega che l’affondo – rimasto finora celato – risale addirittura al 17 gennaio quando Arcelor ha inviato una prima notifica di controversia per una risoluzione amichevole. Nei tre mesi di tempo previsti nulla è successo e Arcelor ha quindi avviato un arbitrato (datato 24 giugno 2025) ai sensi dell’Articolo 36 della Convenzione sullo Spazio di Trattamento delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e Partecipanti di Altri Stati (“ICSID”). Una lite che, secondo il documento, «nasce da una serie di misure dannose implementate dall’Italia che violerebbero il trattato internazionale ECT (l’Energy Charter Treaty). Non solo, l’Italia è accusata di aver assunto decisioni che sarebbero state «arbitrarie, discriminatorie, sleali e sproporzionate, nonché contrarie alle legittime aspettative di Arcelor, causando un danno grave all’investimento dell’azienda in Italia e influendo negativamente sui suoi interessi più ampi in Europa».
A seguito di queste presunte violazioni Arcelor sostiene di aver perso il proprio investimento in Italia, subendo danni superiori a 1,8 miliardi. Attenzione, non si tratta però della richiesta di risarcimento di Arcelor, ma solo di una base da cui partire. Nella contestazione la società precisa, infatti, di lasciare come discrezionale, in base all’andamento della causa, la pretesa risarcitoria. Oltre al danno, anche la beffa, si potrebbe commentare conoscendo le vicende che negli ultimi anni hanno interessato l’ex Ilva e l’amministrazione Arcelor. Resta il fatto che – quando si passa sul piano legale – l’unica cosa che conta sono le carte, gli accordi e le responsabilità comprovabili.
Un quadro che fa tremare l’Italia, in particolare, alla luce di un dettaglio: i patti parasociali riscritti e orchestrati nel 2020 con il Conte2 per ricomporre la rottura con Arcelor dopo la scelta di abolire lo scudo penale sono praticamente secretati. E potrebbero fare la differenza. Tornando alla causa, nelle pagine dell’arbitrato l’azienda franco-indiana si presenta dettagliatamente come grande player mondiale, tra le principali aziende di acciaio e miniere, con oltre 125.000 dipendenti in tutto il mondo, clienti in 129 paesi e impianti di produzione in 15 Paesi. Si spiega, inoltre, che i suoi prodotti sono impiegati in vari settori, recita il documento in cui segue un lungo elenco di società operative. Insomma, la litigante – si capisce – vuole presentarsi come player affidabile.
Il provvedimento è indirizzato da Pinsent Masons – studio legale internazionale con sede a Londra, tra i primi cento studi legali al mondo per fatturato – al ministero dell’Economia, delle Imprese, degli Esteri, alla presidenza del Consiglio e all’Avvocatura generale dello Stato. La ricostruzione dei fatti chiama in causa diversi aspetti della lunga storia del gruppo a Taranto e, in particolare, il fatto che «per ottenere l’approvazione della transazione Ilva da parte della Commissione Europea ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni Ue, al gruppo è stato richiesto di effettuare (cosa che ha fatto) cessioni significative, tra cui lo stabilimento di Piombino, il suo principale impianto di acciaio zincato in Italia, e altri siti integrati di produzione siderurgica in Europa».
Al Governo Conte di allora, giugno 2018, si contesta poi di aver tentato, senza successo, di procedere all’annullamento del decreto che aveva attribuito i beni Ilva ad AM InvestCo. Non basta «in un cambio fondamentale del quadro giuridico e normativo, con la Legge n. 128 del 2 novembre 2019 (“legge 2019”), il Parlamento italiano ha eliminato la protezione legale da responsabilità penale o amministrativa relativa alle operazioni di Ilva», il cosiddetto scudo penale, che «era una condizione inclusa nell’offerta di AM InvestCo per l’acquisizione dei beni Ilva».
Ad aggravare la situazione, sempre secondo il grande accusatore, nel 2019 il Procuratore della Repubblica di Taranto ha anche ordinato la temporanea chiusura di una delle ferrate presso l’Impianto di Taranto per presunte violazioni dei precedenti Commissari Straordinari di Ilva. Nell’arco temporale 2020-2023 Invitalia e lo Stato italiano hanno fatto diverse assicurazioni all’azienda che ha accettato di estendere l’Ilva Agreement oltre la data di scadenza di maggio 2022. Ma in definitiva, secondo l’accusa, «né Invitalia né il Governo italiano hanno adempiuto alle loro promesse e impegni; invece, il Governo italiano ha adottato una serie di misure discutibili: il 5 gennaio 2023 ha emanato il Decreto 2023, che ha introdotto una modifica senza precedenti alle procedure di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria di società con azionista pubblico che detiene direttamente o indirettamente almeno il 30% delle azioni e che operano siti industriali di interesse strategico nazionale, mirata specificamente ad Acciaierie d’Italia.
Il Decreto 2023 ha inciso sui diritti del cda e del socio di maggioranza. Infine, ha impedito ad Acciaierie d’Italia (ADI) di perseguire procedure alternative. Il 20 febbraio 2024, Invitalia ha presentato una petizione al Mimit, che ha emanato un decreto per porre ADI in amministrazione straordinaria, togliendo – reclama Arcelor – «i diritti di azionista indiretto e ostacolando altre opzioni di ristrutturazione che Acciaierie d’Italia stava perseguendo». In conclusione, secondo Arcelor, l’Italia «avrebbe espropriato il suo investimento violando l’art. 13 ECT. E i decreti sopra citati «avrebbero alterato, drasticamente la governance rispetto alle norme consolidate, portando a una sorta di esproprio indiretto senza compensazione, con violazioni di trattamenti, procedura e finalità pubbliche».
© Riproduzione riservata