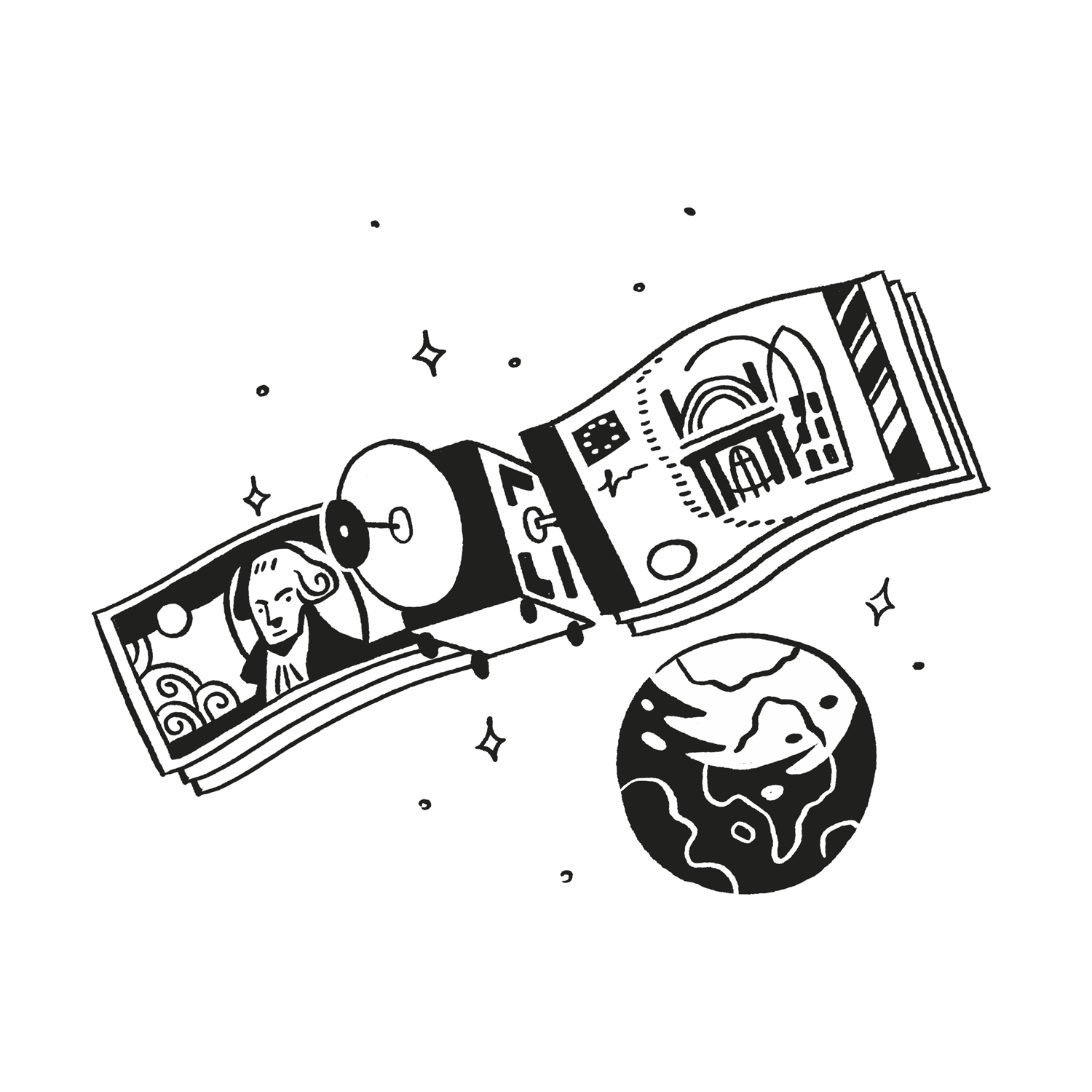Non solo fast fashion, tessile e moda soffrono di una crisi strutturale che ha molteplici ragioni. Motivazioni spesso lontane da quelle di grandi alert come i dazi o l’invasione dei prodotti asiatici. Moneta ha cercato di leggere nelle trame del settore per capire quali sono i problemi che oggi stanno pesando sul cuore produttivo del made in Italy che talvolta combatte e resiste, ma altre soccombe andando a chiudere i battenti e cancellando intere filiere storiche. Le difficoltà del settore tessile hanno portato a un calo della produzione e delle occupazioni in diverse aree, con un tasso di flessione del 6,1% nel 2024, secondo quanto riportato da Confindustria Moda.
Alcuni distretti come Prato e Biella sono in difficoltà, mentre altri, come Como, dimostrano una maggiore resilienza, sebbene registrino cali occupazionali. L’incremento dei fallimenti commerciali ha poi ulteriormente indebolito il mercato. Secondo i dati Cribis, l’1,4% di aziende cessate sono nel settore tessile e abbigliamento con la percentuale che sale del 4,5% nel confronto con le aziende attive.
Cosa ha generato questo cortocircuito? Dopo quella che è ormai considerata comunemente una bolla Covid, il boom del 2021-2022, la moda e tutta la filiera hanno dovuto fare i conti con una forte contrazione dei consumi generata dall’inflazione e dall’incertezza.
Il valore
Improvvisamente si è smesso di spendere e di farlo per beni di lusso non necessari. Un fatto che ha contratto i consumi e lasciato la produzione in stand-by a favore di produttori che in quella fase hanno potuto facilmente vincere sui nostri mercati con prezzi competitivi non zavorrati dai costi energetici esorbitanti e dall’incertezza legata ai conflitti in corso. Una tendenza che Stefania Lazzaroni di Altagamma ha definito un orientamento per il «value for money», piuttosto che per il «value for dreaming» più tipico dei mercati di Asia e America. Ben inteso, poi, chi aveva ancora capacità di spesa non si è messo improvvisamente a risparmiare, ma si è orientato altrove scegliendo di puntare il portafoglio ad altre «experience» che dopo il Covid sono diventate irrinunciabili: viaggi e hospitality in primis.
Paura
Un altro fattore da non trascurare è quello del lusso da nascondere. Come ha descritto bene Lorenzo Bertelli, direttore marketing di Prada, «la tensione sociale ha un peso non indifferente e preoccupante sulle dinamiche di mercato. La forbice sociale si amplia e al posto di accrescere la base della piramide del lusso la vediamo stringersi. Il lusso rischia di essere sempre più per pochi» e chi spende «ha sempre più la necessità di nasconderlo anche per non ingenerare invidie o per paura». Un fenomeno che taglia fuori una fetta di lusso che spesso ha migliaia di piccoli fornitori di eccellenza come quelli del settore tessile.
Invasione
Un altro fattore determinante è l’eccesso di produzione. Un fenomeno che spesso viene imputato al fast fashion che ha invaso i nostri mercati superando le reali esigenze e che va a braccetto anche con il netto aumento delle collezioni presentate al pubblico in un solo anno. Si tratta di un fenomeno dal grosso impatto sulle abitudini di consumo che ha reso in questi anni meno valoriale ed esclusivo il capo di moda in sé.
Un quadro di totale confusione messo in luce anche dalla ricerca di Deloitte Brand Connection – The Age of Meaningful Brands su un campione di oltre 7mila consumatori in sette Paesi (Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Giappone ed Emirati Arabi Uniti): il 45,7% degli intervistati dichiara di non sentirsi legato ad alcun brand e la propensione al brand switching è elevata, segnale che la fedeltà non può più essere data per scontata.
La brand rilevanza, infatti, non è un attributo statico, ma un capitale che deve essere continuamente alimentato. In particolare, i consumatori apprezzano i brand che semplificano la vita quotidiana (63,8%), che garantiscono qualità (63,6%) e che dimostrano autenticità e fedeltà ai propri valori (62,2%). In Europa, soprattutto, la connessione con i brand è prevalentemente funzionale e pragmatica: come driver di scelta prevalgono la rilevanza quotidiana (71,1%), l’autenticità (68,4%), la qualità (67,7%) e l’affidabilità (65,5%). In questo contesto è quindi più che mai essenziale capire il consumatore, ma anche risolvere la matassa che lega i produttori nel Belpaese. Una situazione di cui si è perso il controllo, ma la cui risoluzione vale moltissimo a livello economico. La moda pesa oltre 100 miliardi di euro di fatturato e contribuisce al 5% del Pil impiegando 1,2 milioni di addetti diretti e oltre 53mila imprese.
Il ministero
In merito, il Mimit sta definendo un pacchetto di nuove regole, che saranno «agganciate» al ddl Concorrenza e che riguardano la certificazione di sostenibilità per le filiere, l’estensione della responsabilità estesa del produttore (Epr) a chi vende prodotti dall’estero e la creazione di un registro pubblico di queste certificazioni.
Nel dettaglio, gli emendamenti presentati al ddl sulle Pmi affrontano il tema della legalità nella filiera della moda prevedendo un innovativo sistema di certificazione, su base volontaria, che, al fine di prevenire le violazioni in materia di tutela del lavoro, consente la tracciabilità dei contratti e delle lavorazioni dalla capofila sino ai subfornitori. L’elemento maggiormente innovativo e qualificante del sistema di certificazione è costituito dagli adempimenti richiesti con riguardo ai contratti stipulati lungo la filiera.
Presso il Mimit è istituito un registro nel quale sono annotate le certificazioni rilasciate. Le imprese capofila, inoltre, al momento della stipula dei contratti, dovranno quindi acquisire la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale, assicurando così trasparenza lungo tutta la catena produttiva. Poi il governo recepirà la direttiva Ue 2024/825 che si propone di rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi posti a tutela dei consumatori, contribuendo, al contempo, a un’economia circolare, pulita e verde. Infatti, è emerso come i consumatori siano esposti ai rischi di green claims ingannevoli (dichiarazioni che suggeriscono un ridotto impatto ambientale), del greenwashing (pratica ingannevole di aziende o istituzioni che presentano una falsa immagine ecologica attraverso la comunicazione) e delle pratiche di obsolescenza precoce, compromettendo la libertà di effettuare scelte di consumo consapevoli.
E mentre il governo pensa alla cornice generale, non mancano esempi e iniziative virtuose come quella della Rete di Impresa Innovation for Luxury (I4L) che sta dando vita a una rete aperta delle filiere manifatturiere del lusso, a partire dal distretto tessile-moda italiano, con progetti condivisi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. «Abbiamo scelto di trasformare la competizione in coopetizione: unire forze, esperienze e visioni per affrontare insieme le sfide che nessuno può più affrontare da solo», ha spiegato Francesco Gentili, tra i soci fondatori con la sua Gentili e Mosconi insieme a Fili di Innovazione, Isa Seta, Ostinelli Seta e Open Advisory.
© Riproduzione riservata