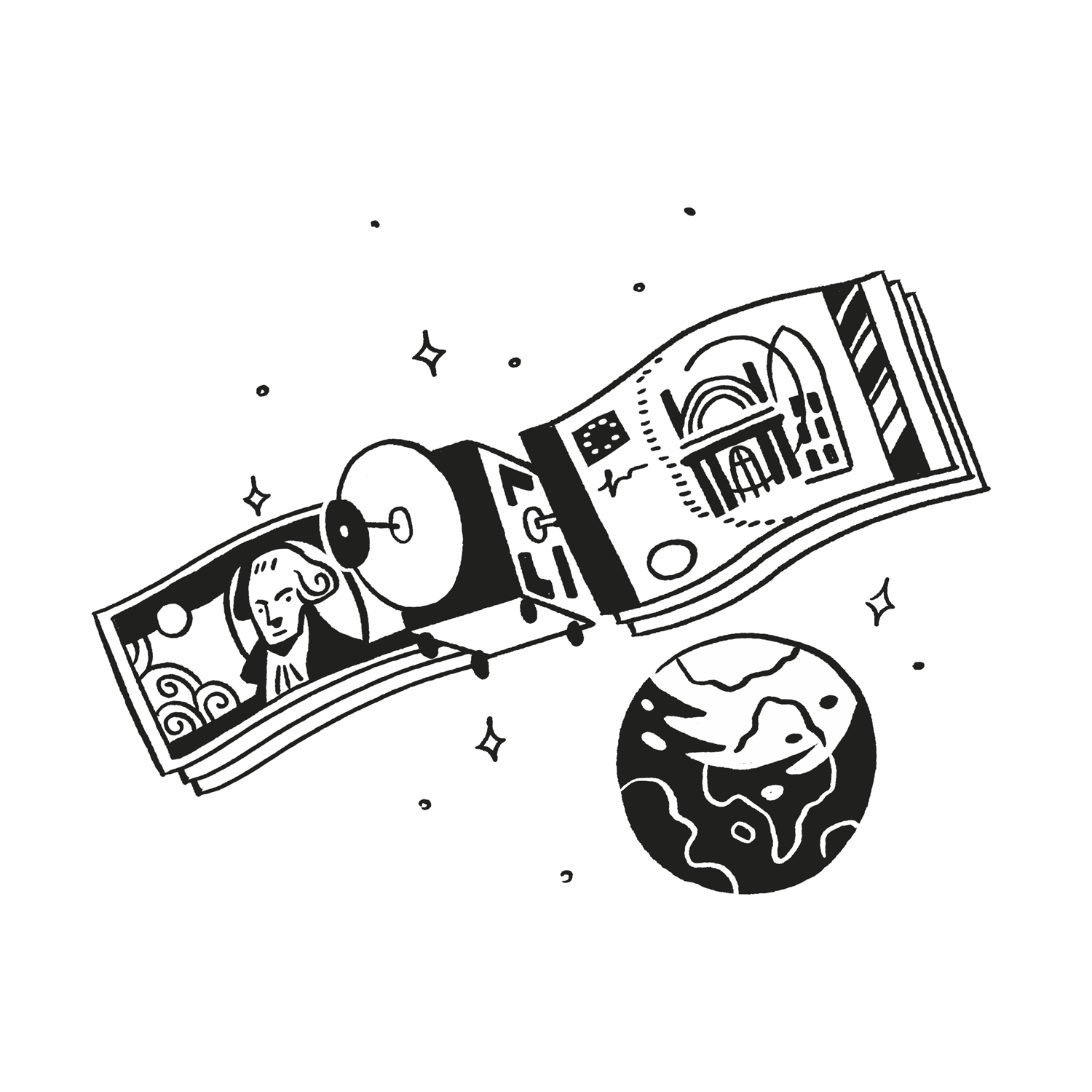In un’epoca in cui le mani battono veloci su tastiere e il tempo rincorre l’istantaneo, resiste un’arte lenta e sacra. In cui le dita non si affrettano, ma plasmano, ascoltano, scolpiscono per dare vita a un’opera unica: la campana. Un’attività, che da quasi mille anni continua tra le mura della Fonderia Marinelli, la più antica specializzata nell’arte campanaria e anche l’azienda artigiana a conduzione familiare più vecchia al mondo. Si trova in Italia, ad Agnone, Comune molisano in provincia di Isernia che oggi sfiora i 5.000 abitanti. Lì, mani sapienti non hanno smesso di lavorare l’argilla, né di parlare con il bronzo. Lì, un patrimonio vivente ha attraversato i secoli con la bellezza del gesto e la pazienza nell’anima.
«Lavoriamo come mille anni fa, con le stesse tecniche e gli stessi materiali. Non è cambiato niente», assicura Armando Marinelli, che insieme al fratello Pasquale rappresenta la 26esima generazione di questa dinastia di fonditori. È un’affermazione che oggi suona rivoluzionaria, quasi romantica. Nessuna macchina, nessun algoritmo, nessuna stampante 3D. Solo mani umane, che seguono tecniche antiche e gesti tramandati. L’arte campanaria, qui, è rimasta intatta, insieme alla passione e alla professionalità cui ci si dedica da secoli. Qui, la tecnologia è rimasta fuori dal laboratorio senza tempo e non ha accelerato il ciclo di lavorazione che può variare da 3-4 mesi fino anche 1 anno e mezzo per campane molto grandi. Un tempo lungo, fatto di gestazione e di attesa.
Per la creazione di ogni campana, si parte dall’anima, la forma interiore, e da lì si inizia a dare forma e si attende fino alla fusione, la nascita. E proprio come per ogni nascita, c’è un rito. Il momento del getto del bronzo è sacro. Viene accompagnato dalla preghiera del parroco e dall’invocazione alla Madonna, per benedire la creatura – la campana – che verrà al mondo. Il metallo incandescente scorre come lava viva, e ogni colata è un atto di fede, perché lì si concentra il lavoro di mesi o addirittura di un intero anno.
Nella «Sala del Paradiso», invece, dove gessi di angeli ricoprono le pareti, si respira l’eternità. Fu un visitatore americano a ispirare questo nome. Colpito dalla moltitudine di santi appesi, esclamò: «Ci sono più santi qui che in Paradiso». Ma forse, più che santi, lì dentro vivono memorie di mani, che magari non ci sono più, ma che ancora parlano attraverso ogni decorazione, ogni incisione, ogni ornamento.
Ma la campana, per Marinelli, non è solo corpo, è anche voce che vibra e si espande con una tonalità unica e riconoscibile. Che chiama alla preghiera, che consola, che celebra e unisce, come recita l’incisione in latino: «En ego campana nunquam de nuncio vana», cioè «Ecco io, la campana, non annuncio mai cosa vana». Anche qui, la perfezione del suono nasce da una fusione di rame e stagno puro, da proporzioni e regole ben precise. Non ci sono scorciatoie né repliche. Ogni campana nasce da una lavorazione esclusiva, che impone tempi lunghi e dedizione assoluta.
Nella sua lunga storia, la fonderia ha vissuto tutto: glorie, incendi e rinascite, senza mai smettere di creare se non nel periodo della seconda guerra mondiale, quando l’attività venne sospesa essendo state requisite le campane per scopi bellici. Nel corso dei secoli, ha lavorato per re e papi, ha pianto e celebrato col rintocco delle sue campane. Tra i momenti più significativi, Marinelli ricorda il 1924, quando Papa Pio XI concesse alla fonderia il privilegio dello Stemma Pontificio. Nel Museo Storico della Campana, sopra il laboratorio, è conservata la memoria di tutto questo.
Oggi, in un’Italia che costruisce sempre meno chiese, la domanda interna si affievolisce e il mercato vacilla. Ma la voce delle campane continua a viaggiare: dall’America, all’Africa, passando per l’Asia. Un giro del mondo che si traduce in circa 40 campane medio-grandi l’anno. «Abbiamo finito da poco un lavoro in Vietnam e stiamo per consegnare una campana in Florida», precisa Marinelli. Il tallone d’Achille, però, rimane il tempo. Quel tempo che non si può comprimere, che resiste a ogni logica di produzione di massa.
Guardando al futuro, la vera grande sfida però sarà trovare manodopera specializzata. Nuove mani, giovani, pronte ad apprendere non solo un mestiere, ma uno stile di vita. Già oggi si fa fatica. La scuola, che forma le menti, potrebbe aiutare, iniziando a onorare chi sa educare le mani, restituendo dignità agli antichi mestieri, spesso ingiustamente considerati opzioni di ripiego. «Spero in una inversione di tendenza e in una riscoperta di questi lavori», riflette Marinelli, guardando alla corsa verso il progresso dell’intelligenza artificiale, «Credo che arriveremo a un apice di questa tecnologia per poi ritrovare quella che noi chiamiamo intelligenza artigianale». Un sapere lento, profondo, che vive nei silenzi, nei passaggi non scritti, nelle parole sussurrate tra generazioni. È un mestiere che non si impara in un clic, ma si scolpisce nel cuore.
E forse, quando la prossima campana rintoccherà su un campanile lontano, in un villaggio di campagna o in una grande metropoli, sarà proprio una Marinelli a farlo. Una voce che, nel tempo della fretta, ricorda la pazienza. Che nel tempo delle macchine, celebra l’unicità. Che nel tempo dell’intelligenza artificiale, difende il sapere.
Leggi anche:
1. Artigiani in estinzione: in 10 anni persi 400mila lavoratori, l’idea del reddito salva botteghe
2. Oro: Piaserico, nei nostri gioielli l’artigianalità brilla insieme all’hi-tech. Pronti alla sfida dazi
3. Fornasetti, Lalique, Ginori e Buccellati: così il soprammobile ha i bagliori dell’arte
© Riproduzione riservata