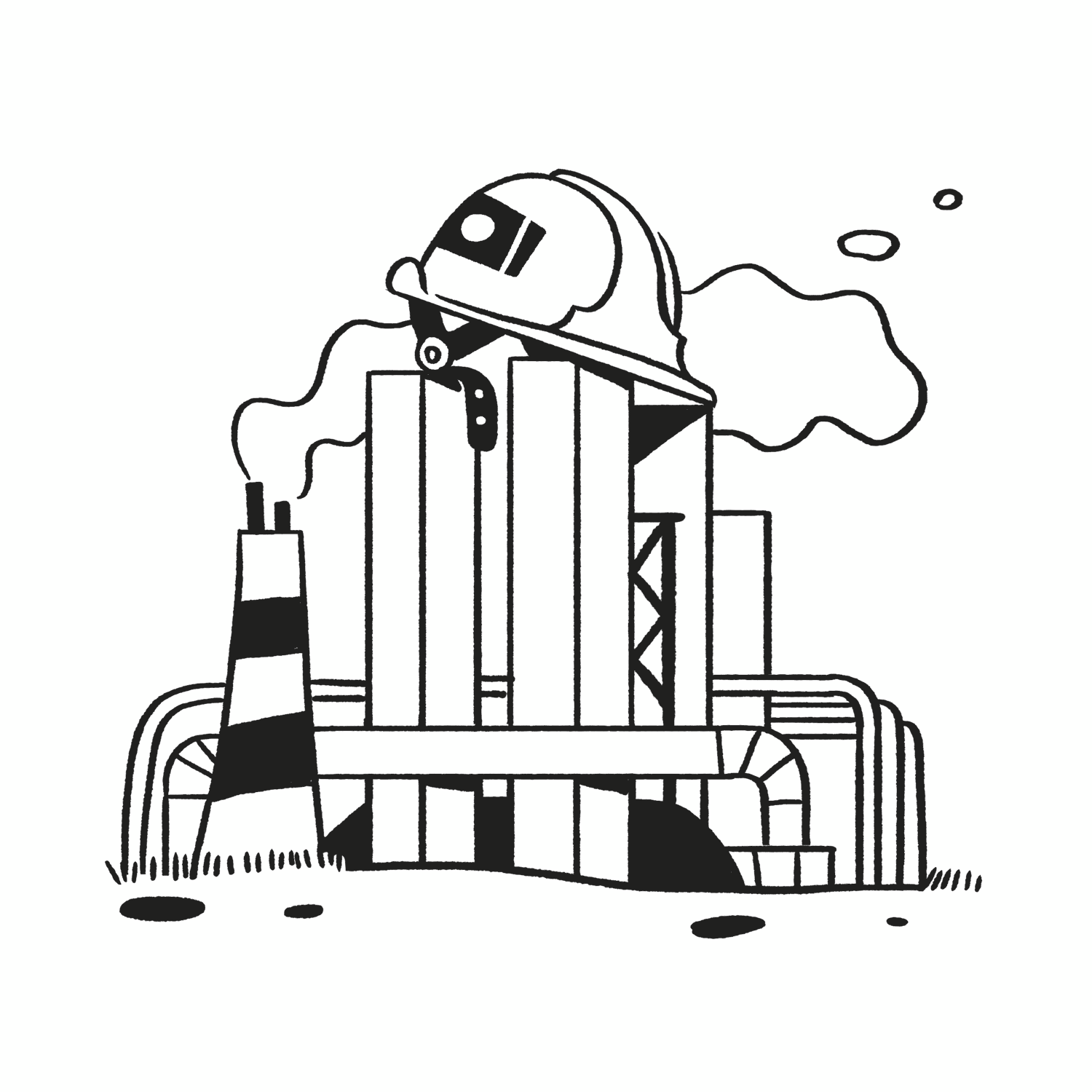Tra le proposte più dibattute del nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea – un maxi-budget da oltre 2.000 miliardi di euro – figura l’introduzione di una nuova imposta denominata Corporate Resource for Europe (Core). La misura prevede un contributo annuale obbligatorio da parte delle grandi imprese che operano nel mercato unico europeo e che abbiano un fatturato netto superiore a 100 milioni di euro, indipendentemente dalla loro sede legale.
Secondo la Commissione europea, la nuova tassa genererebbe circa 6,8 miliardi di euro l’anno, rappresentando una delle cinque nuove “risorse proprie” pensate per diversificare le entrate dell’Unione senza aumentare i contributi nazionali diretti. Il gettito servirebbe a finanziare nuove priorità strategiche come difesa, innovazione, sicurezza dei confini e competitività tecnologica.
Il meccanismo: tassa forfettaria a scaglioni
A differenza delle tradizionali imposte calcolate sugli utili, la Core prevede contributi forfettari su base annua articolati su quattro scaglioni di fatturato. Le aziende con ricavi tra 100 e 249 milioni di euro verserebbero 100.000 euro, quelle tra 250 e 499 milioni pagherebbero 250.000 euro, salendo a 500.000 euro per le imprese con ricavi tra 500 e 749 milioni. Il tetto massimo, pari a 750.000 euro, scatterebbe per le aziende con fatturato superiore a 750 milioni.
Una logica apparentemente progressiva, ma che secondo Unimpresa rischia di penalizzare anche le imprese con margini ridotti e alta intensità di capitale. “Tassare il fatturato significa ignorare la redditività reale delle imprese. Una misura del genere colpisce indistintamente aziende solide ma a margini contenuti, scoraggiando investimenti e incentivando la delocalizzazione,” ha dichiarato Paolo Longobardi, presidente dell’associazione.
Il meccanismo non distingue tra aziende europee e multinazionali straniere: chiunque operi nel mercato unico, dai gruppi americani a quelli cinesi, sarà tenuto a contribuire.
In Italia oltre 3.400 imprese coinvolte, Lombardia in testa
Secondo le stime del Centro studi di Unimpresa, in Italia sarebbero coinvolte circa 3.460 aziende con ricavi superiori a 100 milioni di euro. Di queste, oltre 1.200 superano i 250 milioni di fatturato annuo. Complessivamente, il contributo richiesto al tessuto produttivo italiano potrebbe aggirarsi attorno a 900 milioni di euro con una soglia allo 0,5%, e salire fino a 1,8 miliardi con un prelievo all’1%.
La regione più esposta è la Lombardia, che da sola concentra oltre il 32% delle imprese coinvolte (1.107 aziende). Seguono Emilia-Romagna (12%), Veneto (10%), Lazio (9%) e Piemonte (8%). Anche il Sud è presente, con Campania e Puglia rispettivamente al 5% e 4%.
Settori strategici nel mirino
Il settore manifatturiero è il più esposto, con oltre 1.200 aziende coinvolte (35% del totale), seguito da energia e utilities (15%), costruzioni (10%), servizi finanziari e assicurativi (10%) e commercio (10%). Altri comparti colpiti includono telecomunicazioni, agroalimentare e farmaceutica, tutti pilastri fondamentali della crescita e dell’occupazione qualificata in Italia.
“L’Italia – sottolinea Unimpresa- è già tra i Paesi con la pressione fiscale più elevata d’Europa, oltre il 43% del Pil. Colpire le imprese più dinamiche, quelle che trainano export e innovazione, significa minare la base industriale del Paese. Serve un approccio più equo e lungimirante. L’Europa ha bisogno di risorse, ma non a scapito della crescita dei suoi Stati membri”.
Una manovra per finanziare le nuove priorità dell’UE
La necessità di nuove fonti di finanziamento nasce dall’ambizione della Commissione di rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione. Il nuovo bilancio prevede, tra le altre cose, un aumento senza precedenti dei fondi per la difesa, da 2 a 10 miliardi di euro annui. Saranno triplicati anche i fondi per migrazione e gestione dei confini, mentre ricerca e innovazione riceveranno risorse raddoppiate per affrontare la sfida tecnologica globale con Stati Uniti e Cina.
I prossimi passi
Il dibattito è solo all’inizio. La proposta della Commissione dovrà ora essere negoziata tra Parlamento europeo e Consiglio. Intanto, da parte del mondo imprenditoriale italiano, su cui pesa anche la spada di Damocle dei dazi Usa, cresce la preoccupazione: se l’impianto della Core non verrà modificato, il rischio concreto è di vedere indebolita la competitività del sistema industriale nazionale, proprio in un momento delicato e complesso in cui la crescita stenta a decollare.
© Riproduzione riservata