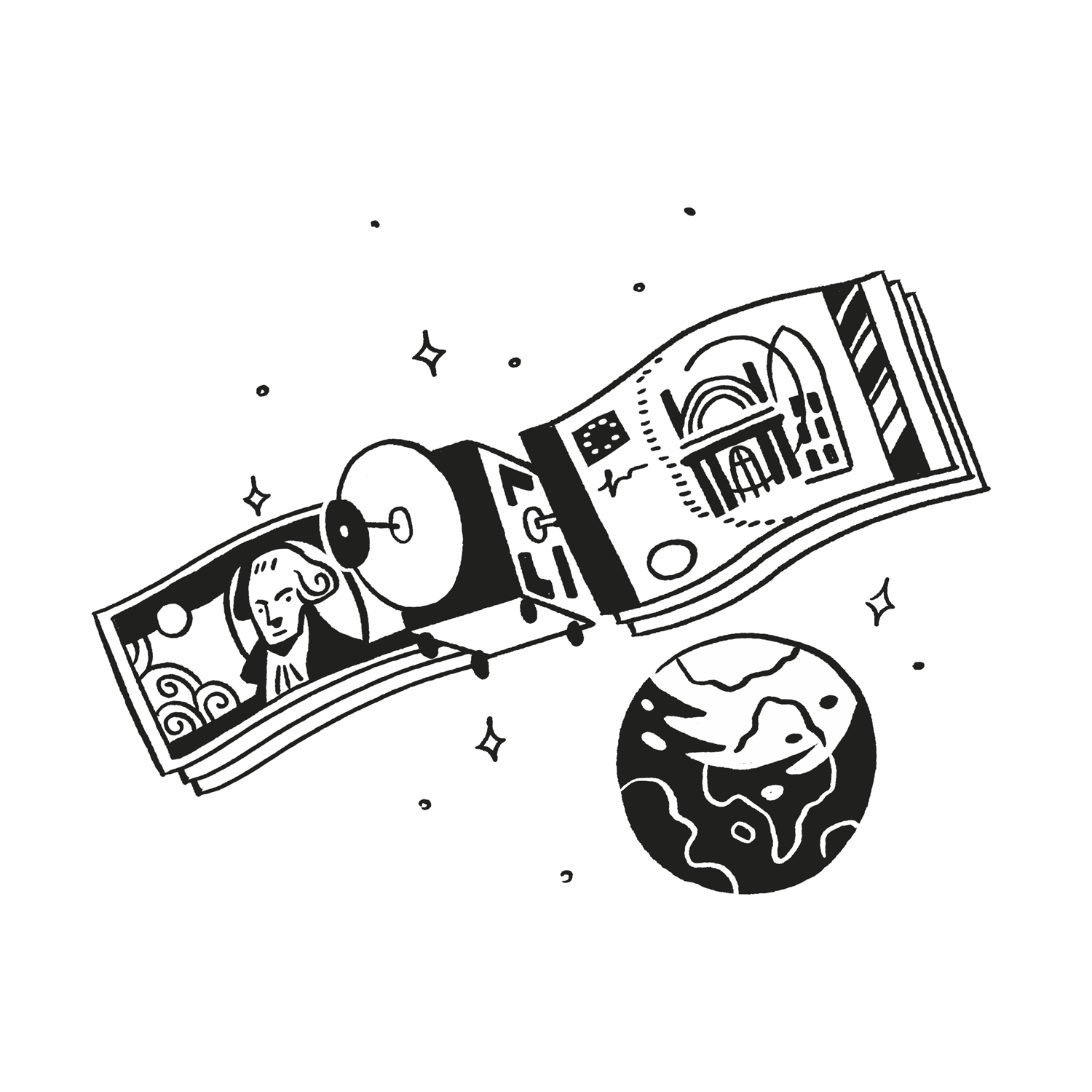Visto dalla Grande Halle della Villette, dove la ventunesima edizione del Whisky Live Paris, la più grande manifestazione al mondo dedicata al re dei distillati, ha contato 25mila ingressi in tre giorni (2.500 in più dell’anno scorso), il mondo del beverage sembra vivere un momento d’oro. Ma se l’entusiasmo degli appassionati non arretra, purtroppo sono le vendite a calare.
Per la prima volta in trent’anni è diminuito il consumo di alcolici negli Stati Uniti, nel 2024 lo Scotch whisky ha fatto segnare un -18%, il costo dell’agave da cui si ricavano tequila e mezcal è crollato. Insomma, il trend non è positivo, «ma nelle difficoltà spesso si trovano opportunità». A fare il punto sullo stato dell’arte è Thierry Bénitah, ceo della Maison du Whisky, che il Whisky Live Paris lo organizza e che si è guadagnata il ruolo di capofila europeo dei distributori e dei selezionatori di distillati. Fondata nel 1956 dal padre Georges sulla scia del grande consumo di whisky da parte dei soldati americani e dal 1995 guidata da Thierry, la Maison non è un colosso multinazionale come Diageo, Pernod Ricard o LVMH, ma è un «grande fra i piccoli»: 245 dipendenti, fatturato di 150 milioni di euro (centuplicato in trent’anni), 250 brand e 4000 referenze esclusive, presente come esportatore in 45 Paesi. Ecco perché dalla sua posizione particolare Bénitah può raccontare meglio di tanti altri cosa succede dietro le quinte del beverage.
Monsieur Bénitah, il 2024 è stato l’annus horribilis degli alcolici. Com’è la situazione oggi?
«Dal 1995, quando ho preso le redini dell’azienda di mio padre, abbiamo attraversato tanti momenti difficili. Ma nessuno è durato così tanto, neppure con la crisi economica del 2008».
In cosa è diversa questa crisi del settore?
«È la prima che dura più di sei mesi. Speravamo che nel 2025 il mercato invertisse la rotta, ma finora il trend negativo si conferma».
Qual è il motivo?
«Il problema centrale è la sovrapproduzione. Le distillerie sono sedute su un mare di prodotto invenduto. Il che porta alle prime chiusure, ai fallimenti, al disinvestimento generale dai progetti e dalle piccole realtà».
Come si è arrivati a questa sovrapproduzione?
«Durante la pandemia i consumi, soprattutto casalinghi, erao esplosi letteralmente. Tutti hanno aumentato la capacità di produzione, sono stati aperti nuovi impianti, i colossi hanno speso fortune e rilevato i piccoli marchi. Nessuno aveva visto arrivare la tempesta perfetta».
La guerra?
«Le guerre. E la flessione del mercato cinese, i dazi di Trump, la crociata salutista globale contro l’alcol… Il worst case scenario si è manifestato nel periodo di massima espansione produttiva».
Come si esce dalla tempesta?
«Un tema sensibile è quello dei prezzi. I nuovi listini sono arrivati da pochi giorni, per la prima volta sono calati, è il primo frutto di questo caos. Dal 2015 al 2022 i prezzi erano volati e noi lo abbiamo accettato senza problemi, perché il mercato era ricettivo. I produttori pensavano sarebbero potuti aumentare all’infinito, mentre oggi il mondo è totalmente diverso. Oggi il rapporto qualità-prezzo torna decisivo. Per esempio negli ultimi dodici mesi abbiamo assaggiato prodotti eccellenti, ma con prezzi non corretti. Non li abbiamo presi».
Esiste una soglia psicologica di prezzo?
«Si è creata negli ultimi due anni, perché i consumatori sono più sensibili alla spesa. Diciamo che intorno ai 60 euro c’è uno scalino importante. Ma per alcune bottiglie è anche più bassa, 40 euro».
E i brand di lusso?
«Ognuno decide come posizionarsi. Alcuni marchi come Macallan e Dalmore hanno scelto il settore ultra-premium, altri ci provano. Ma non sono tanti quelli che riescono a guadagnarsi un posto al sole. In generale, non mi trovo molto a mio agio con questo tipo di approccio, con il marketing che fagocita il whisky o il rum. Sono lontano da questa idea di business. Certo, questo periodo per il lusso è ancora più difficile».
Quali altri cambiamenti state notando nel mercato?
«Per esempio siamo tornati agli age statement (l’indicazione in etichetta degli invecchiamenti dei distillati, ndr). Oggi i cosiddetti NAS, i whisky senza età di invecchiamento, sono invendibili a certi prezzi. Si torna al passato, a quando in commercio c’erano solo malti maturati almeno 12 anni. La narrazione sull’età che non conta è recente, è figlia della carenza di stock di whisky vecchi. E oggi non funziona più».
Come sta andando il settore delle rarità e del collezionismo?
«Finalmente ci sarà differenza fra prodotti davvero rari e fintamente limitati. Il mio amico Sukhinder Singh, grande collezionista e fondatore dell’ecommerce The Whisky Exchange, è convinto che il collezionismo non finirà mai, cambierà soltanto. E devo dire che le aste in corso sulle nostre piattaforme gli danno ragione: dopo mesi di flessione, i compratori sono tornati».
E il whisky come investimento? Il fallimento di società come Cask88 e Braeburn spaventa
«Ci sono diversi punti di vista: gli operatori finanziari puri che fanno affari ad alto livello con l’Oriente sono pessimisti; i distributori non sono così netti. La mia sensazione è che ora si vedrà il vero valore di selezionatori e imbottigliatori».
Darwinismo alcolico, la sopravvivenza del più adatto?
«Diciamo che forse finirà la speculazione fine a se stessa».
Nel generale stallo, gli analcolici e i low-alcohol fanno segnare crescite a due cifre. Bolla di sapone o tendenza vera?
«Quest’anno il dry january, il mese di astensione dall’alcol, è stato un fenomeno nazionale: i consumi sono aumentati di cinque volte e ci hanno costretti ad occuparci di un settore merceologico che avevamo sempre snobbato. A livello assoluto vale ancora poco, ma non possiamo più ignorarlo. Funziona fra i giovani».
La Maison, fra i suoi grandi meriti, ha anche quello di aver fatto scoprire il whisky giapponese all’Europa…
«Il caso giapponese è esemplare. Sono passati dall’avere uno stock minuscolo con allocazioni impossibili all’esplosione delle distillerie. I guai sono arrivati anche lì».
E in Francia?
«Non molti sanno che in Francia ci sono ormai più di cento distillerie di whisky. Non ci sono big players, sono tutte mediamente piccole, locali, e hanno successo perché ai consumatori piace comprare francese, spendere in qualcosa che faccia parte della comunità. Orgoglio nazionale…».
…alla faccia del cognac…
Sorride. «Oggi nell’Esagono si produce più whisky che cognac, è cambiato un mondo. Quando ho iniziato, non potevo letteralmente andare in Cognac, ce l’avevano a morte con me, rischiavo la pelle. Oggi la maggior parte delle nuove distillerie di whisky sono in Cognac. Anzi, sono gli stessi produttori di cognac, che – avendo già licenza e alambicco – diversificano la produzione nei mesi in cui non si distilla il vino…».
Nel 2017 avete creato una joint venture con Velier, l’azienda genovese di Luca Gargano: 10 milioni di fatturato, presente in 32 mercati con marchi come i rum Hampden e Caroni, i Clairin di Haiti, la serie di single malt “Artist”. Anche in Italia stanno fiorendo le distillerie di whisky. Ci sono similitudini?
«Io e Luca siamo molto diversi, lui vulcanico, io più posato. I mercati sono diversi, ma ad entrambi piacciono l’autenticità e l’onestà in un mondo non così onesto. Siamo trasparenti, indipendenti e soprattutto condividiamo una filosofia: abbiamo il privilegio di essere persone prima di aziende».
A proposito di persone: 25mila ingressi al Whisky Live quest’anno.
«Siamo molto orgogliosi del fatto che sia cresciuto gradualmente fino a diventare l’evento che è. Inizialmente la Maison lo organizzava ma non voleva comparire. Oggi invece è strategico per la ricezione del nostro marchio, per la reputation».
È arrivato il momento di qualche cambiamento strategico per le aziende che si occupano di spiriti?
«Io nelle crisi vedo solo opportunità. Ci siamo abituati al fatto che tutto il mondo sia disponibile, ma oggi è prioritario concentrarsi e, se necessario, avere la forza di fermarsi e tagliare qualche brand dal portafoglio. Un ridimensionamento di progetti, non licenziando personale».
Quali sono le sfide che vi attendono?
«La principale è creare delle categorie oltre i brand, come è stato fatto con il single malt, che è emerso come prodotto d’eccezione quando tutto il mondo beveva blended whisky più commerciale. Faccio un esempio: da tre anni in Francia è esploso il consumo di sakè. Ma noi ci lavoriamo da vent’anni: formazione, narrazione, lavoro con la gastronomia… Servono progetti precisi in cui credere, non solo marketing. La seconda è sapersi adattare ai mercati, e poi c’è la terza…».
La qualità?
«No, beh, io adoro la qualità, chi non la adora? No, il tema è che bisogna vendere. Sembra banale, ma non lo è. Noi siamo nati retailer con il negozio di rue d’Anjou, solo recentemente si è affiancata l’attività di distribuzione. L’equilibrio fra le due anime è importante e oggi è tempo di spostare di nuovo il focus sulla capacità di vendita, sul consumatore».
Qual è la parte del suo lavoro che preferisce?
«Assaggiare whisky e rum per le nostre selezioni ovviamente è emozionante, mi esalta lavorare con marchi diversissimi. Ma quel che più mi dà soddisfazione è trovare soluzioni ai problemi, capire il posizionamento corretto di un prodotto. Il fine tuning».
Cioè?
«Intervenire per migliorare i piccoli dettagli. Per il Whisky Live è stato così, ogni anno sistemiamo qualcosa. Un’area da ampliare, un servizio in più…».
Lei è un perfezionista?
«Sì, ma non amo avere il controllo totale. Questo settore non è solo profitti, è anche avventura, divertimento e spontaneità. Il bello è creare le condizioni perché qualcosa di speciale accada. Smetterò quando nulla mi sorprenderà più».
Leggi anche:
Campari cede Cinzano al Gruppo Caffo: l’addio frizzante vale 100 milioni
© Riproduzione riservata