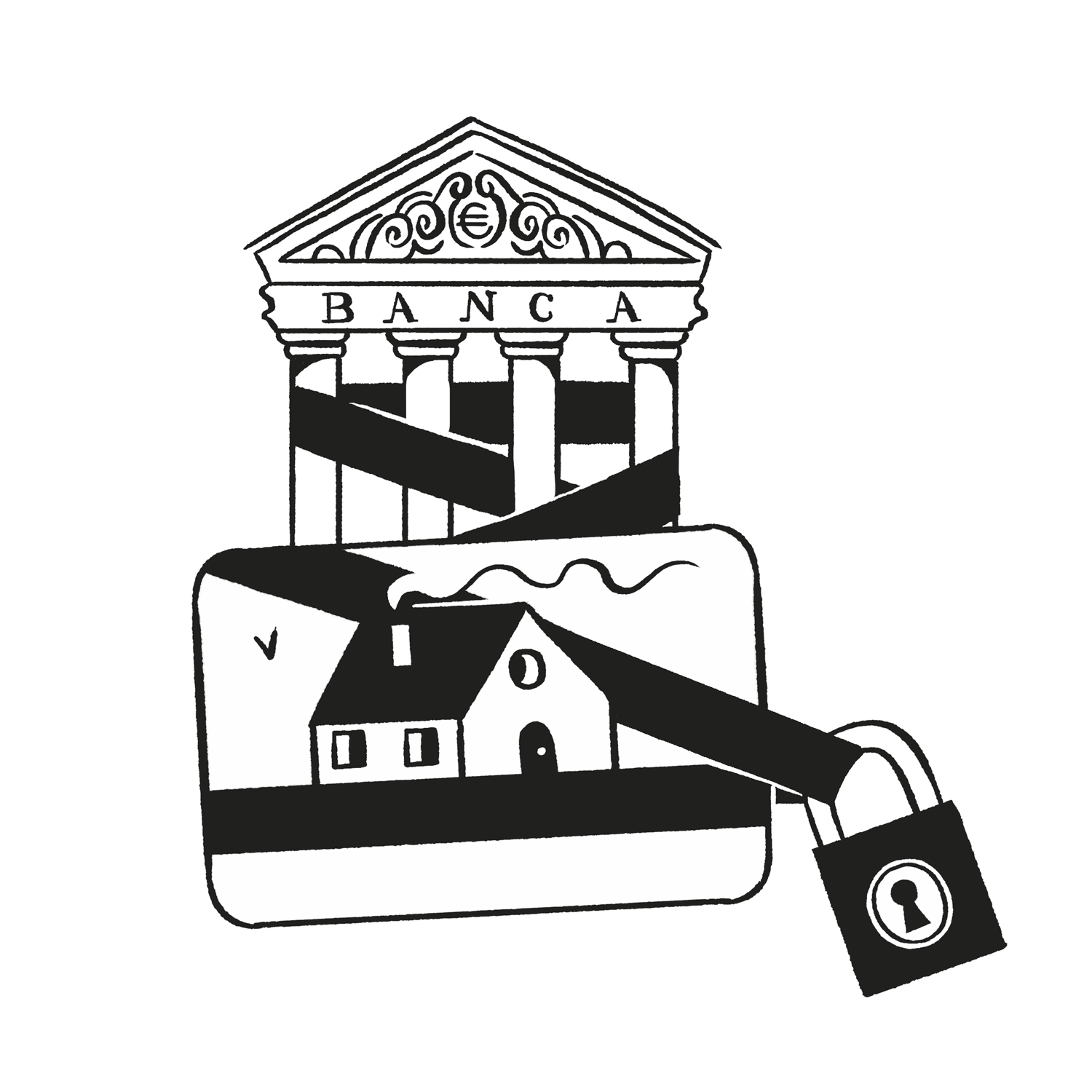Dieci anni dopo il crac delle ex popolari venete, il fantasma delle insolvenze continua a camminare tra Montebelluna e Vicenza come una condanna senza appello. I risparmiatori traditi non hanno ancora trovato giustizia, alcuni responsabili di quella rovina morale e finanziaria stanno pagando ma altri restano al riparo dietro le pieghe di procedure infinite o perché considerati “intoccabili”. Il sistema bancario nel frattempo è cambiato, si è ristrutturato, capitalizzato, e negli ultimi diciotto mesi ha persino riscoperto la sua centralità nel mercato. E mentre i titoli delle grandi banche quotate corrono in Borsa, regalando agli azionisti plusvalenze mai sognate, i risparmiatori delle Popolari sacrificate nei falò delle improvvisazioni e delle regole mai uguali per tutti, osservano storditi, inchiodati alla loro disfatta.
Veneto Banca e Popolare di Vicenza dovevano rappresentare l’orgoglio del credito territoriale, la solidità di una finanza “di casa” nella regione più ricca e più dinamica del Paese. Invece, nel 2015, hanno trascinato nella polvere il risparmio di decine di migliaia di famiglie. Secondo i dati non ufficiali, furono oltre 206mila i cittadini coinvolti nei due crac, per un numero di miliardi svaniti che ancora oggi è difficile consuntivare. Numeri che non raccontano solo un disastro economico, ma una frattura sociale profonda.
Il pensionato che si fidava dell’impiegato allo sportello, l’artigiano che comprava azioni perché lo facevano tutti, la famiglia che pensava di costruire un futuro per i figli: è questa l’Italia andata in fumo. E non per disgrazia o per un evento imprevedibile. Dietro l’euforia della crescita di Veneto Banca si nascondevano anni di silenzi, controlli inefficaci, relazioni ispettive finite nei cassetti. Bankitalia, che oggi s’indigna con piglio severo, intervenne con la consueta lentezza felpata: gli ispettori già nel 2013 avevano fotografato il meccanismo delle “azioni finanziate” – le cosiddette operazioni baciate (una pratica allora assai diffusa nel mondo delle banche popolari) – ma per altri due anni nulla accadde. Quando la Vigilanza decise di agire, il buco era ormai un cratere. La verità è che Via Nazionale non può limitarsi a recitare la parte del giudice severo dopo aver chiuso un occhio mentre i buoi lasciavano la stalla. Il suo ruolo non era di certificare il disastro, ma di prevenirlo. È così che la storia delle Popolari venete resta anche una pagina di vigilanza mancata, di controlli ritardati, di complicità istituzionali con un sistema che, in nome della stabilità, ha preferito non vedere. È accaduto allora, ed è accaduto di nuovo negli anni della liquidazione, quando la burocrazia ha sostituito la giustizia e la responsabilità si è sciolta in mille cavilli.
I commissari
A dieci anni dal disastro dell’istituto di Montebelluna, scopriamo che nemmeno i commissari liquidatori si sono mossi nella direzione di rigore che i risparmiatori attendevano. Gli esposti presentati dall’associazione dei piccoli azionisti guidata da Luigi Ugone, di cui Camilla Conti ci riferisce a pagina 4, parlano chiaro: transazioni milionarie a favore di debitori eccellenti, sconti generosi, conflitti di interessi gestiti con leggerezza. Il caso De Vido, con uno “stralcio” di oltre 34 milioni su 73 milioni di esposizione, è solo la punta dell’iceberg. Altri nomi, altre società, altre dilazioni di comodo si aggiungono alla lista delle pratiche discutibili, sulle quali la Vigilanza ha mantenuto un riserbo irresponsabile. Anche la vicenda che riguarda Enrico Marchi – l’imprenditore che alla testa di Nem sta provando ad acquistare La Stampa dopo aver rilevato i quotidiani veneti di John Elkann – e la sua società Aprile è oggetto di approfondimento nelle nostre pagine: anche in quel caso la procedura di liquidazione si è mossa con solerzia sorprendente, là dove in migliaia attendono ancora una pur misera risposta.
Non è solo questione di singoli episodi: è la fotografia di un sistema che si protegge, che gestisce il dopo come ha gestito il prima, con opacità e autoreferenzialità. In questi dieci anni abbiamo assistito a un copione che si ripete: un ordine dei tempi rovesciato, che fa giustizia solo quando non serve più. Bankitalia si è svegliata tardi, come un vigile che multa l’auto dopo aver ignorato per anni il divieto di sosta. Ma se davvero vuole riconquistare autorevolezza, la Banca centrale deve smettere di proteggere se stessa e cominciare a spiegare perché certe relazioni ispettive rimasero inerti, perché la rete di relazioni interne alle banche venete fu tollerata, perché i vertici non furono rimossi prima del collasso.
Vigilanza
Non c’è risarcimento possibile senza ammettere le proprie responsabilità. Né per le banche né per lo Stato né per la Vigilanza. Il dramma dei risparmiatori veneti non è una parentesi: è un atto d’accusa permanente contro un sistema che ha preferito l’autoconservazione alla tutela del cittadino. E che oggi, a disastro compiuto, si limita a gestire la decomposizione, come se la liquidazione fosse una pratica amministrativa e non una questione morale.
Finché i risparmiatori traditi non avranno giustizia, ogni profitto bancario resterà moralmente viziato. E finché la Vigilanza non riconoscerà il proprio fallimento, ogni parola sulla stabilità del sistema suonerà come retorica di cartapesta. Il film di Antonio Albanese, “Cento domeniche“, restituisce la misura umana di quella disfatta: un padre che si fida, che crede, che cade. Ma il film reale non è finito. Sta ancora andando in scena nelle case di chi ha perso tutto o quasi tutto.
Leggi anche:
© Riproduzione riservata