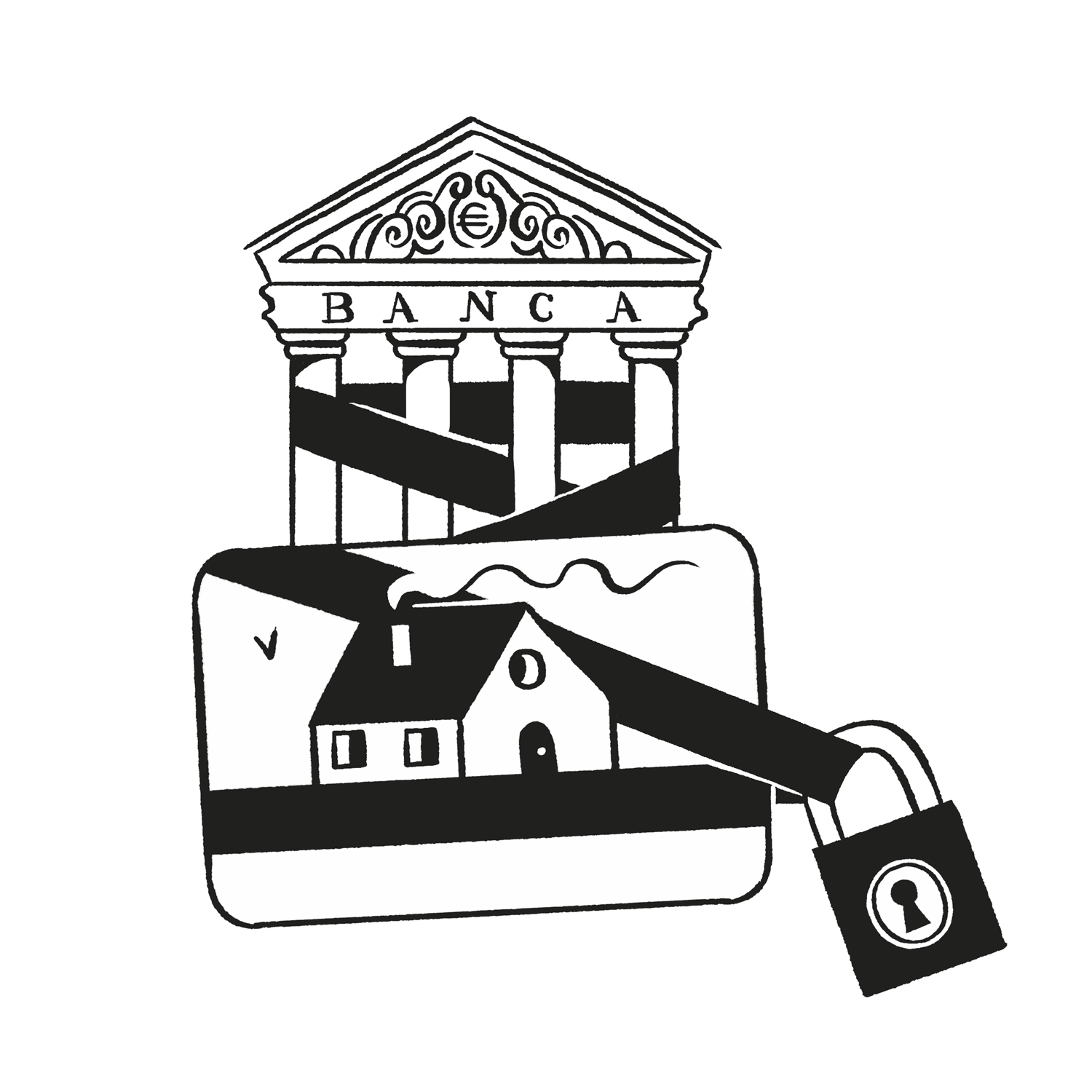C’è stato un tempo in cui collezionare arte era affare solitario, gesto di mecenatismo o di prestigio personale. Oggi, nel cuore dell’alta finanza, anche chi possiede capitali a sei zeri sceglie di “fare la colletta”. Non per necessità, ma per strategia. È il concetto alla base dei club deal, modelli di investimento collettivo che permettono a gruppi selezionati di investitori privati di unirsi per finanziare progetti e accedere a operazioni di alto valore, altrimenti difficili da realizzare per mancanza di rete, competenze e mezzi. In questo caso, si tratta di un co-investimento in opere d’arte di altissimo valore. Perché anche chi ha molto, oggi vuole rischiare meno, diversificare meglio e accedere a un mercato storicamente chiuso.
Si tratta di un mercato da miliardi, ma non per tutti. Nel 2024 oltre la metà (52%) delle vendite all’asta globali ha riguardato l’arte contemporanea e del dopoguerra, creata cioè da artisti nati dopo il 1910. In questo segmento, a contare davvero sono state le blue chip, opere da oltre 500.000 dollari, che hanno profondamente segnato la storia dell’arte, riconosciute da istituzioni museali, gallerie internazionali e collezionisti. Come le blue chip del mercato azionario, questo segmento costituisce la parte più liquida e dinamica del mercato. Si tratta di artisti come Andy Warhol, Yayoi Kusama, Yves Klein, Pablo Picasso o Lucio Fontana. Non sorprende che circa l’85% delle opere vendute dai mercanti venga scambiato in meno di due anni, a riprova dell’alta rotazione e appetibilità di questo segmento.
Eppure, accedere a questo universo non è semplice. Servono capitali, competenze, network e un know-how tecnico che va dalla due diligence all’assicurazione dell’opera, fino alla sua rivendita. È qui che entra in gioco Matis, prima piattaforma in Europa a proporre club deal regolamentati nel mondo dell’arte contemporanea, sotto la supervisione dell’Amf (l’equivalente francese della Consob). Nata a Parigi, è approdata sul mercato italiano, con una sede a Milano.
Come funziona
Per ogni singola opera d’arte, acquistata a prezzo strategico (tra 500.000 e 5 milioni di euro) viene creato un club deal, ovvero una società ad hoc (una srl francese) proposta a un gruppo di investitori con un ticket minimo di ingresso di 20.000 euro tramite l’acquisto di obbligazioni convertibili.
Il modello è puntare sulle opere più significative e rare di artisti iconici, acquistarle con uno sconto consistente, che può arrivare anche al 60%, e rivenderle entro un orizzonte temporale di 24 mesi, con una durata massima di cinque anni, attraverso canali professionali (gallerie, collezionisti, musei), generando una plusvalenza per gli investitori. «Il nostro team è in grado di valutare rapidamente il prezzo massimo al quale è opportuno comperare l’opera e può quindi gestire un flusso di operazioni molto ampio, al fine di battere il mercato», spiegano da Matis.
A seconda del valore di rivendita ottenuto, gli investitori possono recuperare i propri fondi e la plusvalenza realizzata. Da quando è nata nel 2023, Matis ha selezionato 65 opere per i propri club deal, ha effettuato 16 rivendite, tra le quali un’opera di Lucio Fontana, e ha restituito quasi 15 milioni di euro agli investitori, con una performance media netta del 17,7%, a seconda del club deal. Interessante il ritorno di oltre il 31% realizzato in soli nove mesi con un’opera di François-Xavier Lalanne.
Certo, non c’è nulla di garantito. Investire nell’arte contemporanea comporta rischi di perdita di capitale e di liquidità. «Circa l’80% delle opere affidate alle gallerie viene venduto entro due anni dalla consegna, e puntiamo a operare all’interno di questa finestra temporale. – rassicurano da Metis – Tuttavia, il successo della vendita dipende dall’interesse dei collezionisti e non possiamo garantire un termine preciso per la dismissione».
L’approccio suggerito? Creare un portafoglio di più opere, replicando nella sfera dell’arte la logica del portafoglio bilanciato. Qualora la vendita non avvenga entro i cinque anni, i titoli obbligazionari si convertono in azioni e da lì i soci decidono se forzare la vendita attraverso un’asta.
Per quanto riguarda i costi, bisogna tenere conto di un 10% dell’importo investito come commissioni iniziali a cui si aggiunge un 20% della performance in caso di plusvalenza realizzata (soggetta a tassazione del 26% in Italia). Nessun costo di gestione annuo.
Insomma, non si tratta più di acquistare un’opera da mettere in salotto e ammirare, ma di entrare in un ecosistema dove la bellezza può generare ritorni e resistere alla volatilità dei mercati finanziari, che oscillano tra crisi geopolitiche e strette commerciali. E quella che può sembrare una “colletta” tra Paperoni è in realtà un esempio di una forma moderna di diversificazione patrimoniale.
Leggi anche:
1. Dalle tele di Vedova al casco di Senna così anche il lusso diventa democratico
2. Da Mr. Gold al T-Rex con Lego l’affare è un gioco a incastro
© Riproduzione riservata