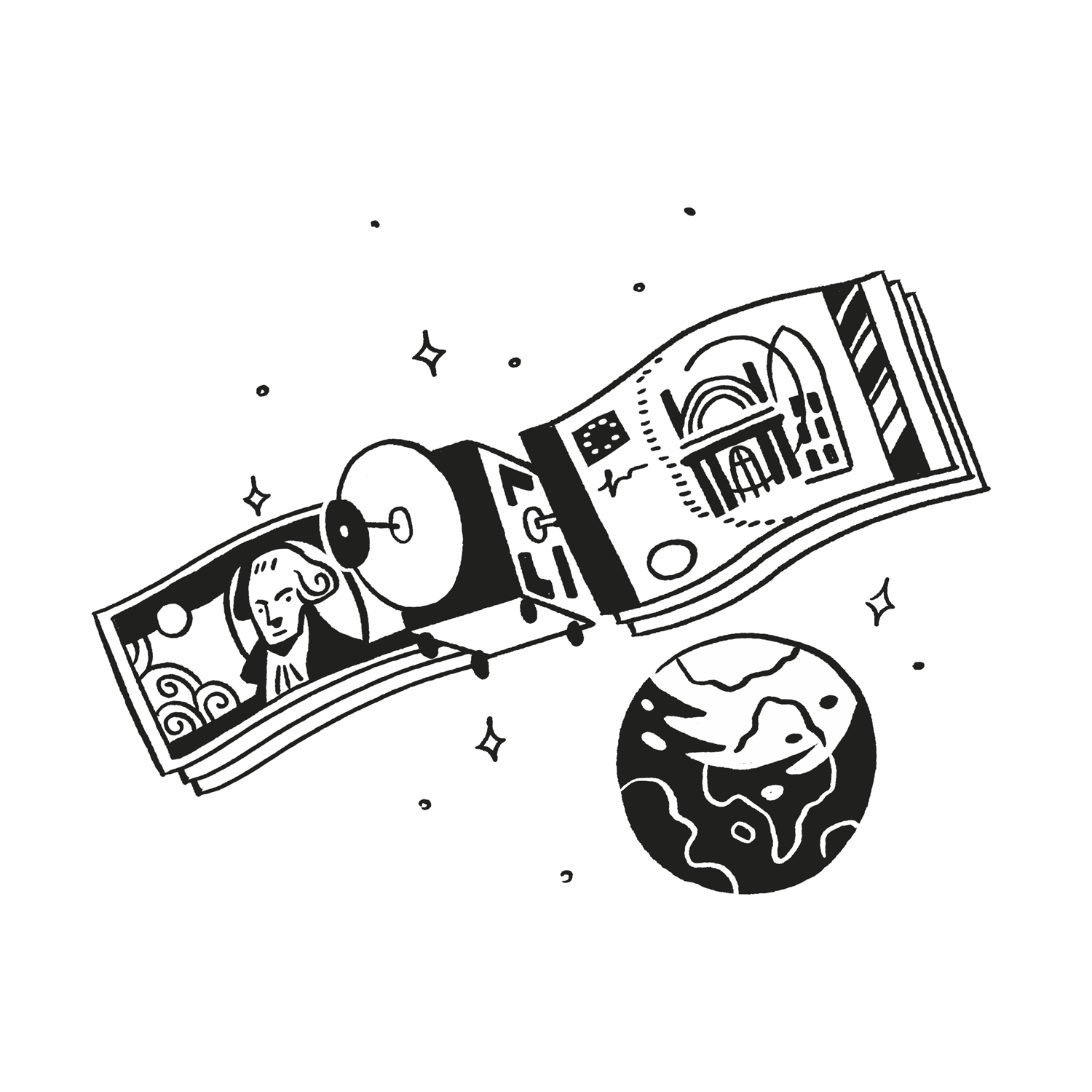è chi li chiama extra-profitti per ignoranza, e chi invece li chiama così perché serve a propalare un’immagine usuraia delle banche, pur sapendo che non c’è nulla di extra nei loro profitti. Detto una volta per tutte: il profitto di una impresa può essere buono, ottimo, eccezionale o modesto, ma mai extra. E in massima parte è sempre legato al ciclo produttivo. Nel caso delle banche, normalmente segue l’andamento dei tassi: quando questi vanno a zero non si guadagna, anzi si perde; quando invece salgono, i guadagni piovono, talvolta in misura eccezionale. Tutto qui, non c’è nulla di extra, solo normale andamento dell’attività bancaria.
Il che non ci fa velo nell’affermare che gli istituti di credito vengono da un triennio d’oro, il più ricco dalla crisi Lehman del 2008, che ha portato nelle loro casse quasi 90 miliardi di euro. Nel 2024 gli utili netti dell’intero sistema (dati Banca d’Italia) furono 35 miliardi, l’anno prima 32 miliardi e nel 2022, all’avvio del ciclo di stretta monetaria della Bce che ha portato i tassi da zero a oltre il 4% in gran velocità, si sono contati 22 miliardi di utili: in tutto, dal 2022 al 2024, 89 miliardi tondi tondi. E il 2025 non sarà da meno, anche se i tassi ormai si sono dimezzati e sul margine d’interesse si palesano le prime crescite negative, mentre gli analisti prevedono per l’esercizio altri 30 miliardi di utili netti. Che portano il totale della più ricca stagione bancaria a quasi 120 miliardi in soli quattro anni: nel primo semestre, le cinque banche principali hanno archiviato utili per 15 miliardi; e per il terzo trimestre si stimano altri 6 miliardi.
Eldorado
Una sorta di Eldorado per i banchieri che, senza affannarsi troppo, hanno visto volare il margine d’interesse, grazie alla corsa dei tassi Bce a ritmi che non si vedevano da oltre un decennio. Anche qui basta leggere i dati di Bankitalia. Il margine del prestare denaro è passato, per l’intero sistema, dai 45 miliardi del 2022 (38 miliardi nel 2021 con i tassi fermi) a 64,4 miliardi nel 2024. Per le banche una vera cuccagna, nell’ambito della quale si è realizzata l’ambizione estrema di ogni banchiere tra quelli più orientati a sviluppare l’istituto in base alle proprie stock option, prestando il meno possibile (si deve accantonare troppo capitale e c’è il rischio di sofferenze) facendosi pagare interessi i più alti possibili, e allo stesso tempo remunerando i clienti-correntisti il meno possibile. Un’ambizione molto diffusa negli ultimi anni, stemperata soltanto laddove vige il concetto di banca di sistema (Intesa Sanpaolo per esempio) o del territorio (Banco Bpm o Bper per esempio). Sta di fatto che i prestiti in soli tre anni sono calati di oltre 50 miliardi: erano 1.500 miliardi tra famiglie e imprese a fine 2021, sono scesi a 1.446 a fine 2024. Quanto ai tassi positivi per la banca, nella fase più acuta della stretta sono saliti anche oltre il 4,5% sia per i mutui sia per i prestiti alle imprese. E i tassi passivi, quelli riconosciuti ai correntisti? Quelli sono praticamente rimasti fermi. Ed è lì che c’è la vera manna per le banche. Ammontano infatti a 1.550 miliardi i depositi sui conti correnti liberi, cioè non vincolati per un certo periodo. Una massa che copre ampiamente i prestiti e che viene remunerata allo zero virgola: è dalla forbice tra le due grandezze – quanto il denaro viene fatto pagare ai mutuatari e alle imprese e quanto costa raccoglierlo alle banche – che emergono i maggiori profitti.
Leggi anche:
Banche obbligate a inviare bonifici istantanei senza sovrapprezzo
A queste argomentazioni le banche replicano che i depositi liberi non sono investimenti, ma denari che potrebbero essere prelevati dal correntista in ogni momento e quindi il tasso di remunerazione non può che essere minimo. Solo i depositi vincolati possono quindi pretendere un interesse congruo, che in questa fase si aggira sul 2-3%. Peccato che i conti vincolati siano una percentuale esigua dell’intera raccolta bancaria, per cui è fatale che, viste le grandezze in gioco, finisce per essere prestata alle imprese anche parte dei depositi nei conti correnti liberi e quindi non remunerati.
Va inoltre segnalato che nel frattempo i prestiti alle imprese non sono cresciuti, anzi mancano all’appello quasi 50 miliardi di credito affidato: erano 647 miliardi nel 2022 mentre ora ruotano attorno a 600 miliardi. Ecco la straordinaria congiuntura per il sistema creditizio: hanno fatto più soldi (20 miliardi in soli 2 anni) facendo meno credito. Per avere una misura del tutto, possiamo semplificare concludendo che dallo stock complessivo di impieghi per circa 1.400 miliardi, nel corso del 2024 le banche hanno registrato guadagni per 64,4 miliardi, vale a dire qualcosa più del 4%.
Margini di interesse
Ma c’è una novità: ora il Bengodi si sta esaurendo. Il margine d’interesse nei primi sei mesi del 2025 ha registrato in media per le prime cinque banche una decrescita del 5% a fronte del fatto che i tassi sono rientrati al 2%. Basta leggere le anticipazioni di bilancio di Unicredit, la prima banca a fornire gli esiti del terzo trimestre, per avere conferma che per i mesi a venire i segni meno nei bilanci delle banche saranno superiori ai segni più, confermando che il margine d’interesse si attesterà su valori più fisiologici. Anche se, è bene segnalarlo, perdurerà un effetto che gli economisti chiamano «vischiosità dei prezzi». Il caso dei produttori-distributori di benzina insegna: rapidi ad adeguarsi alle salite del prezzo del greggio, lenti a scendere quando i prezzi invertono la rotta.
Leggi anche:
Manovra, l’Ania: contributo delle assicurazioni ma con equità
Ma alle banche viene in soccorso l’altra voce dei ricavi: quella da commissione e servizi che, al contrario, salgono con una certa costanza praticamente in tutti gli istituti, in misura tale da neutralizzare in parte il calo dei guadagni da prestito di denaro. Non sarà però facile convincere la clientela che il 34% di redditività (i 35 miliardi di profitti netti realizzati nel 2024 a fronte di ricavi totali per 110 miliardi, sempre dati di Bankitalia) è l’effetto del ciclo dei tassi, una performance che le imprese industriali si sognano.
A meno che qualcuno non ricordi loro che il ciclo dei tassi alti è stato preceduto dal ciclo dei tassi zero, quando in soli quattro anni (dal 2012 al 2016) le banche italiane nel loro complesso hanno subito perdite per 70 miliardi e «digerito» sofferenze per circa 300 miliardi, costringendo anche colossi come Unicredit e Intesa Sanpaolo a chiedere l’intervento degli azionisti con ricapitalizzazioni per svariati miliardi. Oggi la qualità dell’attivo appare tra le più elevate mentre le sofferenze non spaventano più, considerata una patrimonializzazione media che tocca punte del 15% di Cet1. Dunque non sorprende che in questi anni, di là degli effetti del risiko esploso quest’anno, Piazza Affari le abbia più che premiate con performance stellari. Una corsa che, secondo più di un analista, potrebbe continuare dato che, nonostante il forte apprezzamento borsistico, le banche trattano a un rapporto prezzo/utile tra i più bassi del listino milanese.
© Riproduzione riservata