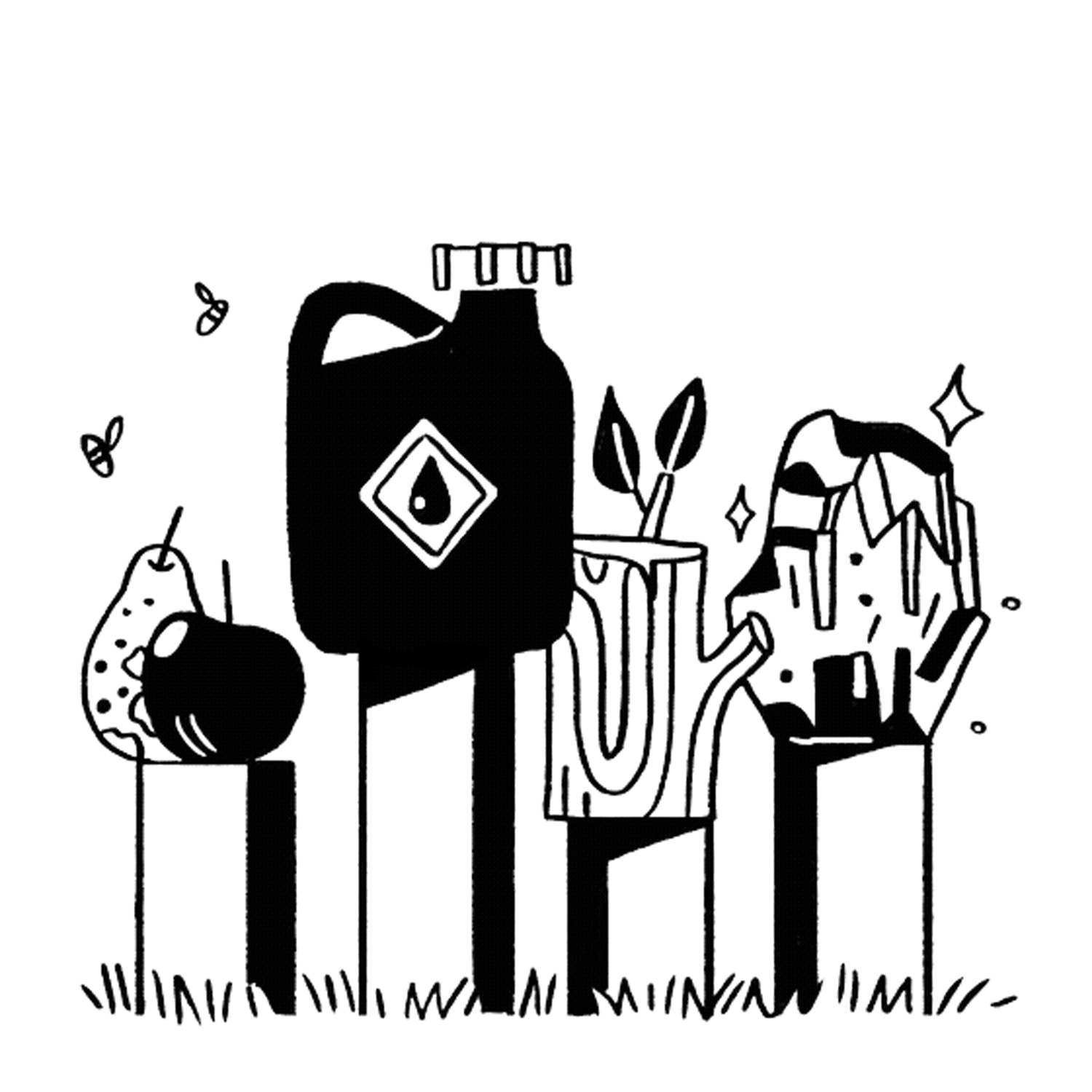E’ passato esattamente un mese, era il 2 aprile, da quando Donald Trump ha trionfalmente annunciato il «Giorno della liberazione» degli Stati Uniti. Una liberazione celebrata a suon di dazi esorbitanti su tutte le importazioni americane, che però pochi giorni dopo ha parzialmente ritrattato davanti agli effetti disastrosi provocati sui mercati e soprattutto sul dollaro. Pagine e pagine sono state dedicate alla profonda crisi di fiducia verso la leadership americana che si era propagata ovunque, a cominciare proprio dagli Stati Uniti che pure nel disegno di Trump avrebbero dovuto gioirne per gli imminenti benefici. La caduta dello 0,3% del Pil Usa annunciata mercoledì prova invece che allo stato si registrano solo conseguenze negative, appannando ulteriormente la forza del dollaro come valuta di riserva globale e accrescendo il senso di incertezza che si era registrata solo durante le peggiori crisi economiche e geopolitiche. Prima della notizia sul Pil, i mercati sembravano tornati a muoversi nel solco di una quasi normalità, il dollaro si era leggermente risollevato e le tensioni sui titoli del Tesoro americano erano calate. Ora la visione è di nuovo offuscata, anche perché il peggio potrebbe essere davanti a noi.
Ci sono due eventi cruciali che possono farci capire quali effetti ha prodotto davvero la nuova politica economica americana. Il primo accadrà martedì 13 maggio, giorno in cui verranno diffusi i dati dell’inflazione Usa relativi ad aprile. Perché è importante aprile? Perché è il primo mese in cui hanno cominciato a manifestarsi gli effetti dei dazi sui prezzi dei beni acquistati dai consumatori americani. La bassa inflazione registrata a marzo – che ha visto un Trump sprezzante scagliarsi contro la Federal Reserve per la resistenza ad abbassare i tassi – non incorporava ancora quegli effetti, mentre il dato di aprile, sebbene ancora parziale, ci potrà far capire se la nuova fiammata inflazionistica che tutti temono ci sarà davvero.
Ora, gli economisti hanno diversi modi per cercare di comprendere in anticipo le tendenze inflazionistiche, ma non sempre ci riescono perché, come più volte si è scritto, l’economia non è una scienza esatta. Secondo le valutazioni di Ignazio Angeloni, la caduta del dollaro è però motivo sufficiente per confermare che il processo ha avuto inizio: l’incognita sta nella velocità con la quale i nuovi valori si vanno consolidando.
Ciò posto, possiamo anticipare che qualunque dato d’inflazione verrà diffuso il 13 maggio dalle agenzie governative, basterà una crescita dello 0,1-0,2% per far riesplodere la polemica tra l’amministrazione di Washington e la Fed. Se infatti la crescita risulterà modesta, la posizione della banca centrale americana diventerà ancora più difficile perché per nessun motivo Trump vorrà accettare dal presidente Jerome Powell un atteggiamento nuovamente attendista sui tassi. E la contesa giuridica che ne nascerebbe, scatenerebbe nuove turbolenze a Wall Street con probabili effetti sistemici sulla finanza globale. Se poi la crescita dell’inflazione dovesse rivelarsi più sostenuta, per nulla al mondo Powell vorrà abbassare i tassi, semmai avvierà una procedura volta al rialzo progressivo, rendendo ancora più infuocata la situazione.
C’è però un secondo evento che deve indurre alla prudenza operativa, non soltanto in Borsa. Fra poco più di due mesi la sospensione dei cosiddetti «dazi reciproci» (ricordate la moratoria di tre mesi concessa da Trump sulla spinta di una Azienda America che minacciava ritorsioni congressuali?) giungerà a scadenza. Dalle informazioni che trapelano da Washington apprendiamo che attualmente sono in corso trattative con i 18 maggiori partner commerciali americani, che a rotazione sono chiamati ad «aggiustare» la misura dei loro dazi: ebbene, a meno di miracoli della diplomazia, difficilmente in così poche settimane verranno raggiunti risultati credibili. Soprattutto, non pochi di quei 18 partner resteranno in sala d’attesa per mancanza di tempo. Vale perciò interrogarsi su ciò che accadrà l’8 luglio, quando la pausa di 90 giorni arriverà al termine.
I dazi esorbitanti imposti il 2 aprile torneranno in vigore solo per alcuni partner, creando distorsioni e turbolenze analoghe a quelle che hanno determinato la loro sospensione? Oppure avremo nuove proroghe, che per definizione aumenteranno le incertezze? E quali saranno i prodotti maggiormente penalizzati? Domande non oziose, che suggeriscono massima concentrazione da parte di chi è chiamato a operare scelte che coinvolgono investimenti e lavoro: di fronte a sbalzi di umore e di intuizione di un uomo come Trump, che non ha esitato a manomettere in modo tanto caotico quanto rozzo i complessi ingranaggi del commercio globale, c’è da aspettarsi di tutto.
Per questa ragione, qualunque esito abbiano le trattative tra Bruxelles e Washington (e perché no, anche tra Roma e Washington), l’Italia deve comunque accelerare il riposizionamento del suo export in un contesto globale, vista l’importanza che riveste questa voce nel Pil nazionale. La questione riguarda soprattutto il cuore della nostra manifattura: le piccole e medie imprese che non hanno e non possono avere sedi produttive all’estero, ma che vendono direttamente o indirettamente sui mercati internazionali. Le grandi aziende hanno gli strumenti necessari per leggere in tempo reale i mutamenti in atto, e hanno risorse per avviare stabilimenti ovunque ci sia domanda di prodotti eccellenti. Ciò non vale per le pmi che, proprio per questo, oggi più che mai, hanno bisogno di un orientamento, di una bussola che consenta loro di affrontare con lucidità le nuove sfide.
Il ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani ha avviato interlocuzioni che guardano soprattutto a Oriente, con lo scopo di sostituire quanto eventualmente fossimo costretti a perdere nella trattativa con Washington. Ma il tema non è abbandonare gli Stati Uniti, con cui dobbiamo continuare a mantenere il massimo degli scambi; si tratta invece di presidiare il mercato con modelli distributivi e produttivi totalmente nuovi in territori diversi.
Dove possibile – esortava pochi giorni fa Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno – occorre favorire la creazione di presidi locali, accordi con grandi distributori e strategie di filiera che permettano di assorbire gli effetti dei nuovi dazi. E chi meglio delle Camere di commercio italiane all’estero, oggi presenti in 63 Paesi, può efficacemente edificare una struttura strategica finalizzata alle piccole e medie imprese? Avremmo così non solo semplici reti di promozione, ma veri e propri centri di intelligence economica, capaci di raccogliere i segnali deboli, anticipare le tendenze, facilitare partnership locali e guidare gli imprenditori nella lettura dei territori. Si darebbe così vita a una nuova «geopolitica dell’export» nell’ambito dei nuovi equilibri globali, che consentirebbe di dare un senso a quanto di sconvolgente sta accadendo.
Sia chiaro, non siamo tanto ingenui da pensare che saranno le Camere di commercio a risolvere il problema, ma sicuramente il loro contributo aiuterebbe. Ove ciò dovesse apparire compito improbo, dovremo cominciare a interrogarci sull’utilità di queste 63 presenze italiane all’estero.
© Riproduzione riservata