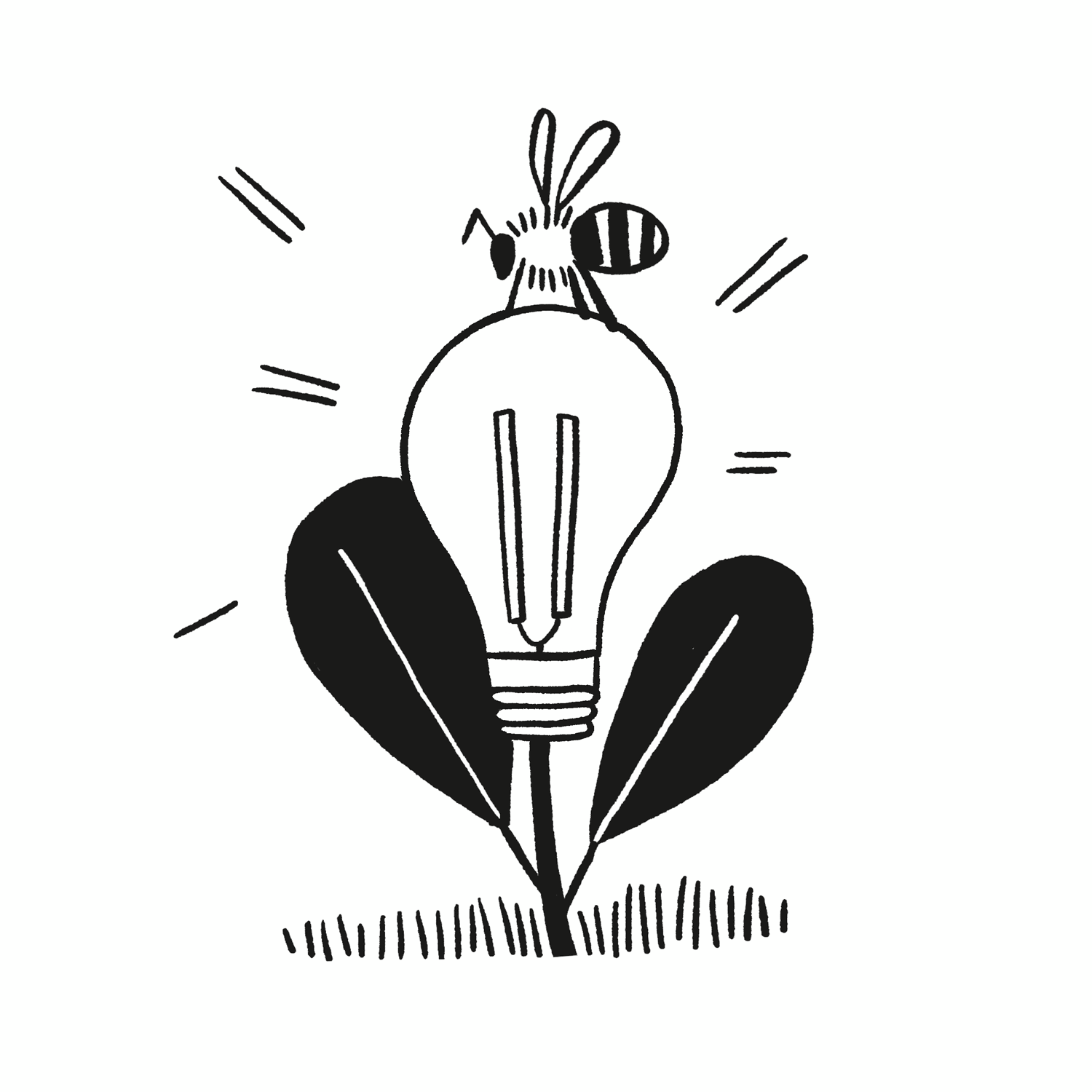Nel 2024, le imprese italiane hanno erogato in media circa 1.000 euro a dipendente sotto forma di credito welfare, con un incremento del 10% rispetto ai 910 euro dell’anno precedente. Contestualmente è cresciuto anche il tasso di utilizzo da parte dei lavoratori, che raggiunge quasi il 90%, segno tangibile della crescente rilevanza del welfare come leva per sostenere il reddito e la qualità della vita dei dipendenti. Dati dell’Osservatorio di Edenred Italia.
Spinti dalla legge di Bilancio dello scorso anno, che ha innalzato la soglia di esenzione fiscale da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per chi ha figli a carico) fino al 2027, i fringe benefit – tra cui rientrano buoni acquisto, buoni carburante, rimborsi per affitti e bollette domestiche – rappresentano oggi la principale voce di spesa all’interno del credito welfare: per la prima volta, hanno superato la metà del credito welfare complessivo che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti, arrivando a coprire il 52% del totale. Le voci di spesa a seguire sono area ricreativa (23%), istruzione (13,5%), previdenza integrativa (5,6%) e assistenza sanitaria (3,2%). Chiudono la classifica mobilità (1,5%) e assistenza familiare (0,9%).
Insomma, a fronte dei salari notoriamente bassi, nella nostra penisola, c’è una leva che da una decina d’anni a questa parte ha agito da integrazione, non del tutto marginale, della remunerazione. E soprattutto si tratta di somme che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente. Si tratta di somme «nettissime», cioè non gravate da Fisco e contribuzione previdenziale. Se è vero che la media retributiva annua in Italia è di circa 24mila euro netti (circa 33mila euro lordi, dati Eurostat), quei 1.000 euro in più derivanti dal welfare aziendale valgono come un incremento del 4%, che porterebbe la media retributiva in Italia vicino alla media Ue (circa 27mila euro netti).
Il budget
Il problema è che a godere di piani di welfare aziendale, in Italia, sono ancora pochi lavoratori. Prendiamo l’esempio dei buoni pasto (che la nuova legge di Bilancio suggerisce di portare da 8 a 10 euro): ne usufruiscono circa 3,5 milioni di lavoratori, compresi quelli del settore pubblico. Meno del 20% del totale. E si tratta della misura più pervasiva (oltre che gradita). Tuttavia, ci sono segnali di progressiva crescita del settore. Secondo l’ultimo rapporto Aon-Università di Pavia, il 76% delle aziende ha una strategia di welfare attiva; un dato in forte crescita rispetto al 2023 (era il 31%). Osservando i dati degli ultimi tre anni, anche il budget destinato dalle aziende alle strategie di welfare risulta in crescita: tra il 2021 e il 2023, il 41% delle imprese dichiarava di investire meno di 1.000 euro l’anno per dipendente in piani di well-being; nel 2024, invece, il 34% delle aziende ha indicato di aver destinato oltre 3.000 euro per dipendente negli ultimi 12 mesi.
Il 70% delle aziende intervistate ha attivato un piano di flexible benefits; in altri casi invece le prestazioni di welfare sono erogate grazie alla welfarizzazione del premio di risultato. Per il 71% dei rispondenti, il tasso di conversione del premio di risultato e dei premi di produzione è maggiore del 30%; per il 41% di aziende la conversione supera il 50%. Una volta convertite le somme in strumenti di welfare, in media l’85% dell’importo in welfare viene utilizzato entro fine anno.
Se la «welfarizzazione del premio di risultato» non è facile da misurare – l’Italia è un Paese ricco di Osservatori «di parte», ma carente di Osservatori «univoci» e integrali – è possibile misurare la diffusione dei premi di risultato: secondo una recente indagine di Adapt (su dati ministero del Lavoro) sarebbero circa 4,5 milioni i lavoratori italiani che godono di contratti di secondo livello dove viene misurata e premiata la produttività. Pochi in senso assoluto – la produttività è un altro dei buchi neri del dibattito sul lavoro in Italia – ma tuttavia una percentuale di circa il 25%. E il premio medio annuale si aggira intorno ai 1.500 euro l’anno. In questo caso Adapt misura il salario medio, basandosi sui dati Inps, che indicano la cifra di circa 40mila euro lordi l’anno (sensibilmente di più dei dati Eurostat): sempre un 4% in più che si aggiunge alla busta paga base. E ancora una volta, se il premio di risultato viene welfarizzato, uscirebbe dalla busta paga, diventando nettissimo, equivalente a una serie di prestazioni che vengono indicate azienda per azienda, secondo modalità assai diversificate.
premi di risultato
Già, come si compone il beneficio di welfare aziendale che viene goduto dal lavoratore? L’Osservatorio Welfare di DoubleYou, provider che fa parte del gruppo Zucchetti, prova a fare una ripartizione di queste origini del welfare in azienda: c’è una quota (33%) che deriva dalla contrattazione collettiva nazionale (Ccnl); un’altra (30%), come detto, proviene dalla conversione del premio di risultato, ovvero quella parte aggiuntiva della retribuzione definita attraverso la contrattazione di secondo livello e riconosciuta in base al raggiungimento di obiettivi legati a produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Infine, ci sono le azioni «on-top» (85%), che comprendono sia la contrattazione aziendale e territoriale sia le iniziative unilaterali delle imprese, come i regolamenti aziendali e le liberalità, che non prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Il totale non fa 100, perché il 38% del campione dell’Osservatorio compone il suo piano di welfare aziendale attingendo dalle diverse fonti indicate.
© Riproduzione riservata