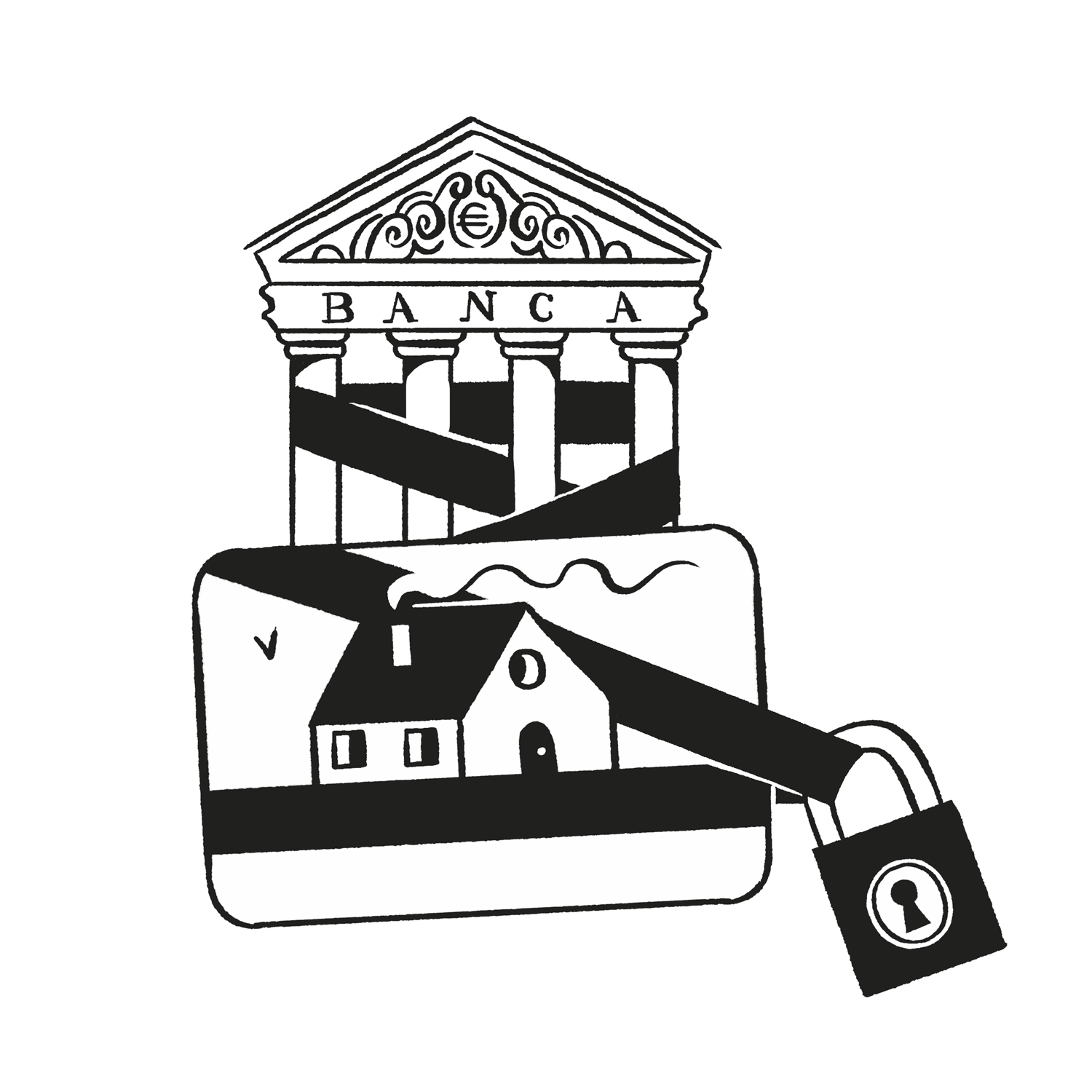Dal centro alla periferia. È un movimento lento ma costante, che avviene da anni nelle principali città italiane. Lo confermano anche i dati del gruppo Tecnocasa: nel 2024, la percentuale di acquisti di case in provincia o nei comuni limitrofi da parte di residenti in grandi città è arrivata al 24,6%, in aumento sia rispetto al 2023, quando si attestava al 23,1%, sia ai livelli pre-pandemici del 2019, quando era ferma al18%. Di conseguenza, la percentuale di acquisti nelle metropoli da parte di chi già vi abitava è in calo: è pari al 64,3%, quota mai raggiunta negli anni precedenti. Prima del Covid, i residenti in grandi agglomerati che compravano casa nella stessa località arrivavano al 74,4% sul totale delle transazioni.
Considerando le singole città, a Milano, Roma, Napoli e Torino si registrano importanti rialzi delle quote di spostamenti nell’hinterland negli ultimi sei anni. A Milano, ad esempio, il 28,5% degli acquirenti preferisce la periferia, con un +7,3% rispetto al 2019 (quando erano invece il 21,2%). Nella capitale, si passa dal 7,6% del 2019 al 13,8% del 2024 (+6,2%), a Napoli si è arrivati quasi al 27% con un +10,8% (nel 2019 si partiva dal 16%), a Torino si passa dal 24,5% del 2019 al 41,8% del 2024 (+17,4%). Il riferimento agli anni precedenti alla pandemia non è casuale: i lockdown, che si sono susseguiti nel 2020 e 2021, hanno spinto sempre più persone ad apprezzare gli spazi ampi, possibilmente con balconi e giardini, che non sono facili da trovare – o comunque da acquistare a prezzi accessibili – nelle aree urbane più affollate. In parallelo, la diffusione del lavoro da remoto ha reso meno necessario per molti lavoratori vivere in prossimità del proprio ufficio. A questi trend, si sommano poi dei fenomeni più complessi, che meritano di essere analizzati.
Gentrificazione
Tra questi è da considerare il tema della gentrificazione, che esercita una pressione crescente sui prezzi immobiliari nei centri: quartieri un tempo popolari sono stati riqualificati e resi appetibili per fasce di reddito più alte, mentre gli abitanti storici, spinti dai rincari, si sono spostati verso aree più accessibili. È un processo che si manifesta in molte metropoli europee e che in Italia ha assunto forme specifiche: nel quartiere Isola di Milano, a Monti e San Lorenzo a Roma, o in alcune zone di Torino, il cambio di volto è evidente. Dove un tempo c’erano botteghe, laboratori e famiglie operaie, oggi sorgono coworking, bistrot e appartamenti di design.
La gentrificazione nasce da un meccanismo economico definito dagli urbanisti come rent gap: la differenza tra il valore attuale di un immobile o di un quartiere e il suo potenziale costo dopo un intervento di riqualificazione. Se il divario è ampio, si attivano gli investitori, generando un circolo che aumenta i prezzi e modifica la composizione sociale dell’area. A Milano e a Roma il processo è alimentato dalla scarsità di offerta abitativa e da una domanda sempre più alta. In molti casi, le piattaforme di affitto turistico hanno accelerato la sostituzione dei residenti con flussi temporanei, contribuendo a rendere i centri urbani più esclusivi. A Milano, in particolare, secondo i dati Tecnocasa, i prezzi sono aumentati del 37,1% negli ultimi sei anni, mentre nell’hinterland la crescita è stata del 17,5%. Milano si conferma la città più costosa d’Italia con una media di 4.462 euro al metro quadro, seguita da Roma con 3.169 euro.
Gli esperti, inoltre, sostengono che dopo la pandemia si sia affermata una nuova ondata di suburbanizzazione che non ha i tratti della fuga dal degrado, ma è piuttosto una scelta strategica. L’hinterland spesso è più sostenibile: prezzi più bassi, abitazioni più ampie e una migliore qualità dell’aria rendono queste aree attrattive per famiglie e giovani coppie. Il fenomeno è evidente soprattutto attorno a Milano, Torino e Napoli, dove la crescita dei valori immobiliari in città ha spinto molti residenti a cercare soluzioni nei comuni limitrofi. Un sostegno a questa tendenza è offerto anche dalla diffusione del lavoro ibrido o da remoto, che ha ridotto il vincolo della prossimità fisica ai luoghi di lavoro. La possibilità di lavorare da casa ha cambiato le priorità abitative: cresce la domanda di spazi domestici più ampi, con una stanza in più da destinare a ufficio, e diminuisce l’interesse per la centralità. Così, mentre i centri urbani rischiano di trasformarsi in vetrine di alto profilo, le province e i Comuni dell’hinterland diventano nuovi poli residenziali.
Verona e le altre città
Al contrario invece, in capoluoghi di dimensioni più ridotte come Palermo, Bari e Genova, le quote di acquisto nell’hinterland sono basse, rispettivamente 7,4%, 10,8% e 11,2%. Sono quindi elevate le percentuali di acquisto in città, che si attestano tra l’80% e il 90%. La motivazione è da attribuirsi al fatto che in queste città i prezzi sono mediamente convenienti: 1.136 euro al metro quadro a Palermo, 1.654 euro a Bari e 1.121 euro a Genova. La modesta percentuale di acquisti nell’hinterland di Genova è dovuta anche ai prezzi medi più elevati, dato che molti Comuni sono mete turistiche.
A Verona, Firenze e Bologna la quota di spostamenti verso la provincia è in calo rispetto al 2019. Il capoluogo emiliano però fa storia a parte: qui gli spostamenti fuori città sono sempre stati importanti e il 2024 non ha fatto eccezione: il 43,4% dei residenti ha acquistato in provincia, il 16,8% in altre città, il 2,7% ha cambiato regione.
© Riproduzione riservata