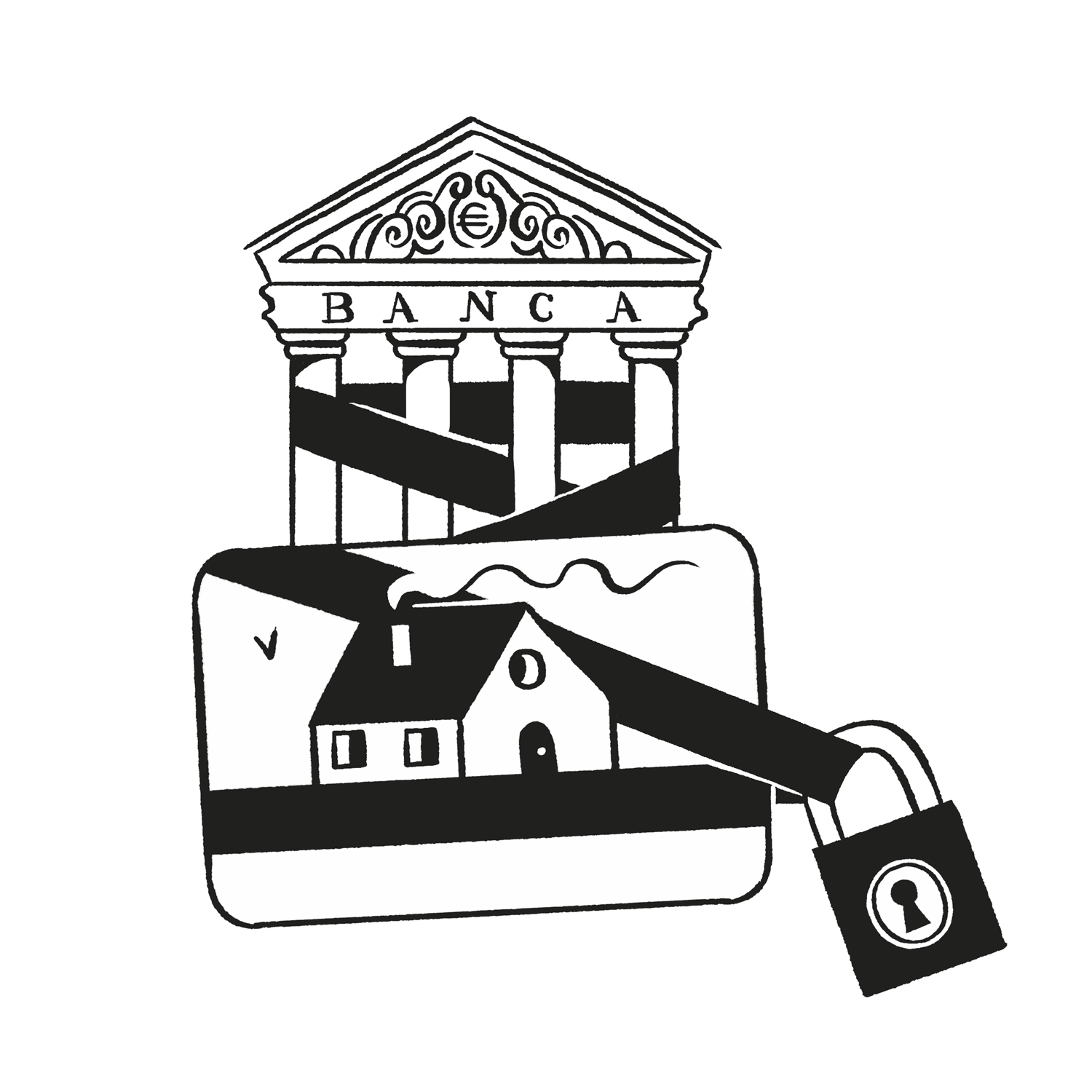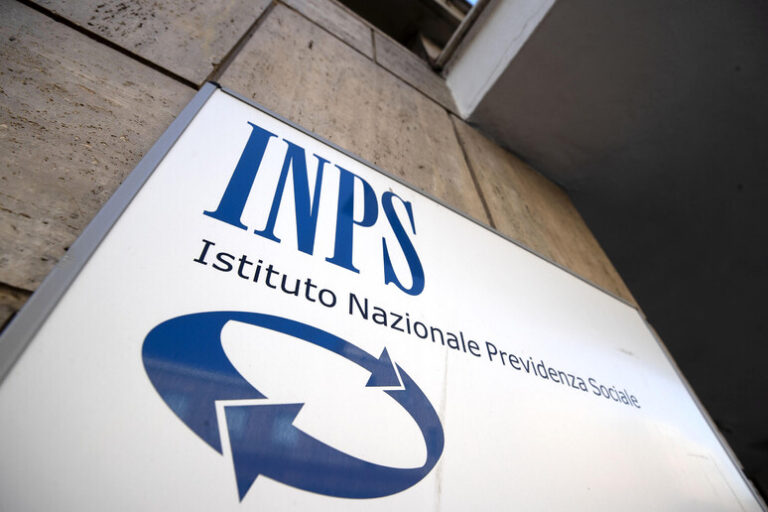Le baby pensioni sono una mostruosità che ha segnato gli anni Settanta e Ottanta (varate nel 1973, abolite nel 1992), i cui effetti sui conti pubblici continuano a essere sensibili: ci costano almeno 4 miliardi all’anno, forse di più. Ci sono cittadini italiani che percepiscono la pensione da 43 anni, e magari hanno superato da poco la soglia degli 80 anni di età: al netto dell’infanzia e dell’adolescenza hanno lavorato solamente per un quarto della loro esistenza. Un po’ poco. Si dirà che sono un’eccezione. Sì e no. Sarà il perdurare dell’effetto «moneta cattiva scaccia moneta buona», ma oltre alla patologia – le baby pensioni sono state una malattia terribile per l’equilibrio previdenziale del Paese – sembra rimasta una latenza preoccupante dell’obiettivo italico: lavorare meno, il meno possibile. Nonostante i proclami della nostra Costituzione, che vorrebbe la Repubblica «fondata sul lavoro».
All’estero
Ogni anno, da anni, ci si lambicca il cervello per consentire ai nostri connazionali di andare in pensione prima possibile, trascurando gli effetti della rivoluzione demografica in atto (l’Italia con il Giappone è il Paese dove si vive di più, e il Paese dove si nasce di meno, al mondo) e omettendo l’impatto impresso sui conti pubblici, che stanno mettendo a rischio il «patto generazionale» che sta alla base del nostro sistema previdenziale, «a ripartizione». In Italia, ma non solo da noi, le pensioni dei pensionati sono pagate dai contributi incassati dai lavoratori attivi, che a loro volta contano di ricevere la stessa cortesia, in cambio, dai loro figli e nipoti.
In altri sistemi, meno solidaristici – nei Paesi anglosassoni, ad esempio – ciascuno andrà in pensione con quello che lui stesso ha messo da parte (sistema a capitalizzazione, quello che in Italia vige nella previdenza complementare): hai lavorato per molto tempo (in ore e in anni)? Hai pagato molti contributi, in forza di una retribuzione più rotonda? Avrai una pensione più robusta rispetto a chi, per scelta o per caso, ha lavorato poco e magari con salari modesti.
La battaglia della pensione anticipata contraddistingue il dibattito politico e il confronto sindacale. L’ultimo problema, in ordine di tempo – dopo la certificazione dell’aumento dell’aspettativa di vita, da parte dell’Istat – è il blocco dei tre mesi di lavoro in più che porterebbero l’età legale della pensione (di vecchiaia) a 67 anni e tre mesi, dal 2027. Non siamo gli unici. La soglia dei 67 anni la condividiamo con Norvegia, Danimarca, Islanda, ma poco sotto (con un’età che varia intorno ai 66 anni) ci stanno Olanda, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Irlanda. Il piccolo Bengodi è rimasta la Francia, vedremo come andrà a finire.
Ma sarebbe giusto innanzitutto precisare che nonostante l’età legale di pensione a 67 anni (fino a oggi) gli italiani smettono di lavorare, in media, intorno ai 64 anni: questa è l’età reale del pensionamento. Se poi si prendono i connazionali che vanno in pensione per anzianità (in relazione ai contributi versati, non in relazione all’età anagrafica) l’età media di uscita è di poco più di 61 anni. Sorpresi? Eppure, il dato è consolidato da tempo nei bilanci Inps e nelle riclassificazioni del sistema previdenziale offerte da tutti i centri di studio e ricerca, Itinerari previdenziali in testa.
Come mai? Da anni la pensione è utilizzata – impropriamente – come un ammortizzatore sociale. Di fronte alle crisi aziendali, o comunque dinnanzi ai piani di riorganizzazione che prevedono esuberi, lo strumento principe è il prepensionamento. E poi, fisiologicamente, c’è da dire che le generazioni degli attuali sessantenni (e magari settantenni) iniziavano presto a lavorare, per cui accumulare il minimo (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne: se scatteranno i tre mesi in più dal 2027 saranno richiesti 43 anni e un mese) era relativamente facile. Al lavoro subito dopo il diploma (19 anni di età) e lavoro ininterrotto magari nello stesso posto, o se si cambiava era solo per un miglioramento retributivo. E il gioco è fatto. Era fatto. Oggi non è più così: carriere discontinue, salari non sempre crescenti, accesso al mercato del lavoro sempre più tardi.
Tutto si paga con la pensione. Anche il malcostume del lavoro nero, almeno in alcune aree del Paese, che ha generato spesso retribuzione senza contribuzione previdenziale, oltre che senza fiscalità. Ma se alle tasse si può sfuggire, è più difficile sottrarsi ai calcoli della previdenza. Complicati, per certi versi troppo complicati, ma implacabili. Non hai contributi? Non hai pensione, se non quella «sociale» (il vecchio «milione di lire» che oggi è poco più di 516 euro al mese).
«Una delle maggiori criticità del sistema pensionistico italiano, amplificata dalla recente introduzione dei cosiddetti “lavori gravosi” di cui non vi è traccia nelle letteratura medico scientifica», come scrive l’ultimo rapporto di Itinerari previdenziali, «è l’elevato numero di norme che hanno concesso nel tempo deroghe rispetto all’età legale di pensionamento per alcune categorie di lavoratori»: le baby pensioni, i prepensionamenti durante le varie crisi di settore, le nove salvaguardie per «esodati» e altre categorie dal 2012 al 2019, l’introduzione delle anticipazioni per lavoratori precoci, disoccupati, Opzione donna, nel 2019. E poi le quote, 100, 102 e 103.
Il dito puntato sulla riforma Fornero – che non si può sottoporre a referendum abrogativo, perché legge di bilancio per l’anno 2012 – in realtà si dovrebbe rivolgere anche alle due mini riforme Sacconi e ancora prima alla riforma Dini. Certamente la Fornero aveva un mandato: rendere sostenibile il peso della previdenza rispetto ai conti pubblici. Ci riuscì, e ci riesce ancora, ma certamente con dei costi sociali, soprattutto rivolti al computo dell’assegno: il prolungamento del lavoro, agganciato all’aspettativa di vita (già ideato nella riforma Sacconi) è né più né meno una garanzia di sostenibilità, per cui si tende a trasformare i contributi in rendita pensionistica per una durata di vita limitata nel tempo, che non sia più di 20 anni (poco meno, poco più). Oltre questa soglia, i conti saltano. Per questo l’aggancio «automatico» dell’età legale della pensione all’aspettativa di vita calcolata dall’Istat.
I buchi
C’è poi il problema, tutt’altro che marginale, della consistenza dell’assegno. Fino alla metà degli anni Novanta del secolo scorso eravamo abituati a sapere con certezza – o quasi – quanto avremmo preso di pensione: circa l’80% dell’ultima retribuzione (valeva il sistema retributivo di calcolo, oggi sostituito da quello contributivo: in questi anni siamo ancora nella lunga transizione del sistema misto). Oggi il tasso di sostituzione è sceso intorno al 60-65% dell’ultima retribuzione. Grazie alla Fornero? Non proprio e non solo, ma grazie alle carriere discontinue (buchi contributivi, prepensionamenti con contributi figurativi) e ai salari bassi che producono contribuzioni basse.
Le proiezioni a regime (verso il contributivo puro) vedono una possibile progressione del tasso di sostituzione fino al 75%, e anche più. Ma a tre condizioni. Primo: costanza di retribuzione e quindi di contribuzione. Secondo: adeguamenti salariali che consentano di costituire un montante contributivo sempre aggiornato, verso l’alto. Il valore della pensione è ormai agganciato al valore dei contributi messi da parte. Il sistema rimane a ripartizione, ma il calcolo della prestazione diventerà – a regime – un contributivo puro. Terzo: lavorare di più, in proporzione agli anni di vita attesi, la cosiddetta aspettativa di vita.
Insomma, non c’è scampo: per avere una buona pensione occorre lavorare, lavorare molto e per molto tempo. Anche se, si sa, lavorare stanca.
Leggi anche:
1. In pensione più tardi, ecco cosa ci aspetta
2. Pensione: come anticiparla con l’aiuto del fondo previdenziale
© Riproduzione riservata