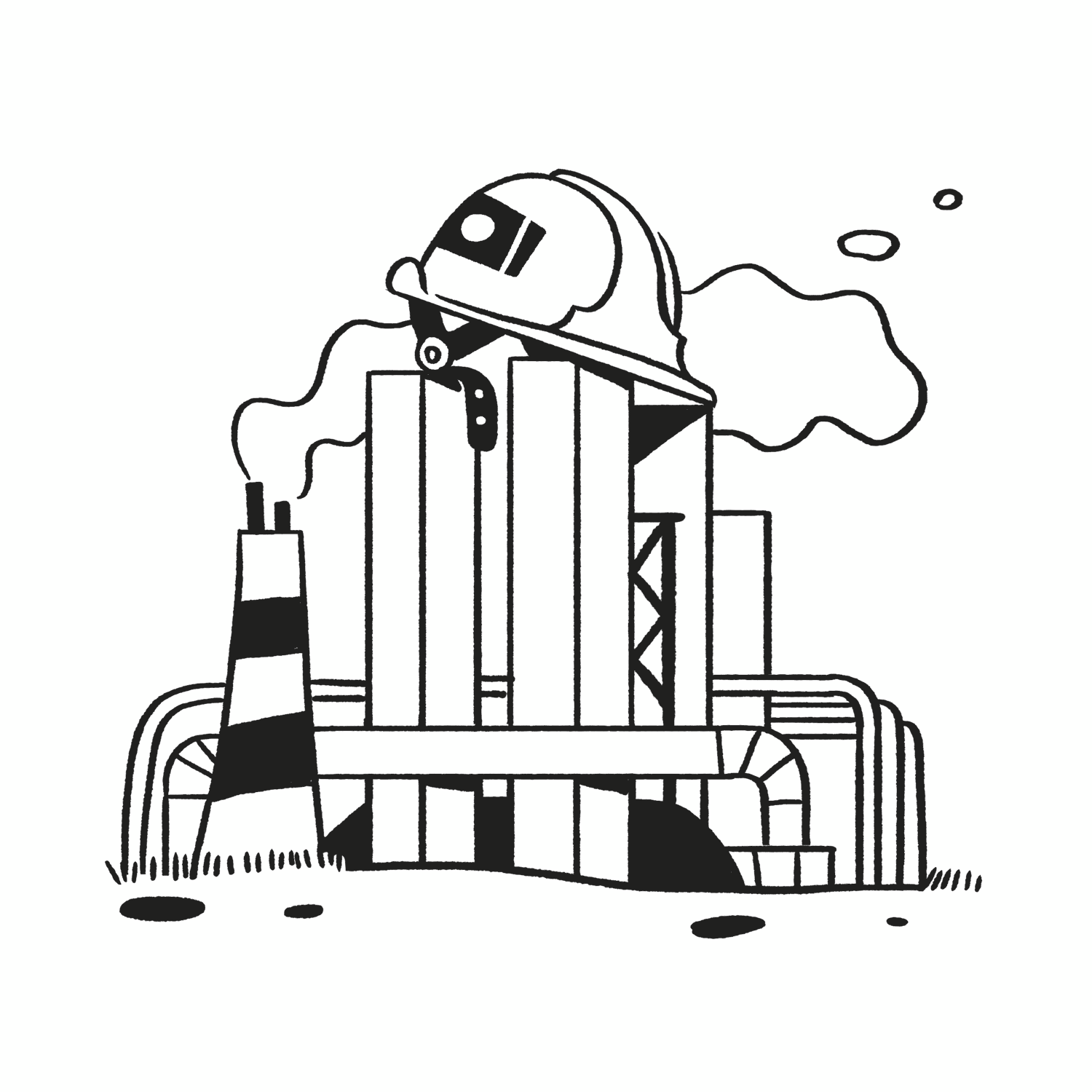Negli Stati Uniti i fondi pensione investono un patrimonio complessivo che vale quasi 43mila miliardi di dollari: una volta e mezzo il Pil. In Italia meno di 270 miliardi, un valore che non arriva al 12% del Pil. Posto numero 15 nella classifica dei Paesi Ocse. Non regge la scusa della quantità degli abitanti: là sono 300 milioni, qui poco meno di 60 milioni. Il confronto, al netto della demografia, è impari: 143 dollari contro 4 pro capite.
Questa scarsa propensione a prepararsi una propria “pensione di scorta” è spesso giustificata da una scarsa – scarsissima – educazione finanziaria. Solo poco più di 1 italiano su 10 (16,6%) ha competenze finanziarie minime accettabili, posizionando l’Italia al 36° posto su 39 Paesi Ocse. Ma anche le analisi “domestiche” emettono una dura sentenza: bocciati in educazione finanziaria. Il periodico report che produce la Banca d’Italia ogni tre anni – l’ultimo è datato 2023 – emette una insufficienza piena nell’alfabetizzazione finanziaria (10,6 punti su 20) .
I dati Ocse rincarano la dose: sulle competenze minime solo il 16,6% degli italiani raggiunge il punteggio minimo di 70 punti su 100 considerato accettabile dall’Ocse per una gestione finanziaria consapevole. Peggio dell’Italia fanno solo Paesi come Panama (16,5%), Cipro (16,1%), Paraguay (11,2%), Cambogia (12,5%) e Yemen (3%). Al contrario, la Germania domina con il 75,5% dei cittadini che raggiunge il minimo accettabile. Anche altri vicini europei più che doppiano l’Italia per competenze finanziarie: Francia (38,7%), Spagna (39,2%), Estonia (48,4%) e Finlandia (45,8%).
Le conseguenze disastrose del basso livello di educazione finanziaria italiana emergono analizzando chi comprende realmente i meccanismi di credito: appena il 17,2% degli italiani padroneggia sia l’interesse semplice che quello composto, posizionando l’Italia al penultimo posto in Europa, davanti alla sola Romania (16,9%) e lontanissima da Germania (66,4%), Hong Kong (78%) e dalla media Ocse (31%). Questo significa che oltre l’80% degli italiani non comprende realmente come funzionano i prestiti che sottoscrive, una percentuale che spiega molte delle situazioni di sovraindebitamento e la facilità con cui i cittadini cadono vittime di prodotti finanziari inadeguati. Non è difficile immaginare che questo “ritardo” coinvolga anche l’educazione previdenziale, che in qualche modo è un derivato dell’educazione finanziaria. Per certi versi anche un po’ più complessa.
Ed ecco il sillogismo: gli italiani aderiscono poco ai fondi pensione, gli italiani sanno poco di educazione finanziaria, quindi, i fondi pensione non decollano a causa di questa grave lacuna di conoscenza e di competenza. Errore? Almeno un dubbio è lecito. Il primo, su scala internazionale: possibile che gli americani siano così esperti di dietimi e di interessi composti? E allora perché hanno fatto precipitare il sistema internazionale nel più grande default della storia nel 2008? Se veniamo a casa nostra, il dubbio si presenta su un altro fronte: perché i lavoratori delle grandi (e medio grandi) aziende in Italia aderiscono ai fondi pensione per il 70-80% e invece nelle Pmi (e nelle microimprese) ci si ferma intorno all’8%? I dati sono più che attendibili, anche se mancano dalla relazione Covip. La Commissione di vigilanza ci offre tutti i dati sul gap di genere e di anagrafe (cioè donne e giovani sono i meno iscritti ai fondi) così come quello geografico (la solita divisione tra Nord e Sud), ma non ci informa sulle platee dei lavoratori (in questo caso parliamo più spesso di fondi chiusi, quelli negoziali, agganciati alla contrattazione nazionale di categoria) in relazione alle aziende in cui sono dipendenti.
Per colmare la lacuna informativa ci pensa Itinerari Previdenziali, la creatura di Alberto Brambilla, che ha snocciolato queste cifre anche in un recente convegno a porte chiuse a palazzo San Macuto. Numeri che – se la spiegazione fosse la carente educazione finanziaria – ci dovrebbero far dire che nelle aziende medio-grandi si fanno molti corsi integrativi per imparare a far di conto. Nelle Pmi, si lavora e basta.
Il gap aziendale per i fondi pensione – che si aggiunge a quello di genere, di età e di geografia – non è imputabile solo all’educazione finanziaria.
C’è una spiegazione più semplice: nelle Pmi vige un accordo ulteriore, “integrativo”, a volte non detto: se non lasci il Tfr in azienda forse il tuo posto di lavoro è a rischio. Non è un ricatto, intendiamoci bene, ma un concorso di responsabilità, che nelle Pmi è ben oltre gli obiettivi di “cogestione” alla tedesca: l’interesse dei lavoratori coincide con quello dell’imprenditore. E visto che le aziende ormai sono escluse dal sistema del credito bancario – il gigantismo del sistema ha azzerato o quasi le relazioni sul territorio – non hanno alternative: per finanziare i loro progetti usano il Tfr dei dipendenti, come fosse manna dal cielo. Nel 2024 sono stati 17,5 miliardi, negli ultimi 17 anni lo stock di finanziamento delle aziende tramite Tfr è stato di oltre 234 miliardi. O le aziende trovano alternative creditizie, oppure i fondi pensione (ovviamente c’è anche un problema fiscale non banale) saranno destinati a restare una Cenerentola, visto che in Italia le pmi occupano la maggioranza dei lavoratori dipendenti, (11 milioni su 15-16 milioni in totale) che non conferiranno il loro Tfr ai fondi, ma lo lasceranno in azienda. Per il loro interesse.
Leggi anche:
1. Pensioni, allarme Cida sulle svalutazioni
2. In pensione più tardi, ecco cosa ci aspetta
© Riproduzione riservata