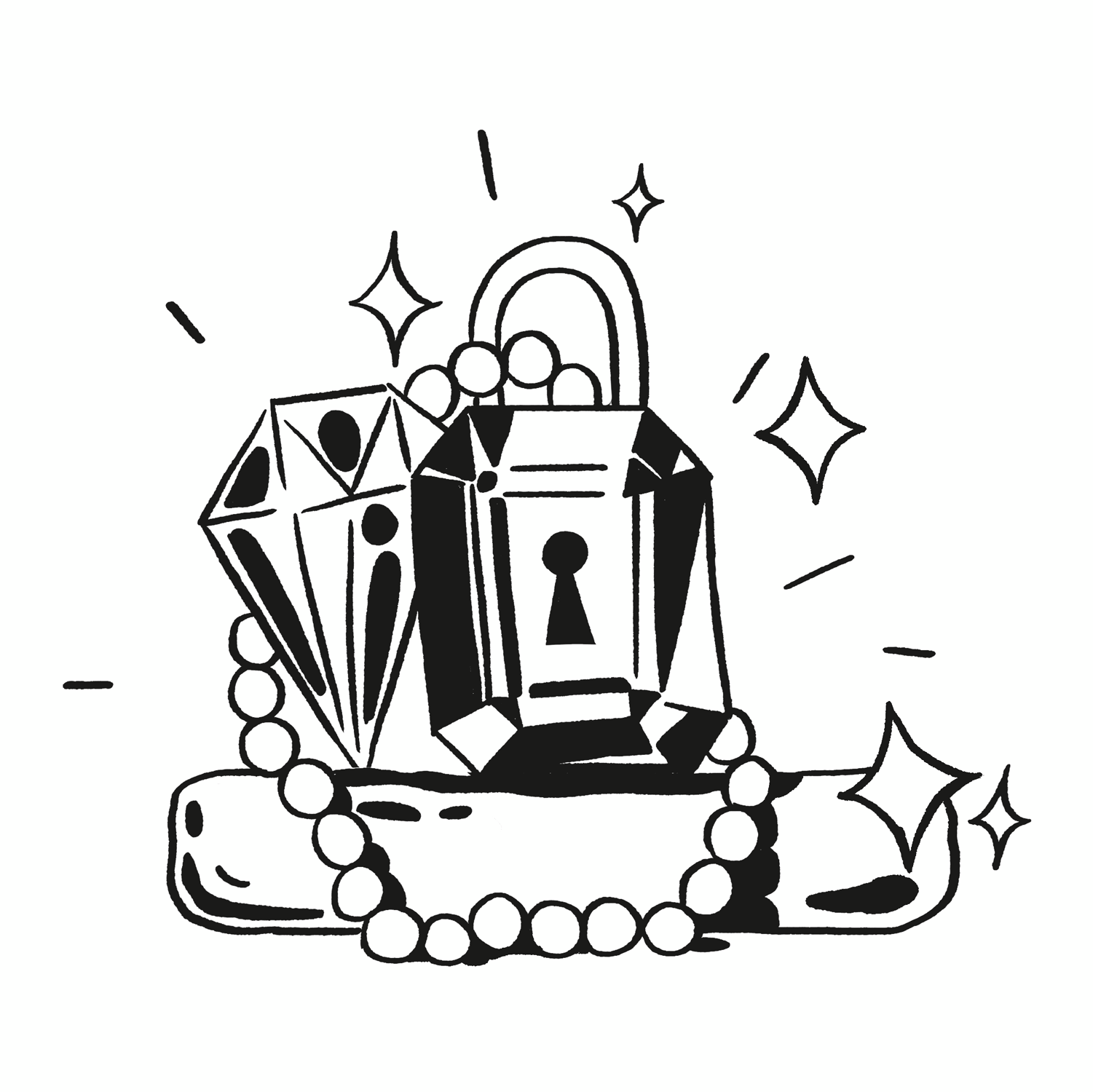Il mappamondo non s’è fermato mai un momento. Dal Cinquecento a oggi non ha mai smesso di girare su se stesso e di tracciare rotte, sogni e fortune. Prima come strumento di conoscenza e simbolo di potere, poi come oggetto di culto per collezionisti e investitori, che nella curvatura della sfera hanno intravisto il bagliore dell’affare. Già nel Cinquecento, quando la Terra sembrava dilatarsi a ogni spedizione, i globi erano un bene di lusso destinato a ricchi commercianti, astronomi, ricercatori, principi e monarchi; nel tempo quel valore non solo è rimasto intatto ma si è moltiplicato.
«Questi oggetti sono sempre stati costosi, in quanto frutto di una manifattura raffinata e di una accurata precisione scientifica coerente al loro tempo. Oggi lo sono ancora di più, vista la loro rarità. A differenza delle carte geografiche, spesso racchiuse negli atlanti e conservate con maggiore cura, i mappamondi sono stati infatti esposti alla luce e agli agenti esterni, dunque gli esemplari oggi disponibili sono limitati e molto preziosi», spiega a Moneta Cristiano Collari, responsabile del dipartimento Libri, manoscritti e autografi della casa d’aste Pandolfini.

Luoghi lontani
Ogni pezzo è una vera e propria opera d’arte e di ingegno: la realizzazione cominciava da una sfera di cartapesta, legno e gesso, talvolta rinforzata con metallo, sulla quale si incollavano le gore, sottili strisce di carta stampata e rastremata a mano, adattate con precisione millimetrica alla curvatura terrestre. Poi arrivavano i colori, stesi ad acquerello da pittori e incisori che raffiguravano terre, cieli e costellazioni, coprendo con cartigli decorati le zone ancora ignote del globo. Si tracciavano quindi gli equatori, i tropici, i meridiani e i circoli polari. E talvolta si aggiungevano dettagli sorprendenti, come piccole navi immerse tra le onde, animali esotici, figure allegoriche o scene di vita quotidiana, che trasformavano ogni emisfero in un racconto visivo completo.
«È importante ricordare che i mappamondi venivano sempre realizzati in coppia, con il globo terrestre assieme a quello celeste, sul quale erano indicate le costellazioni. Oggi è difficile trovarli insieme e chiaramente, quando questo accade, il valore può anche triplicare rispetto al singolo pezzo», puntualizza l’esperto. Nel Cinquecento, epoca d’oro della cartografia, il mappamondo divenne una meraviglia della scienza e dell’arte. Dall’olandese Willem Janszoon Blaeu, astronomo e stampatore che trasformò il globo in simbolo di prestigio, al veneziano Vincenzo Coronelli, frate cosmografo capace di creare sfere monumentali destinate a sovrani e cardinali, ogni maestro lasciò la propria impronta nella storia.
Sultani
«I globi di Coronelli oggi possono valere anche 250mila euro, se sono in coppia addirittura 700mila», annota Collari, citando anche altri casi in cui le quotazioni sono salite alle stelle. Alle principali aste internazionali si trovano infatti globi e sfere armillari (modelli tridimensionali composti da anelli) che superano 300mila euro. Totalizzano quotazioni straordinarie anche gli astrolabi, antichi calcolatori che servivano per localizzare le stelle: un modello in ottone realizzato per il sultano ottomano Bayezid II è stato ceduto per 1,5 milioni. E ancora, nel 2019 un globo terrestre di Coronelli del 1688 è stato battuto da Christie’s per oltre 670mila dollari, stabilendo un record assoluto per un esemplare del genere. Poco dopo, una sfera terrestre di Blaeu del XVII secolo ha raggiunto 600mila dollari in un’asta newyorkese. Benché fuori mercato, in quanto custodito in un museo, un mappamondo di Coronelli realizzato per re Luigi XIV di Francia ha segnato un ulteriore primato, se non altro nelle dimensioni: quattro metri di diametro.

«Sul valore influisce innanzitutto questo. I globi più sono grandi e più valgono. Conta ovviamente anche la conservazione e poi a pesare è la storia del singolo esemplare: se è appartenuto a un personaggio importante, la stima sale esponenzialmente», argomenta l’esperto di Pandolfini casa d’aste. A differenza di quanto accade nella filatelia e nella numismatica, tuttavia, gli errori di stampa non fanno l’unicità, né tanto meno il valore. «Nel Settecento alcuni globi riportavano una svista grossolana nella raffigurazione della California, erroneamente riprodotta come se fosse un’isola, ma questo equivoco non ha avuto peso sul mercato». Gli appassionati sono piuttosto attratti dalla finezza dei dettagli e dalla solidità dei materiali, che appagano sia il gusto estetico sia la prospettiva dell’investimento a lungo termine.

Così, mentre l’antiquariato attraversa un momento di evidente fatica (la contrazione delle vendite sul 2024 è già a doppia cifra), i mappamondi continuano a far girare gli affari e l’interesse del collezionisti, tra i quali è ben diffusa la consapevolezza che gli esemplari di valore in circolazione saranno sempre meno. In molti casi, infatti, in Italia le Sovrintendenze hanno riconosciuto il peso culturale dei pezzi più pregiati, sottraendoli così alle logiche di mercato. «Le cose belle non soffrono alcuna crisi. Se poi sono importanti e di buona provenienza, non c’è di che temere: faranno sempre grandi cifre».
© Riproduzione riservata