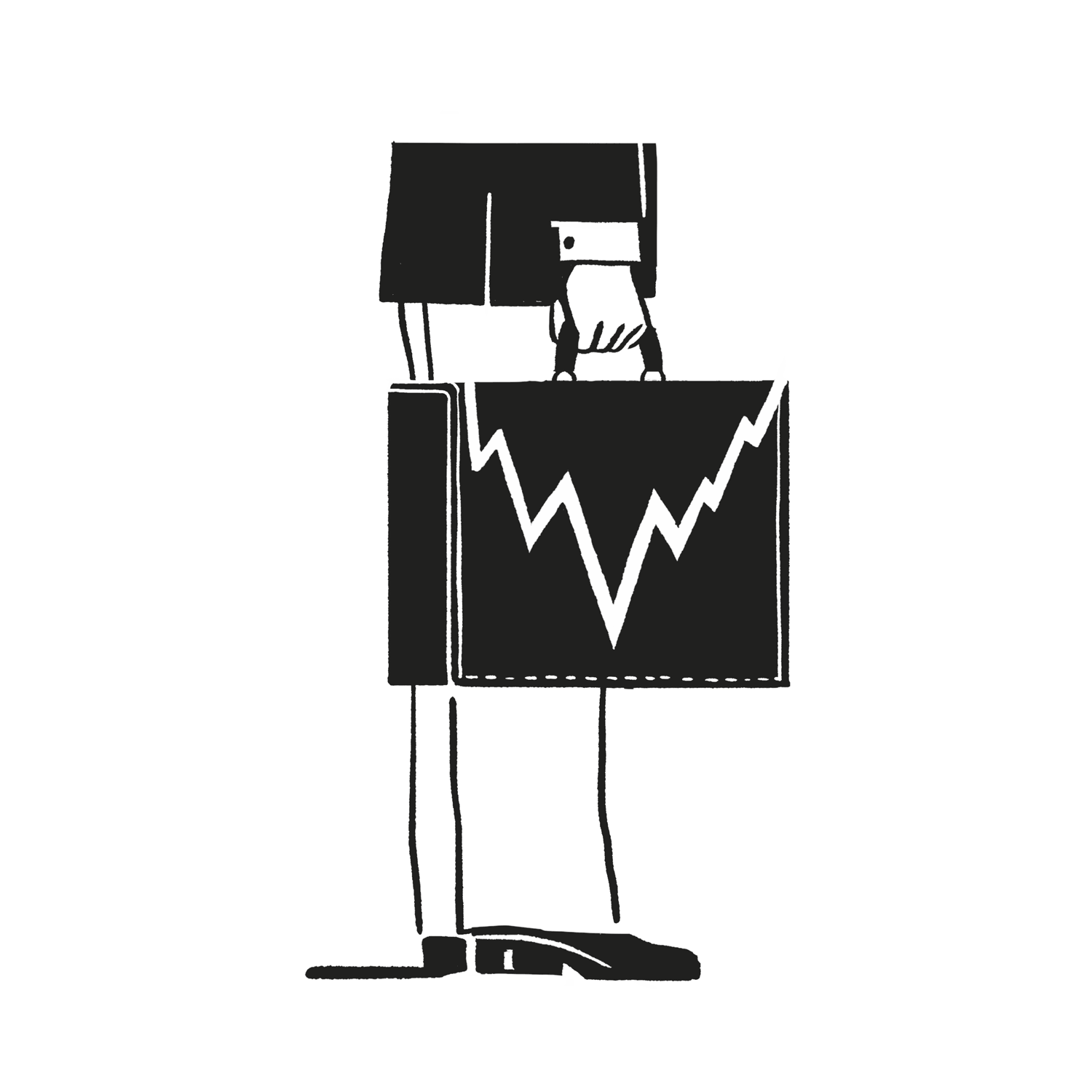Signor ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, quanto è davvero risorsa fondamentale la scuola?
«La scuola è una risorsa esistenziale di una civiltà ed è anche una fondamentale risorsa personale. Sono aspetti su cui mi sono soffermato più volte, in rapporto a parametri da recuperare come il merito, la responsabilità, il rispetto, i valori della nostra tradizione. Va aggiunto che investire nell’istruzione genera anche un prezioso ritorno economico. Accresce la competitività, quindi il Pil, quindi la ricchezza di una nazione. Ci sono due Nobel, Theodore Schultz e James Heckman, che hanno dimostrato come la ricchezza di un Paese sia direttamente proporzionale al suo livello di istruzione».
Anche in Italia?
«Ci sono stime di Confindustria secondo cui il mancato incontro tra domanda del sistema industriale e offerta del sistema scolastico – che non riesce a formare qualifiche corrispondenti alla richiesta del mercato del lavoro – genererebbe una perdita di Pil di 35 miliardi l’anno. E ci sono stime di Unioncamere con prospettive allarmanti: nel 2027, quasi metà del fabbisogno di qualifiche professionali richiesto non verrà soddisfatto dalla scuola. Con un fisco equo, poca burocrazia, investimenti in ricerca, la formazione delle persone è un pilastro su cui si regge lo sviluppo economico».
Come possiamo correre ai ripari?
«Serviva una svolta strategica. Innanzitutto, occorreva un recupero culturale di sensibilità e di motivazioni. Sotto questo aspetto la riforma del sistema tecnico-professionale, conosciuta come la riforma del 4+2, è stata la risposta attesa dalla fine del secolo scorso. Il raccordo tra sistema scolastico e sistema produttivo è stato demonizzato per ragioni ideologiche; il governo di centrodestra ha considerato prioritari il futuro occupazionale dei giovani e il bisogno di competitività del nostro sistema produttivo».
Cosa vuol dire quattro più due?
«Quattro (anziché cinque) anni di istituto tecnico o professionale, e poi, eventualmente, due anni presso le ITS Academy. Il tutto costruito in filiera».
In quale modo cambia il rapporto tra scuola e impresa?
«Le imprese, insieme alla scuola, contribuiscono a definire i curricula formativi. E qualora mancassero le competenze, la scuola può assumere tecnici, manager, dirigenti, imprenditori che insegneranno in percorsi specialistici, svolgendo il loro ruolo esattamente come un professore di italiano o di matematica».
Nella riforma del 4+2 avete introdotto anche le soft skills, che cosa sono?
«Sono delle competenze trasversali come, per esempio, apprendere la puntualità, il saper lavorare in squadra, il saper coordinare un gruppo di lavoro. Competenze essenziali per la formazione di una personalità responsabile, matura, capace di inserirsi nel mondo lavorativo».
Il successo della scuola dipende in gran parte dalla professionalità degli insegnanti. Per avere buone professionalità non servirebbero stipendi migliori?
«Sicuro. Aumentare gli stipendi è fondamentale, visto che sono rimasti fermi dal 2009 al 2018, quando una sentenza della Corte Costituzionale costrinse il governo dell’epoca a sbloccarli. Poi per altri 4 anni le trattative fra i successivi governi e i sindacati non portarono a nulla. Nel novembre 2022, in sole tre settimane, abbiamo raggiunto un accordo sulla parte economica per il contratto 2019-2021, chiudendo la vertenza con un aumento decoroso. Nella scorsa legge di bilancio abbiamo previsto risorse per i contratti fino al 2030. Ora stiamo ragionando sulla necessità di incrementare ulteriormente le risorse per il contratto 2025-2027».
Nuove tecnologie IA: devono entrare o restare fuori dalla scuola?
«Sono già entrate. Abbiamo investito 2,1 miliardi per digitalizzare tutte le scuole italiane; nell’anno 2021/2022 avevamo un rapporto di 1 device ogni 6 studenti, oggi ci avviciniamo a un rapporto di 1 ogni 2 studenti; abbiamo investito 450 milioni nella formazione digitale degli insegnanti; abbiamo introdotto, nelle nuove linee guida sull’educazione civica, anche l’utilizzo corretto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale; abbiamo avviato in alcune scuole, fra i primi in Europa, l’utilizzo di assistenti virtuali per personalizzare la didattica».
L’intelligenza artificiale inciderà anche sui rapporti di lavoro?
«Sì, molti lavori a bassa specializzazione spariranno, e aumenterà la richiesta di tecnici specializzati. Ci sarà lavoro sempre più qualificato e, quindi, più gratificante: e questo va sottolineato perché, soprattutto nei rapporti di lavoro, occorre tenere presente la centralità della persona. E dunque ancora una volta decisiva sarà la formazione».
Quanto siamo indietro nell’uso dell’intelligenza artificiale nella scuola?
«L’Italia è avanti: fra l’altro, proprio a Napoli terremo dall’8 al 13 ottobre il primo summit internazionale su IA e scuola. Nei giorni scorsi ho visitato in Calabria alcune scuole che hanno avviato in via sperimentale il programma di IA applicata alla didattica: i risultati sono estremamente confortanti».
E gli insegnanti?
«Hanno un ruolo decisivo: la scuola è innanzitutto una grande comunità umana dove il ruolo del docente è e sarà sempre fondamentale. Anche quando si utilizzano prodotti dell’intelligenza artificiale sono i docenti a programmarli e a utilizzarne i risultati e qui decisiva è la loro sensibilità, esperienza e competenza».
Non spariranno dalla scuola penna e quaderno?
«Carta e penna sono essenziali per un apprendimento di qualità. Lo dimostrano le ricerche pedagogiche e i dati statistici di agenzie come l’Ocse. Va poi considerato che secondo studi neurologici recenti le nuove tecnologie non riuscirebbero a stimolare alcuni settori cerebrali. Abbiamo così ribadito l’importanza della scrittura, del corsivo e dei diari cartacei e il carattere fondamentale della lettura di libri e dell’esercizio della memoria».
I ragazzi dovranno sempre più guardare a studi legati alla tecnologia e lasciare in secondo piano le materie tradizionali?
«Sarebbe un grave errore stravolgere le basi del sistema formativo. Una solida formazione nelle materie di base resta fondamentale. Per esempio, senza conoscere correttamente la lingua italiana è difficile avvalersi di un pensiero logicamente corretto e comunicativamente chiaro ed efficace, sia nei rapporti personali sia nei rapporti di lavoro; la matematica è fondamentale per il ragionamento scientifico e per la comprensione stessa delle nuove tecnologie; la storia ci serve per intendere il senso profondo del cammino dell’uomo e per comprendere i fenomeni che caratterizzano la società in cui viviamo».
Gli istituti tecnici non saranno più gli istituti cenerentola?
«Gli istituti professionali sono percorsi formativi fondamentali per la nostra società, per dare importanti opportunità occupazionali ai giovani, per garantire competitività al nostro sistema produttivo. Dunque si tratta di percorsi di importanza non minore rispetto ai licei. Tutti i percorsi formativi sono di pari livello e dignità come di pari dignità e pari livello sono le tante, diverse intelligenze di ogni giovane. Come sottolinea del resto la più recente letteratura psicologica».
Perché proibire i cellulari?
«Un conto è insegnare nell’educazione civica un uso corretto dei cellulari, un altro è difendere la salute e la qualità degli apprendimenti dei nostri giovani. Gli studi ci dicono che apprendere tramite cellulare dà risultati peggiori rispetto al modo tradizionale. Inoltre è assodato che l’abuso dei cellulari fra i giovani, oltre a creare dipendenza, danneggia creatività, fantasia e memoria».
Quanto l’uso dei cellulari in classe isola lo studente dal contesto formativo?
«Molto. E incide anche negativamente sulla autorevolezza e sulla autorità dell’insegnante: autorevolezza e autorità che sono due elementi centrali e fondanti della relazione formativa».
© Riproduzione riservata