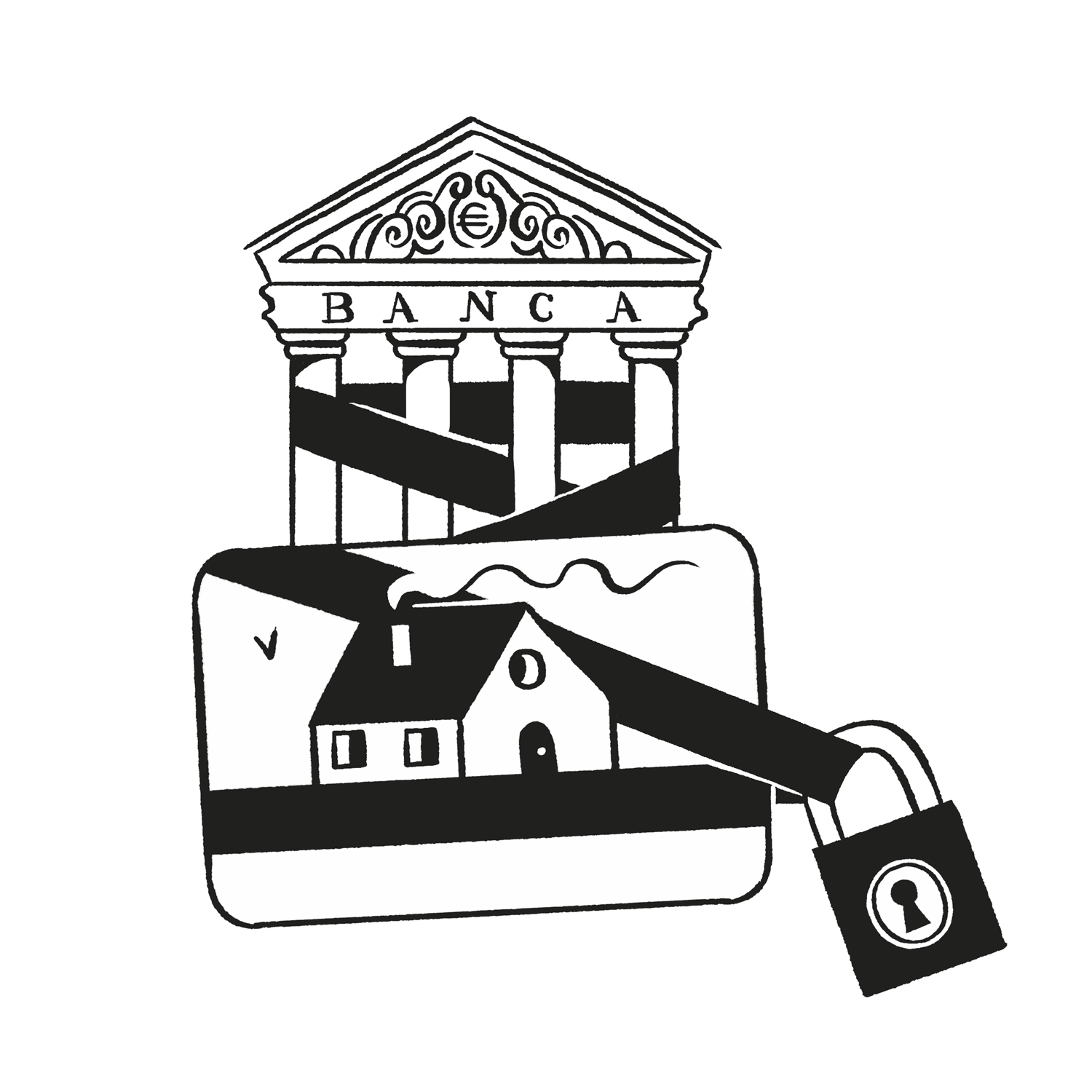Andare per boschi a «caccia» di prodotti di stagione ma anche a osservare il foliage, quel fenomeno spontaneo per cui alcune specie di alberi in autunno cambiano colore, passando dal verde al giallo, poi arancione, rosso e marrone. Un evento che trasforma la natura in un grande spettacolo, con un numero crescente di appassionati armati di scarponi e macchina fotografica. È un turismo che si sta sempre più diffondendo. Fa bene per lo svago e per la salute perché le passeggiate sotto gli alberi consentono di respirare aria pura e di portare in tavola cibi sani. Dai tartufi alle castagne fino ai funghi, le specialità del bosco spingono il turismo autunnale anche nelle sagre, con circa sette italiani su dieci che a fine anno avranno visitato almeno una delle centinaia di fiere enogastronomiche lungo lo Stivale secondo l’indagine Coldiretti/Ixè.
Per il 2025 Enit e Osservatorio Turismo stimano infatti un aumento del 20% dei viaggiatori che scelgono mete italiane per fare esperienze culinarie genuine. E il piatto di stagione più pregiato è senza dubbio il tartufo, la cui raccolta è entrata nel vivo con quotazioni che a inizio stagione sono state fissate in media a 4.000 euro al chilo per le pezzature tra 15 e 20 grammi alla 95° edizione della Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, che continuerà fino all’8 dicembre. Un valore iniziale in linea con gli anni passati che però nel 2024 è salito progressivamente per arrivare a 6.000 euro a dicembre, verso fine stagione. Quotazioni variabili si registrano lungo tutta la Penisola dove feste e sagre rappresentano comunque un’ottima occasione per fare buoni acquisti come la Fiera internazionale del tartufo bianco di Acqualagna in programma dal 1 al 23 novembre nelle Marche, giunta alla 60° edizione con valori che oscillano tra 1.500 e le 2.000 euro al chilo per il bianco pregiato, grazie a una stagione promettente. Ma ci sono anche la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato in calendario in Toscana dal 15 al 30 novembre e il 45° Salone nazionale bianco pregiato a Città di Castello, in Umbria, dal 31 ottobre al 2 novembre, quando si tiene anche la Mostra Mercato del tartufo bianco di San Pietro Avellana (Isernia) in Molise dove si raccoglie buona parte della produzione nazionale di tartufo bianco, e molte altre iniziative lungo la Penisola.
Il terreno
Opportunità da cogliere al volo perché le condizioni climatiche fino a ora hanno consentito una buona raccolta per il Tuber magnatum Pico che si sviluppa in terreni freschi e umidi. Dal Piemonte alle Marche, dalla Toscana all’Umbria, dall’Abruzzo al Molise, ma anche nel Lazio e in Calabria sono numerosi i territori battuti dai ricercatori. Il tartufo deve le sue caratteristiche (colorazione, sapore e profumo) alle radici degli alberi presso il quale si sviluppa come il pino, il leccio, il sughero e la quercia. La forma, invece, dipende dal tipo di terreno: se soffice il tartufo si presenterà più liscio, se compatto diventerà bitorzoluto per la difficoltà di farsi spazio. Il business del tartufo coinvolge in Italia una rete composta da circa 73.600 detentori e praticanti, chiamati tartufai, riuniti in 45 gruppi associati nella Federazione nazionale associazioni tartufai italiani (Fnati), da singoli tartufai non riuniti in associazioni per un totale di circa 44.600 unità e da altre 12 associazioni che, insieme con l’Associazione nazionale città del tartufo (Anct), coinvolgono 20.000 liberi cercatori e cavatori. La «Cerca e cavatura del tartufo in Italia» è entrata nel 2021 nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. Un’attività che sembra essere stata praticata già dai sumeri e che ancora oggi svolge una funzione economica a sostegno delle aree interne boschive dove rappresenta un’importante integrazione di reddito per le comunità locali, grazie ai flussi turistici.
Si avvia positivamente alla conclusione anche la stagione dei funghi per effetto delle condizioni meteo che hanno garantito nel 2025 una «buttata» da record in tutte le regioni. La nascita di porcini, chiodini, finferli e altre varietà richiede come condizioni ottimali terreni umidi senza piogge torrenziali, una buona dose di sole e 18-20 gradi nel bosco. Hobbisti e professionisti parlano di una ottima annata che ha consentito di rifornire tavole, negozi e ristoranti a condizioni convenienti. È necessario tuttavia seguire alcune regole che vanno dal rispetto di norme locali alla raccolta solo di funghi di cui si è sicuri. Mai fidarsi di detti e di luoghi comuni, ma rivolgersi sempre, in caso di incertezza, per controlli a Comuni o Unioni micologiche. Utilizzare cestini di vimini ed evitare buste di plastica.
Leggi anche:
Coldiretti: le spese militari non penalizzino l’agricoltura
Coldiretti: le spese militari non penalizzino l’agricoltura
I funghi rappresentano una risorsa importante per un Paese come l’Italia che può contare su oltre 11 milioni di ettari di bosco che copre il 40% della superficie del Paese, segnati spesso purtroppo da incuria e dall’azione criminale dei piromani. Ad attaccare il bosco sono anche gli insetti e gli organismi alieni portati dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione. Le castagne hanno infatti pagato un conto salatissimo per colpa del cinipide galligeno del castagno, il Dryocosmus kuriphilus, proveniente dalla Cina, che provoca nella pianta la formazione di galle, cioè ingrossamenti delle gemme, contro il quale è stata avviata con successo una capillare guerra biologica attraverso la diffusione dell’insetto Torymus sinensis, che è un antagonista naturale, anche se ci vorrà ancora tempo. Quest’anno in Puglia la produzione di castagne rischia un crollo fino al 90% a causa di questo insetto killer che ha azzerato la raccolta soprattutto nell’area del Gargano nella quale gli alberi secolari stanno seccando, mentre le piante più giovani stentano a dare frutti. Coldiretti evidenzia che all’attacco del cinipide si aggiunge la peronospora del castagno, la bruciatura fogliare, che fa cadere le foglie ma anche i ricci. La situazione è migliore in altre aree del Paese ma restano lontani i fasti produttivi del passato per quello che Giovanni Pascoli chiamava «l’italico albero del pane», simbolo dell’autunno. Nel 1911 la produzione di castagne ammontava a 829 milioni di chili, mentre negli ultimi anni è oscillata attorno ai 40-60. Il rischio è quello di trovare nel piatto, senza saperlo, castagne straniere provenienti soprattutto da Turchia, Grecia, Portogallo e dalla Spagna, considerato che le importazioni nel 2024 sono risultate pari a quasi 12 milioni di chili di castagne, spesso spacciate per italiane, con forti ripercussioni sui prezzi ai produttori. Da qui la richiesta di Coldiretti di assicurare più controlli sull’origine. Ancora peggiore è la situazione dei trasformati, per i quali non vi è l’obbligo di etichettatura di origine. Delle farine di castagne, per esempio, che non hanno un codice doganale specifico, sono totalmente sconosciuti i quantitativi importati.
Dop e Igp
Se non si vuole comunque correre il rischio di acquistare spesso a caro prezzo caldarroste straniere, la Coldiretti invita i consumatori a prestare attenzione alla qualità e suggerisce di ricorrere a un più genuino fai da te casalingo. Meglio allora frequentare i mercati degli agricoltori di Campagna Amica o le sagre, oppure rivolgersi alle imprese agricole e riscoprire il gusto di partecipare nei boschi alla raccolta delle castagne. Un modo anche per tutelare l’alta qualità della produzione made in Italy che conta ben 16 prodotti a denominazione di origine legati al castagno che hanno ottenuto il riconoscimento europeo.
Cinque si trovano in Toscana e sono il Marrone del Mugello Igp, il Marrone di Caprese Michelangelo Dop, la Castagna del Monte Amiata Igp, la Farina di Neccio della Garfagnana Dop e la Farina di Castagne della Lunigiana Dop; in Campania è riconosciuta la Castagna di Montella Igp, il Marrone di Roccadaspide Igp, il Marrone di Serino/Castagna di Serino Igp e la Castagna di Roccamonfina Igp; in Emilia Romagna il Marrone di Castel del Rio Igp, in Veneto il Marrone di San Zeno Dop, i Marroni del Monfenera Igp e i Marroni di Combai Igp; in Piemonte la Castagna Cuneo Igp e il Marrone della Valle di Susa Igp; e nel Lazio la Castagna di Vallerano Dop.
© Riproduzione riservata