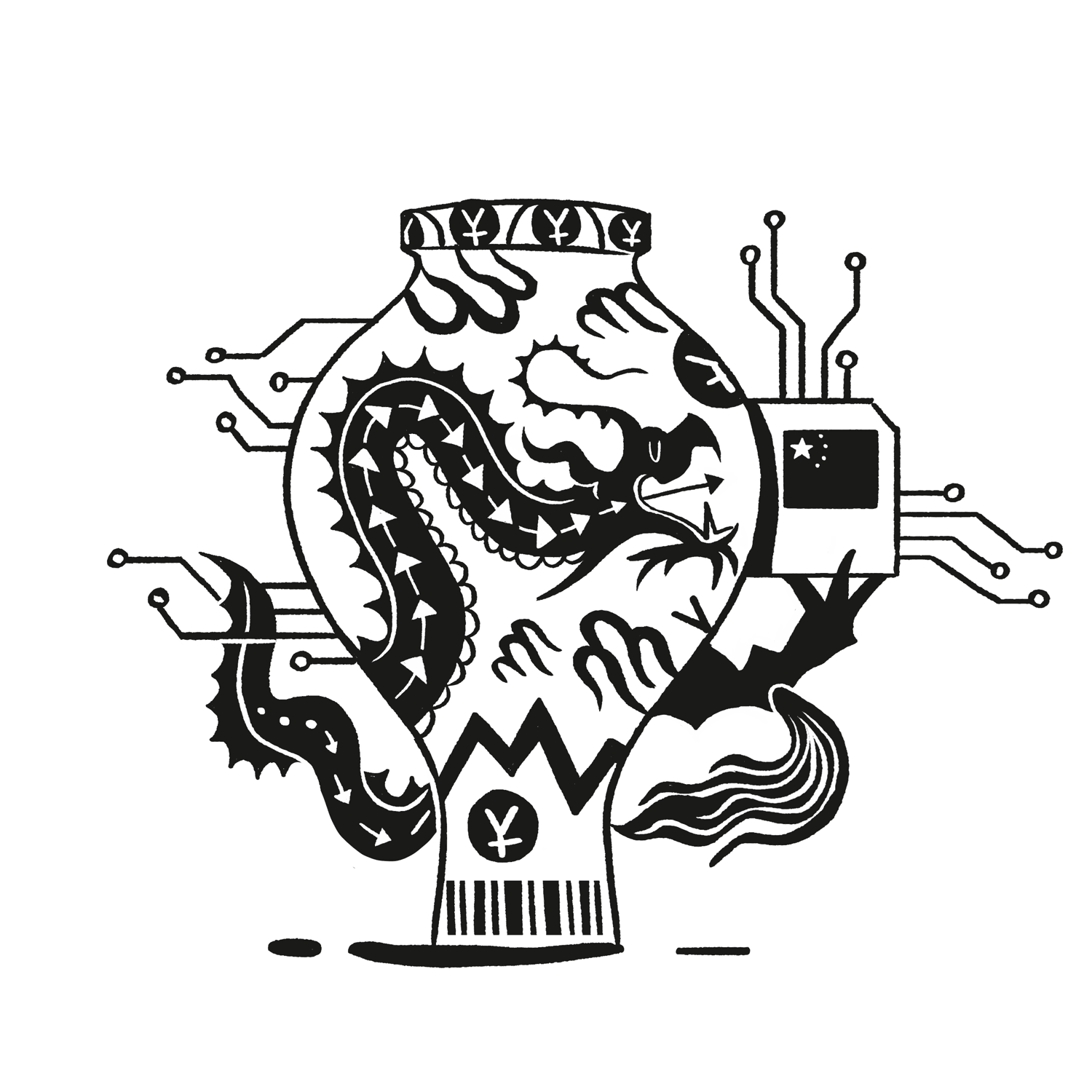Nella finanza italiana si assiste a un ossimoro apparente: strumenti complessi e derivati – i cosiddetti certificati di investimento – che si propongono come “green”, “ESG” o “sostenibili”. Ma quanto c’è di vero, e quanto invece è una trovata di marketing?
Cosa sono i certificati
Facciamo un passo indietro. I certificati di investimento (in inglese certificates) sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati, cioè titoli che incorporano uno o più contratti derivati e che vengono negoziati sui mercati regolamentati come il SeDeX di Borsa Italiana.
Secondo la definizione ufficiale di Borsa Italiana, i certificates «replicano, con o senza effetto leva, l’andamento di un’attività sottostante». In pratica, consentono all’investitore di partecipare all’andamento di un’azione, di un indice, di una materia prima, di un paniere o anche di una valuta – i cosiddetti sottostanti – senza acquistare direttamente quell’attività.
Esistono due grandi famiglie: i certificati senza leva (investment certificates), che offrono un’esposizione “uno a uno” al sottostante, spesso con protezione condizionata del capitale o rendimenti potenziali predefiniti, e i certificati a leva, che amplificano la performance del sottostante. Come spiega ACEPI, l’Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento, questi strumenti hanno un’ampia varietà di profili di rischio/rendimento. In Italia è un mercato è in forte crescita: secondo i dati di FocusRisparmio (2025), nei primi tre mesi dell’anno i volumi di collocamento dei certificati sul mercato primario hanno superato i 7 miliardi di euro, segnando un incremento del 33% rispetto al trimestre precedente.
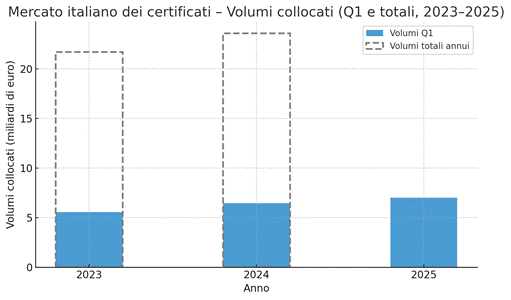
Fonte: Elaborazione su dati ACEPI (2023–2025) e FocusRisparmio (2025).
Green Certificates
Negli ultimi anni, anche il mondo dei certificati ha iniziato a tingersi di verde. Sempre più emittenti – tra cui BNP Paribas, UniCredit, Leonteq e Société Générale – propongono “ESG Certificates” o “Green Certificates”, prodotti che promettono di coniugare rendimento finanziario e criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Ma di cosa si tratta nel concreto?
In realtà, non esiste ancora una definizione normativa univoca di “certificato green”. Secondo le Linee guida ESG di ACEPI, si può parlare di prodotto sostenibile quando «il sottostante o la strategia d’investimento integrano fattori ESG o fanno riferimento a indici tematici coerenti con la finanza sostenibile».
In pratica, possiamo distinguere due categorie principali. La prima consiste in certificati con sottostanti ESG, cioè prodotti che replicano l’andamento di un indice o paniere di aziende selezionate secondo criteri ambientali o sociali. Esempi diffusi sono i certificati legati all’MSCI World ESG Leaders Index o a basket “green” composti da società come Enel, Iberdrola, Schneider Electric, Vestas Wind Systems. La seconda tipologia è invece costituita da certificati tematici o “ESG linked”, che non necessariamente hanno sottostanti sostenibili, ma il cui emittente dichiara un impegno a destinare parte dei proventi o delle emissioni a progetti con finalità ambientali o sociali.
Regole in evoluzione per i prodotti ESG
E qui nasce il grande interrogativo: quanto “verde” è davvero un certificato che comunque rimane un prodotto strutturato, con barriere, leve, rischi emittente e scadenze? Bisogna considerare innanzitutto che non esiste ancora un sistema uniforme e regolamentato che definisca cosa sia precisamente un “certificato ESG”, come invece accade per i green bond o altri strumenti sostenibili. Nel 2022 ACEPI ha pubblicato le proprie Linee guida sui criteri ESG per i certificates (citate in precedenza), un documento di autoregolamentazione che indica principi comuni di sostenibilità per gli emittenti italiani. Si tratta però di un passo volontario del settore, in attesa di una vera normativa europea vincolante che disciplini in modo uniforme la classificazione dei prodotti strutturati “green”.
È poi importante ricordare inoltre che il profilo di rischio/rendimento non cambia solo perché il prodotto è sostenibile. L’investitore può essere attirato dalla narrativa ESG, ma deve capire che è comunque esposto al sottostante, alle condizioni strutturate, al rischio che la barriera non venga rispettata. C’è infine il rischio di greenwashing: comunicare un intento “green” senza che il cambiamento reale (scelta del sottostante, impatto ambientale, trasparenza) sia significativo.
La finanza sostenibile ha ormai aperto le porte anche al mondo dei certificati. Ma “green” non significa automaticamente “a basso rischio” né “etico” nel senso tradizionale del termine. Per chi investe, i certificati ESG possono rappresentare una soluzione ibrida: più accessibili rispetto all’investimento diretto in green equity o infrastrutture, ma più complessi rispetto a un semplice fondo ESG. In un’epoca in cui i risparmiatori chiedono rendimento e senso, i certificati “verdi” possono quindi essere un primo passo verso una finanza più consapevole. Ma è necessario che la narrazione sia sostenuta da trasparenza, rigore e chiarezza, altrimenti il rischio è che il prodotto appaia “verde” solo nella carta, e non nella sostanza.
© Riproduzione riservata