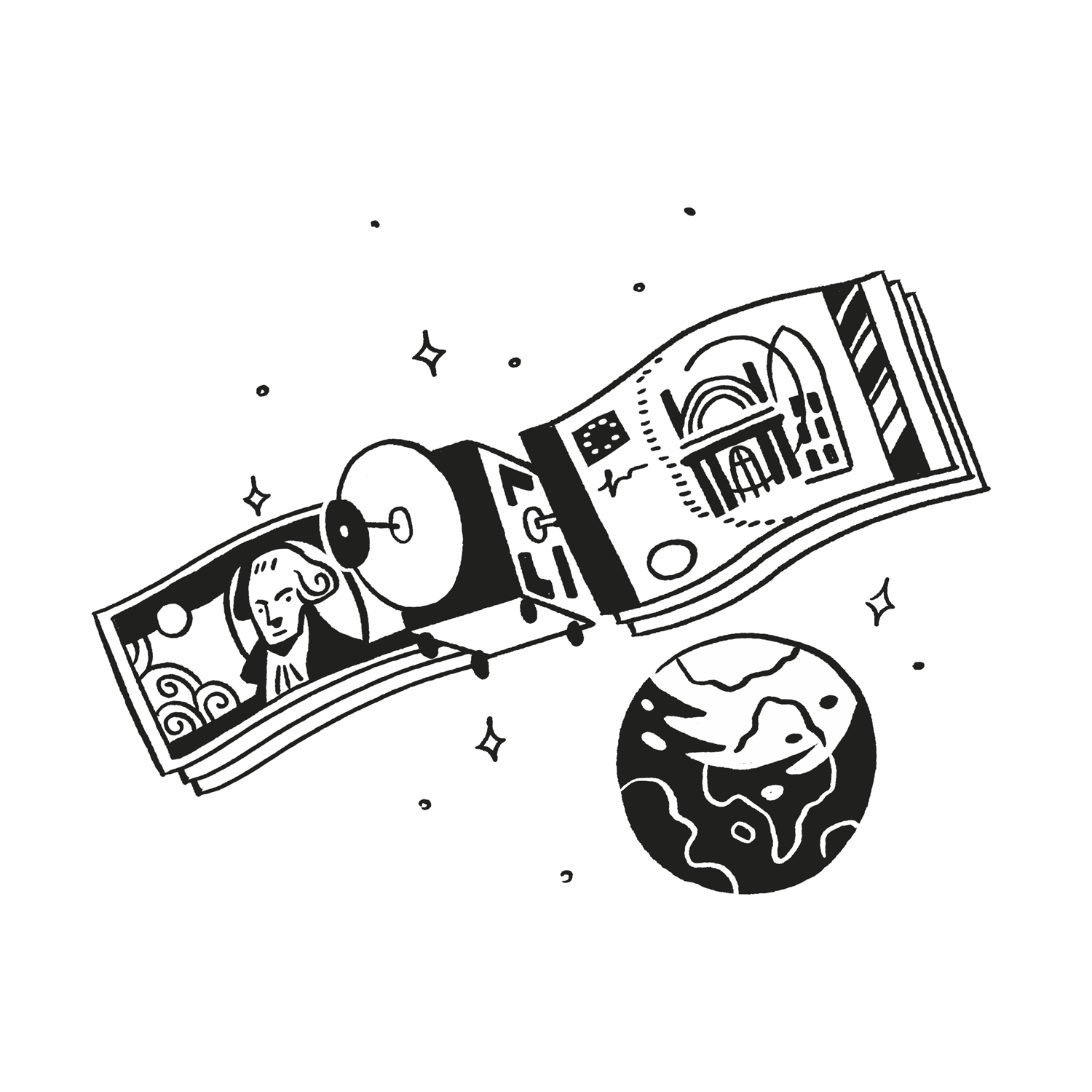Impazza la Vinted-mania. E lo scoppio della passione per l’abbigliamento usato non sfugge ai radar del Fisco, tra furbetti che cercano di aggirare le regole e privati che temono di venire stangati senza aver fatto nulla di male.
L’app lituana che ha reso popolare la “seconda mano“ nel 2024 ha visto i ricavi salire del 36% rispetto all’anno precedente e registrato una crescita del 330% dei profitti che hanno raggiunto i 76,7 milioni di euro. Nella sua corsa ha tirato la volata anche ai competitor: portali storici come eBay (amato dai collezionisti in cerca di pezzi unici e famoso per le sue aste) e Subito.it (dove si vendono pure auto, moto e appartamenti), la spagnola Wallapop, in Italia ancora poco diffusa ma amatissima nella Penisola iberica, e Vestiaire collective, specializzato nei prodotti di lusso, a partire dalle borse di grandi marchi come Louis Vuitton, Gucci e Chanel.
Così, dopo anni sotto traccia, il boom del comparto è finito sotto la lente del Fisco, tanto che dal 2023 è iniziata la stretta con l’approvazione della direttiva europea Dac7. In linea generale, in Italia chi vende usato in modo occasionale non deve pagare tasse. L’esempio più banale è quello delle auto: chi vende una singola vettura usata non versa imposte anche se l’importo può essere molto elevato. Ma il boom del second hand online ha spinto Bruxelles a introdurre meccanismi ad hoc per controllare che i negozi non usino le piattaforme come una scorciatoia per aggirare le leggi e per impedire che i privati aprano vere e proprie boutique virtuali non registrate sulla scia del fenomeno del reselling, ovvero l’acquisto sistematico di capi usati, magari a tiratura limitata (è passato agli annali il caso delle sneakers Lidl), destinati a essere rivenduti a un prezzo superiore.
Lo strumento alla base del sistema di controllo è appunto il modulo Dac7: un certificato che Vinted & Company inviano a chi supera uno soglia «sospetta» di vendite. Un limite molto risicato: per finire sotto la lente basta aver fatto 30 vendite in un anno o aver incassato più di 2.000 euro a prescindere dal numero di transazioni. Chi rifiuta di compilare la Dac7, che viene inserita automaticamente nel proprio cassetto fiscale, si vede bloccare l’armadio.
Ma una volta sforato il limite cosa succede? La palla passa al Fisco, che deve fare una verifica e decidere se l’attività di vendita è occasionale (e quindi esentasse) o se si può considerare un vero e proprio commercio: in questo caso i redditi omessi possono essere segnalati in automatico dall’Agenzia, con lettere di compliance dirette ai contribuenti.
Ma quali sono i criteri per capire se le vendite sono occasionali oppure no? L’Agenzia delle entrate si baserà sui volumi, sulla serie storica (controllando più attentamente chi vende molto per molti anni di fila) o sugli incassi? Il rischio è che chi vende tanti pezzi ogni anno ma per piccole cifre (su Vinted si parte da 1 euro al pezzo) per cercare di racimolare qualcosa si trovi costretto o a pagare o a rivolgersi a un commercialista per non trovarsi una cartella nella buca delle lettere.
Pure le piattaforme stanno stringendo le maglie. Vinted ha introdotto anche in Italia la categoria dei «seller pro», dotati di partita Iva e tenuti a seguire regole diverse su resi e rimborsi rispetto ai privati: nei forum dedicati sui social in molti lamentano di essere stati contattati dall’app che ha intimato loro di diventare «pro», pena la sospensione del profilo. Fra i segnali sospetti, secondo la piattaforma, la presenza di molti capi nuovi con cartellino.
Il difficile è trovare un equilibrio fra la necessità di stanare i furbetti e il rischio di stangare chi non se lo merita. Un tema toccato anche dal rapporto Eurispes Il Fisco nel mondo virtuale: un universo senza regole, che analizza proprio il problema dei redditi digitali. Come sottolinea il rapporto, «la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate hanno peraltro già avviato, in questi ultimi anni, una serie di indagini, per scovare i falsi venditori occasionali, che dovrebbero iscriversi come venditori professionali, aprire un account business e dichiarare al Fisco le somme percepite. Il “trucco”, in sostanza, è iscriversi alle piattaforme come venditori occasionali, mentre in realtà viene posta in essere una vera e propria rivendita professionale».
Il rapporto fa anche esempi concreti, come quello di un uomo residente a Gorizia arrestato dalle Fiamme gialle che, nonostante non dichiarasse alcun reddito, ostentava un tenore di vita piuttosto elevato e aveva acquistato un’automobile da più di 41mila euro e un’abitazione da 110mila euro. I guadagni arrivavano proprio da siti di aste online a cui l’uomo si era iscritto come venditore occasionale, mentre in realtà portava avanti una rivendita professionale di cellulari, tra l’altro contraffatti e provenienti dall’estero, incassando 600.000 euro grazie a oltre 26.000 transazioni. In un altro caso scovato sempre dalla Gdf a Ventimiglia, il reddito non dichiarato era di 1,3 milioni di euro grazie a un giro di vendite online di oggetti di vario tipo, dai prodotti tecnologici alle opere d’arte.
Sul tema si è espressa anche la Cassazione con la sentenza numero 7552 pubblicata il 21 marzo 2025. La Corte ha stabilito che anche un privato senza partita Iva che effettua numerose vendite sulle piattaforme digitali per un periodo prolungato può essere considerato un imprenditore a fini fiscali (quindi con l’obbligo di dichiarare i guadagni e pagare le tasse). Secondo i giudici, l’abitualità e la continuità intrinseche nel fatto di effettuare un elevato numero di vendite online per diversi anni sono requisiti sufficienti per configurare la produzione di redditi d’impresa.
In Italia, il mercato dell’usato vale circa 27 miliardi, come dimostra un’indagine dell’Osservatorio Second Hand Economy condotto da Bva Doxa per Subito.it. Per chi rivende il guadagno medio è di circa 850 euro l’anno. E il comparto online è schizzato del 140% in dieci anni.
© Riproduzione riservata