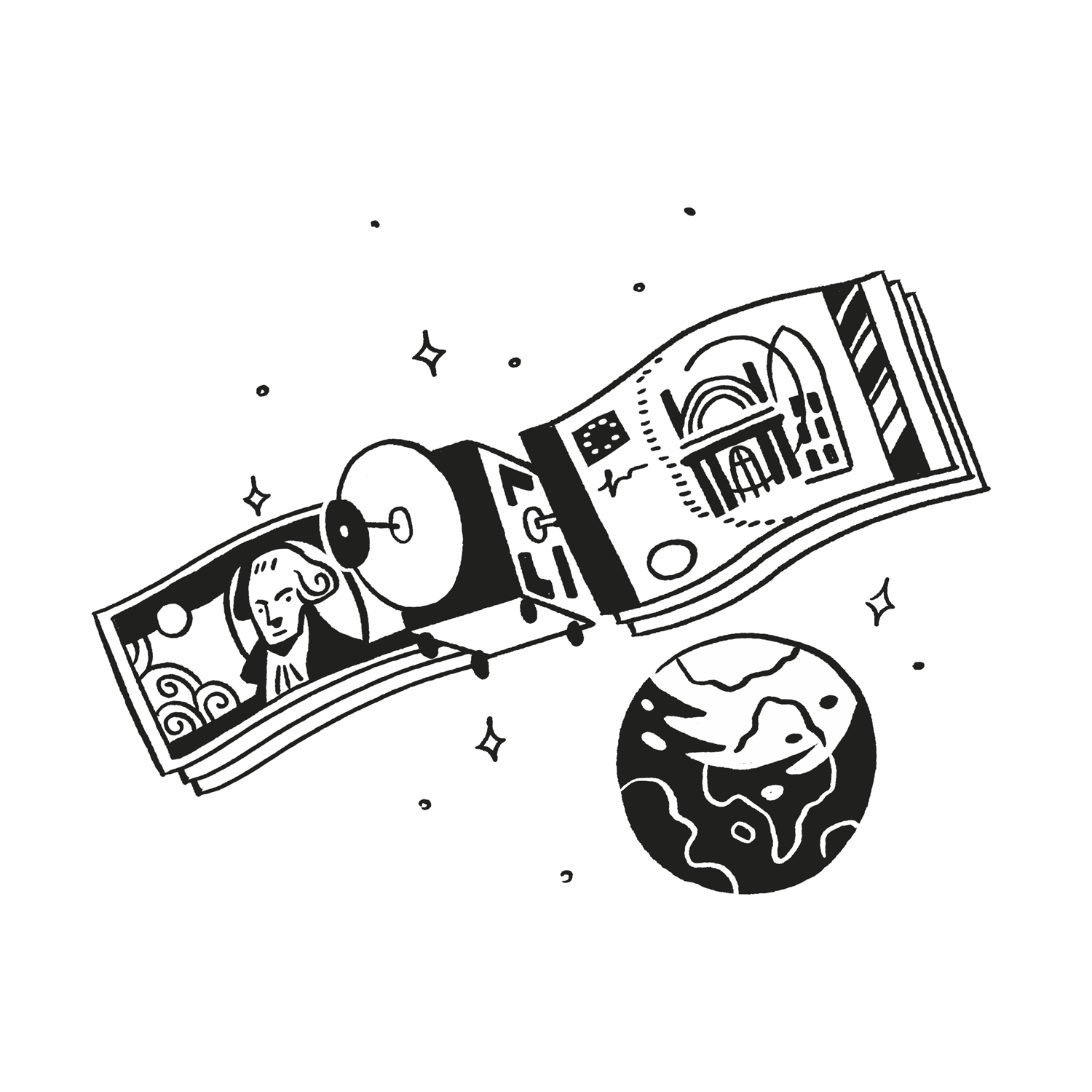Il 3 luglio 2013, pochi mesi dopo l’elezione, Papa Francesco convocò i cardinali a porte chiuse: «Se non sappiamo custodire i soldi, come custodiamo le anime?», disse, denunciando investimenti in attività non coerenti con l’etica cristiana. In poco tempo si era reso conto di avere ereditato una Chiesa in crisi morale e finanziaria. Gli scandali avevano minato la credibilità della Curia e reso opache le strutture amministrative, mentre le finanze vaticane parevano un labirinto caotico, ostaggio di logiche medievali. Avrebbe dovuto avviare una lunga opera di risanamento, sapendo che sarebbe stata ostacolata da forti resistenze interne. Era l’inizio della sua battaglia contro una gestione non conforme ai principi evangelici. Così, attraverso il Motu proprio dell’agosto 2013, Francesco impresse un’accelerazione alla riforma avviata da Benedetto XVI, istituendo da subito l’Autorità di informazione finanziaria (Asif), con funzioni di vigilanza prudenziale e trasparenza patrimoniale. Centrale fu anche l’adeguamento delle pratiche alle norme internazionali contro riciclaggio, finanziamento al terrorismo e minacce alla pace: un’ammissione implicita delle carenze passate.
Il risanamento finanziario non partiva da zero: nel 2009 il Vaticano aveva firmato la Convenzione monetaria con l’Ue. Francesco accelerò la riforma nel 2014 riorganizzando lo Ior (Istituto per le Opere di Religione), banca vaticana posta sotto vigilanza Asif, che rimase fornitore di servizi finanziari specializzati per la Chiesa. Nel 2015 aderì alla normativa Usa Fatca per combattere l’evasione fiscale, uscì dall’elenco statunitense dei paradisi fiscali, entrò nell’area Sepa (pagamenti euro) nel 2019 e nel 2021 ottenne il giudizio positivo di Moneyval per i presidi antiriciclaggio. Migliaia di conti furono chiusi: dal 2013 i clienti (oggi 12mila) devono far parte della Chiesa o servirla. Persino un devoto come Giulio Andreotti oggi non potrebbe più aprire un conto.
Il 30 settembre 2022 Francesco firmò un Rescriptum epocale: tutti i fondi dei dicasteri vaticani dovevano essere trasferiti allo Ior, anche quelli di organismi potenti come Propaganda Fide e i Musei Vaticani. L’obiettivo: aumentare la trasparenza e garantire liquidità. A fine 2023 lo Ior gestiva 5,4 miliardi di euro con un utile netto di 30,6 milioni. Eccellenti gli indici di solidità con un Tier 1 ratio al 59,8% e un cost/income al 48%. Lo Ior è guidato da una commissione cardinalizia presieduta da Christoph Schönborn della quale fanno parte, tra gli altri, due papabili Luis Tagle e Konrad Krajewski. Il consiglio di sovrintendenza, l’equivalente del cda, è presieduto da Jean-Baptiste de Franssu, ex manager di Invesco mentre la guida operativa è affidata a Gian Franco Mammì, uomo di fiducia di Francesco sin dai tempi di Buenos Aires.
Il Rescriptum del 2022 mirava anche a separare i ruoli: lo Ior per l’asset management, l’Apsa per il real estate. L’Amministrazione del Patrimonio della sede Apostolica (da cui l’acronimo Apsa) gestisce oltre 4.000 immobili e un portafoglio mobiliare da 1,8 miliardi. Nel 2023 ha realizzato un utile di 45,9 milioni, 37,9 dei quali versati direttamente al Papa. Dal 2023 è guidata da Giordano Piccinotti, salesiano con una lunga esperienza finanziaria all’interno della compagine istituita da Don Bosco. La nuova divisione di compiti ha ridotto l’autonomia finanziaria dei dicasteri e prevenuto nuovi scandali. Come quello del palazzo di Sloane Avenue a Londra la cui acquisizione da parte della Segreteria di Stato, finanziata con l’Obolo di San Pietro, avrebbe determinato una perdita superiore a 100 milioni. Occorre, tuttavia, sottolineare che fra Ior e Apsa vi è una leggera sovrapposizione. Uscito da Intesa Sanpaolo nel 2010 (aveva lo 0,23%), quota che testimoniava il contributo al salvataggio del Banco Ambrosiano, l’unica partecipazione dell’Istituto è la Sgir, una srl immobiliare romana interamente controllata che ha un patrimonio di 26,9 milioni e ha determinato 2,2 milioni di ricavi e un utile di 872mila euro nel 2023. Tra le sue attività anche la concessione di immobili a canone calmierato a istituzioni religiose e la predisposizione degli stessi per attività caritatevoli e di accoglienza.
Nonostante i progressi, la rivoluzione culturale auspicata da Francesco non è ancora compiuta in quanto lo Ior, sebbene le indicazioni siano state in larga parte seguite, è ancora di là dall’essere l’unica banca depositaria delle istituzioni cattoliche. Il nuovo Papa dovrà completare l’opera perché, come ricordava Francesco nel 2013, custodire bene i beni visibili è il primo passo per essere credibili custodi di quelli invisibili.
© Riproduzione riservata