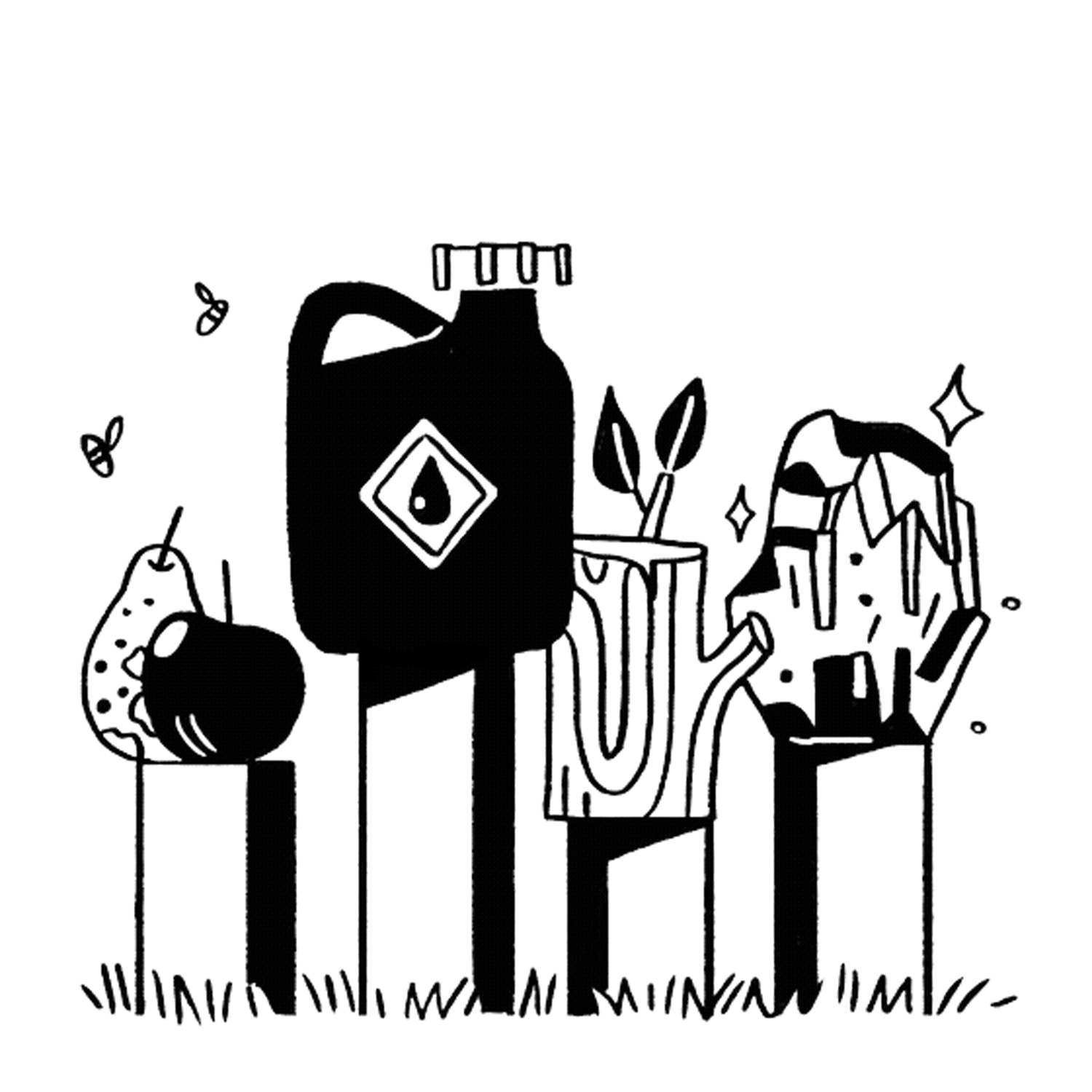C’è un intreccio che unisce alta finanza, geopolitica mediorientale e rivalità personali ai vertici del potere americano. JP Morgan starebbe valutando la possibilità di fornire servizi bancari al cosiddetto “Board of Peace”, concepito inizialmente per creare un quadro di governance per Gaza all’indomani della guerra tra Israele e Hamas e oggi sempre più presentato come un’alternativa operativa alle Nazioni Unite. Una prospettiva che assume un peso politico particolare perché il Board viene attribuito all’iniziativa di Donald Trump, mentre l’ex presidente ha recentemente citato in giudizio l’amministratore delegato della banca, Jamie Dimon, accusando l’istituto di aver chiuso i suoi conti per ragioni politiche.
Il paradosso è evidente: da un lato lo scontro legale e simbolico tra Trump e uno dei banchieri più influenti d’America; dall’altro la possibilità che la maggiore banca statunitense per attivi diventi partner finanziario di un organismo promosso proprio dall’ex presidente. Ma nella logica della realpolitik finanziaria, le grandi banche lavorano con le istituzioni che contano, indipendentemente dalle tensioni personali. Se il Board of Peace dovesse davvero gestire fondi per la ricostruzione, coordinare flussi multilaterali e attrarre investimenti privati, avrebbe bisogno di una struttura bancaria solida: conti istituzionali, gestione della liquidità, compliance internazionale, emissioni obbligazionarie, advisory per progetti infrastrutturali.
La posta in gioco è alta. Gaza rappresenta uno dei dossier più complessi del sistema internazionale: distruzioni diffuse, crisi umanitaria, equilibrio politico fragile. Tradizionalmente, la governance post-bellica passa attraverso meccanismi multilaterali guidati dall’Onu o sostenuti da Banca Mondiale e fondi fiduciari internazionali. Un organismo alternativo, con un’impronta statunitense marcata e un coinvolgimento diretto della grande finanza privata, segnerebbe una svolta nel modo di intendere la ricostruzione: meno centrata sugli aiuti pubblici, più orientata a strumenti finanziari e capitali privati.
Per JP Morgan si tratterebbe di un’operazione ad altissimo profilo, ma anche ad alto rischio reputazionale. Operare in un contesto geopolitico così sensibile significa esporsi a tensioni diplomatiche, pressioni politiche e potenziali controversie legali. Al tempo stesso, il messaggio ai mercati sarebbe chiaro: la banca è pronta a dialogare con qualsiasi architettura di potere che emerga, mantenendo un ruolo centrale nei grandi flussi globali di capitale.
Resta il nodo politico. Trump sostiene che la chiusura dei suoi conti sia stata una scelta ideologica, parte di una più ampia discriminazione nei confronti di figure conservatrici. JP Morgan ha sempre respinto accuse di natura politica, richiamando procedure interne e standard di rischio. Se ora le due parti dovessero incrociarsi sul terreno della governance internazionale, il conflitto personale potrebbe trasformarsi in una cooperazione istituzionale forzata.
Leggi anche:
JP Morgan accetterà bitcoin a garanzia dei prestiti
Jp Morgan: l’Ia darà frutti ma parte degli investimenti andrà perso
© Riproduzione riservata