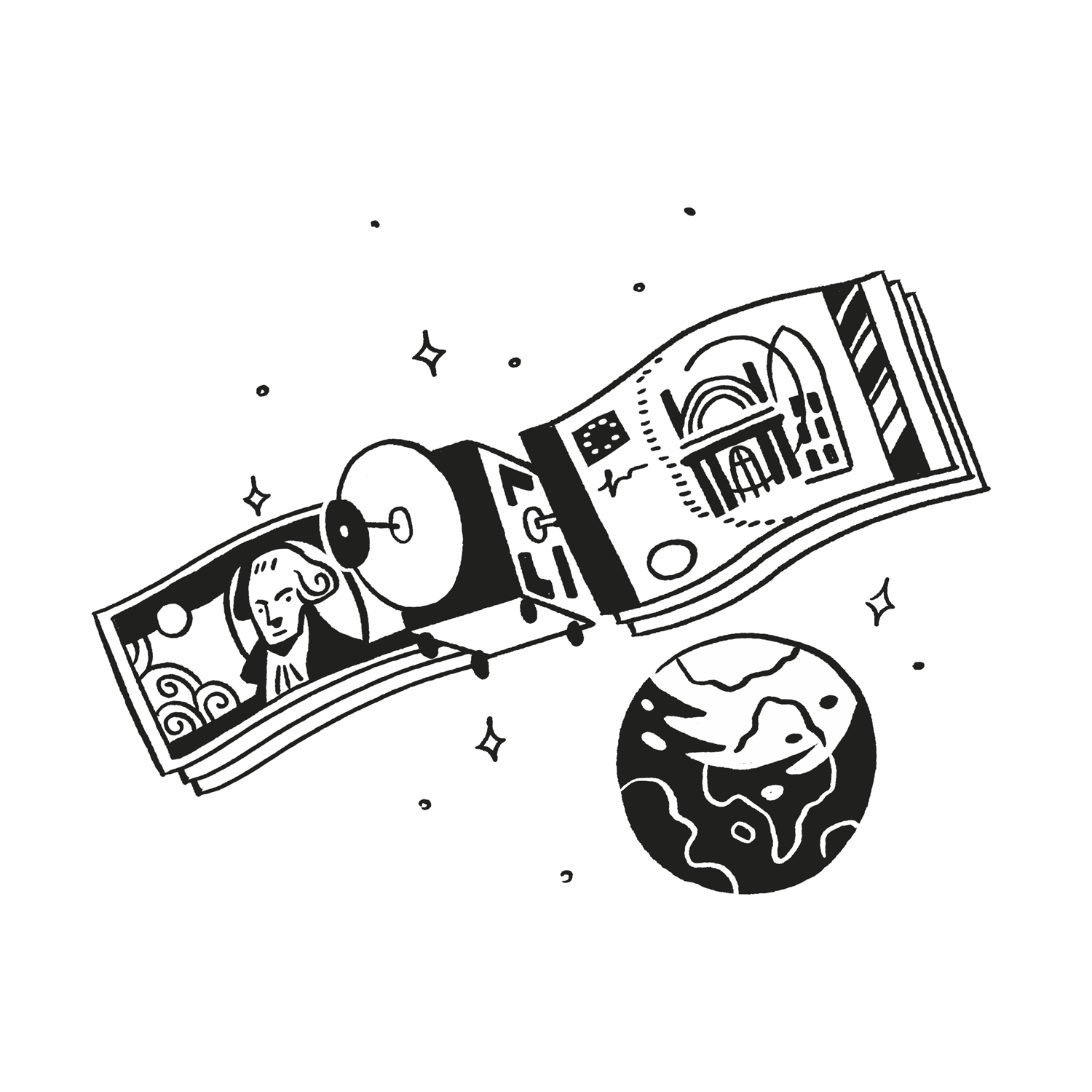Fisico teorico, ricercatore, manager di lungo corso. Dal 2009 amministratore delegato di Pininfarina, Silvio Pietro Angori racconta a Moneta il percorso che ha condotto l’iconica azienda italiana dal mondo dell’auto a una dimensione globale del design, capace di abbracciare architettura, tecnologia, mobilità e innovazione.
Da fisico teorico e ricercatore a manager. Un percorso molto intenso, anche un po’ atipico, no?
«Abbastanza, lo ammetto. Ma quando ho sentito la necessità di virare la mia carriera nel mondo dell’industria e della ricerca applicata è stato un viaggio naturale. Ho continuato gli studi negli Stati Uniti, svolgendo un Mba, e ho capito che dovevo occuparmi della gestione a 360 gradi di un’azienda: da quella operativa e strategica a quella finanziaria. E come potevo farlo? Assumendomi delle responsabilità sempre crescenti».
Responsabilità che sono arrivate con la chiamata di Pininfarina.
«Esatto. Prima come direttore generale (nel 2007), poi come amministratore delegato. Una scelta che non ha fatto altro che soddisfare una delle mie più grandi ambizioni: poter influire davvero sulla creazione di valore e sulla gestione delle persone».
Da quando ha preso il volante, tante cose sono cambiate. Anche il vostro business di riferimento. Non più legato solo all’automotive, anzi.
«È stata una transizione essenziale e naturale. Non potevamo più guardare solo alle auto, anche perché era evidente che il settore della costruzione di veicoli per conto terzi stava morendo e i numeri lo dimostravano. Basti pensare che i ricavi si attestavano a 1,2 miliardi di euro e i debiti a circa 900 milioni. Avevamo quindi l’obbligo di guardare a tutte le sfaccettature del design: dalla mobilità e i trasporti fino ad arrivare all’architettura e alla nautica, preservando però i nostri valori fondanti: creatività, bellezza, unicità e soprattutto made in Italy».
Un’operazione complessa.
«E anche dolorosa. Ma è stata necessaria. Sia per proteggere i nostri dipendenti, anche laddove le prospettive non potevano più essere interne all’azienda, sia per i nostri creditori. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo affrontato le difficoltà e abbiamo concentrato le nostre energie sul nostro valore distintivo: il design. E ci siamo riusciti».
L’automotive però non lo avete abbandonato. Anzi, se dovesse scegliere un progetto di cui va più orgoglioso quale ricorderebbe?
«La Pininfarina Sergio, un’auto sviluppata per Ferrari nel 2013 (come omaggio a Sergio Pininfarina, scomparso nel 2012). Lo scelgo principalmente per un motivo: perché essendo un progetto “garibaldino”, dato che sono stati prodotti solo sei esemplari, ha dimostrato che esiste un mercato per le piccolissime serie esclusive. Da lì quindi è nato un nuovo posizionamento come partner privilegiato per i grandi marchi internazionali. Ma non ci siamo fermati all’auto: oggi sviluppiamo progetti in settori molto diversi, dall’architettura agli spazi pubblici. Questo perché i nostri designer e ingegneri sanno creare esperienze fisiche e digitali – oggi diremmo “phygital” – capaci di suscitare emozioni uniche».
Quindi, cosa è oggi Pininfarina?
«Oggi siamo tre cose: una società di design, un produttore di auto in piccolissima serie e un brand che aggiunge valore ai progetti e ai prodotti dei clienti. La qualità dei nostri designer è riconosciuta, ma ciò che ci distingue è anche la nostra etica. I partner vogliono lavorare con noi, spesso chiedendoci di firmare in esclusiva i loro prodotti. Siamo forse l’unica azienda con questa specificità. E lo dimostra il fatto che pur non avendo un prodotto, ma disegnando per gli altri, tuttavia ricaviamo il 5% del fatturato dal nostro marchio».
Le tensioni geopolitiche attuali stanno riscrivendo le regole del gioco. Che impatto hanno avuto su di voi?
«Dal Covid in poi, tra guerre e dazi, possiamo dire che si sta creando una nuova pagina di storia. In tal senso, però bisogna ricordare una cosa: l’Italia ha una sua unicità: siamo la patria del bello e del ben fatto. Siamo tutti figli di Leonardo, capaci di unire estetica e tecnologia in modo irripetibile. Certo, i dazi e le incertezze hanno bloccato lo sviluppo di nuovi prodotti per molti clienti, rallentando i cicli. Ma siamo resilienti e siamo ben posizionati per superare la tempesta».
Tralasciando tutti questi fattori esterni, qual è stato secondo lei l’errore che ha mandato in tilt il mondo dell’automotive italiano ed europeo?
«L’imposizione dogmatica delle tecnologie. Mi spiego meglio: va bene fissare dei limiti in termini di emissioni, ma imporre le tecnologie per raggiungere gli obiettivi è stato un errore abbastanza rilevante. Anche perché i consumatori devono essere liberi di comprare quello che vogliono. Una libertà che deve essere concessa anche alle aziende nel raggiungere quei determinati obiettivi. In questa direzione, quindi, è positivo che l’attuale governo stia mostrando maggior attenzione a tutto il comparto. Sono fiducioso».
Ma quindi come immagina il futuro di Pininfarina?
«Partendo dal presupposto che prevediamo una crescita dei ricavi e questo è già un segnale incoraggiante, posso dire Pininfarina continuerà a creare oggetti ed esperienze che migliorino la vita delle persone. Questo è il nostro obiettivo: ambienti più belli, più funzionali, più etici».
Non è un caso quindi la vostra prima presenza alla Biennale di Architettura di Venezia?
«Esatto. Abbiamo deciso di mostrare che siamo oltre l’automobile. I nostri 95 anni sono solo un punto di partenza. L’azienda è giovane, sa reinventarsi, ed è già proiettata verso i prossimi 95».
Peraltro avete presentato un progetto particolare
«Molto, grazie anche a Newcleo e Fincantieri: una riproduzione a grandezza naturale di un reattore nucleare di quarta generazione – progettato da newcleo – all’interno di un’installazione immersiva firmata da Pininfarina. L’interno del reattore è visibile, esplorabile, e supportato da sistemi interattivi di visualizzazione dei dati che spiegano il suo funzionamento, i principi della fissione e il ruolo chiave nella decarbonizzazione. Dimostriamo quindi che il design non è un elemento decorativo, ma un ponte tra l’innovazione tecnologica e la società».
© Riproduzione riservata