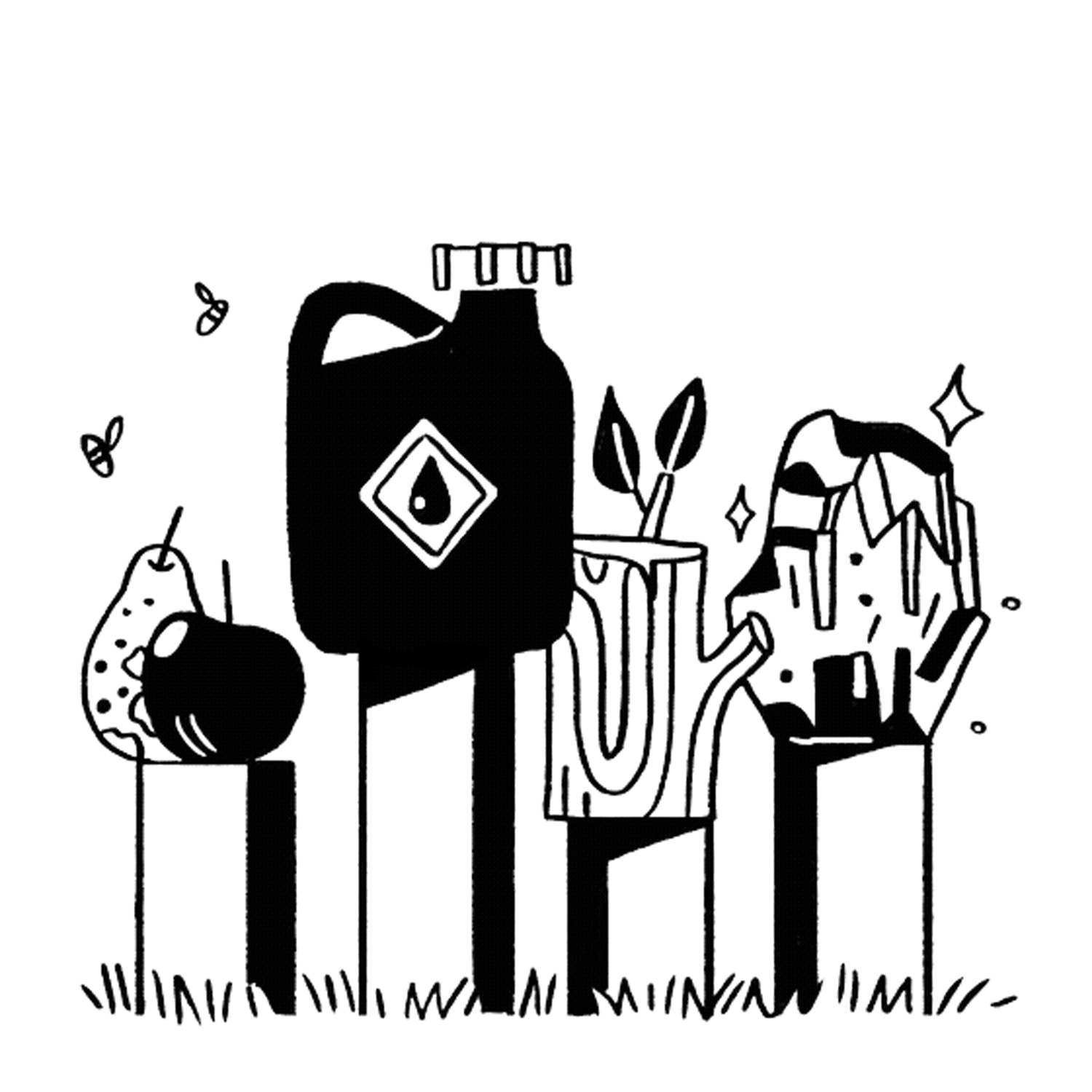Il cambio della guardia alla Banca centrale europea non è mai un fatto burocratico. È sempre un passaggio politico, anche quando lo si ammanta di tecnicalità. Le annunciate dimissioni anticipate di Christine Lagarde – in attesa di conferma ufficiale – aprono dunque una fase che va ben oltre la fisiologica alternanza: chiamano l’Europa a interrogarsi su cosa sia stata la sua politica monetaria negli ultimi anni e, soprattutto, su cosa voglia diventare.
Il confronto con Mario Draghi è inevitabile. Non per nostalgia, ma per metodo. Draghi ereditò un’Eurozona sull’orlo della disintegrazione e la difese con una frase passata alla storia (il celebre «whatever it takes») ma soprattutto con una strategia coerente, fondata su credibilità, visione e coraggio. Sotto la sua guida Francoforte non fu un notaio dei Trattati, bensì l’argine contro la speculazione e il detonatore di una nuova consapevolezza europea.
Lagarde ha avuto davanti a sé crisi non meno gravi: pandemia, shock energetico, guerra, instabilità geopolitica. E tuttavia il suo bilancio resta controverso. L’esordio fu segnato da un clamoroso scivolone: quel riferimento allo spread italiano che suonò come un disimpegno della Bce dal ruolo di garante ultimo della coesione finanziaria. I mercati non aspettano altro che un’incertezza lessicale per trasformarla in costo reale. E il costo lo pagano i debiti sovrani, a cominciare da quello italiano: cosa che accadde puntualmente con grave danno per le nostre finanze. Non fu un dettaglio comunicativo. Fu un errore politico. Perché la Bce non è soltanto un’istituzione tecnica: è il perno di un’unione monetaria priva di unione fiscale. Ogni parola pesa come un punto di Pil.
Leggi anche:
Regalo a Macron: la nuova Bce a sua immagine
Lagarde alla COP30: “Transizione energetica è qui per durare, reti accumulo la prossima sfida”
Il secondo scivolone fu sull’inflazione. Quando i segnali di un surriscaldamento strutturale cominciavano a emergere, la linea prevalente fu quella del fenomeno transitorio. Si è tardato a riconoscere che non si trattava solo di colli di bottiglia post-pandemici, ma di una combinazione di politiche ultra-espansive, shock dell’offerta e tensioni energetiche. Il risultato è stato un ciclo di rialzi aggressivi dei tassi, inevitabile ma tardivo, che ha inciso su famiglie e imprese in modo più brusco di quanto sarebbe stato necessario con una diagnosi tempestiva.
A Lagarde va riconosciuto un merito: aver tenuto la barra in mezzo alla tempesta politica internazionale di fronte alla nuova ondata sovranista e protezionista incarnata da Donald Trump. In un mondo che rimette in discussione alleanze, commercio e multilateralismo, la Bce non ha ceduto alla tentazione di piegare la politica monetaria a logiche identitarie. Ma resistere non basta. Serve guidare. Ed è qui che si gioca la partita del successore.
L’Europa non può permettersi un presidente della Bce che si limiti a gestire l’ordinaria amministrazione dei tassi. Ha bisogno di una figura che comprenda che la fragilità strutturale dell’eurozona non è monetaria ma fiscale. Senza un salto di qualità verso strumenti comuni – chiamiamoli eurobond, debito condiviso o come si preferisce – ogni ambizione di autonomia strategica resterà un esercizio retorico. Senza un mercato profondo e unitario del debito europeo, continueremo a sommare vulnerabilità nazionali invece di mutualizzarle. E ogni crisi riaprirà la faglia Nord-Sud, falcidiando consenso e credibilità.
Non è un caso che la Germania si stia già muovendo. Berlino non nasconde l’ambizione di esprimere il prossimo presidente. Ma se il cancelliere Friedrich Merz resta contrario a una vera mutualizzazione del debito, è lecito accendere i fari su qualunque candidatura sponsorizzata dal suo governo. Non per pregiudizio nazionale, ma per chiarezza politica: l’Europa ha bisogno di integrazione, non di ortodossie travestite da prudenza.
I nomi in circolazione sono molti. Il ritorno di Jens Weidmann, simbolo del rigore tedesco ai tempi del Quantitative easing, rassicurerebbe i falchi ma inquieterebbe chi vede nella Bce un motore dell’integrazione. Isabel Schnabel rappresenta una linea sofisticata e meno ideologica, ma resta espressione di una cultura monetaria storicamente refrattaria alla condivisione del rischio.
Sul fronte francese, François Villeroy de Galhau incarna una sensibilità più aperta a strumenti comuni, ma Parigi ha già dato. L’olandese Klaas Knot è stimato, ma si colloca nell’alveo dei Paesi “frugali”. Il finlandese Olli Rehn conosce bene i meccanismi europei e potrebbe rappresentare una mediazione, ma resta da capire con quale mandato politico. C’è infine lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, profilo tecnico, reputazione di equilibrio tra rigore e pragmatismo, è considerato il candidato più solido.
Tuttavia, la domanda non è chi meglio rassicuri i mercati domattina. La domanda è chi sia disposto a usare l’autorevolezza della Bce per spingere l’Europa a completare se stessa. Perché la politica monetaria, da sola, non può supplire in eterno all’assenza di una politica fiscale comune. In questo passaggio, un ruolo cruciale spetta all’Italia. E in particolare a Fabio Panetta, membro influente del board e voce autorevole nel dibattito europeo. Panetta conosce i limiti dell’attuale architettura e sa che senza un mercato unico dei capitali e senza strumenti comuni di debito, l’euro resterà un gigante monetario dai piedi fiscali d’argilla.

Non è il tempo delle diplomazie silenziose. È il tempo dell’influenza. L’Italia deve far pesare la propria posizione affinché la scelta cada su un presidente per l’Europa, non contro l’Europa. Non su un custode dei Trattati, ma su un interprete capace di evolverli nello spirito dell’integrazione. La lezione di Draghi non fu l’azzardo. Fu la responsabilità. Capì che difendere l’euro significava, in ultima analisi, difendere il progetto politico europeo. Oggi la sfida è diversa ma non meno radicale: trasformare una moneta comune in una sovranità economica condivisa. Se la prossima presidenza si limiterà a presidiare l’inflazione con il manuale del perfetto banchiere centrale, l’Europa continuerà a rincorrere le crisi. Se invece saprà farsi promotrice di un salto fiscale, allora il cambio della guardia non sarà un semplice avvicendamento, ma l’inizio di una nuova fase costituente. La scelta è politica, prima ancora che tecnica. E questa volta non ci sarà una frase salvifica a guadagnare tempo. Servirà una visione. E il coraggio di sostenerla.
Leggi anche:
La Bce accelera sull’euro digitale: l’obiettivo è il lancio nel 2029
Panetta disegna la rotta per un’Italia che cresca oltre l’1% stentato
© Riproduzione riservata