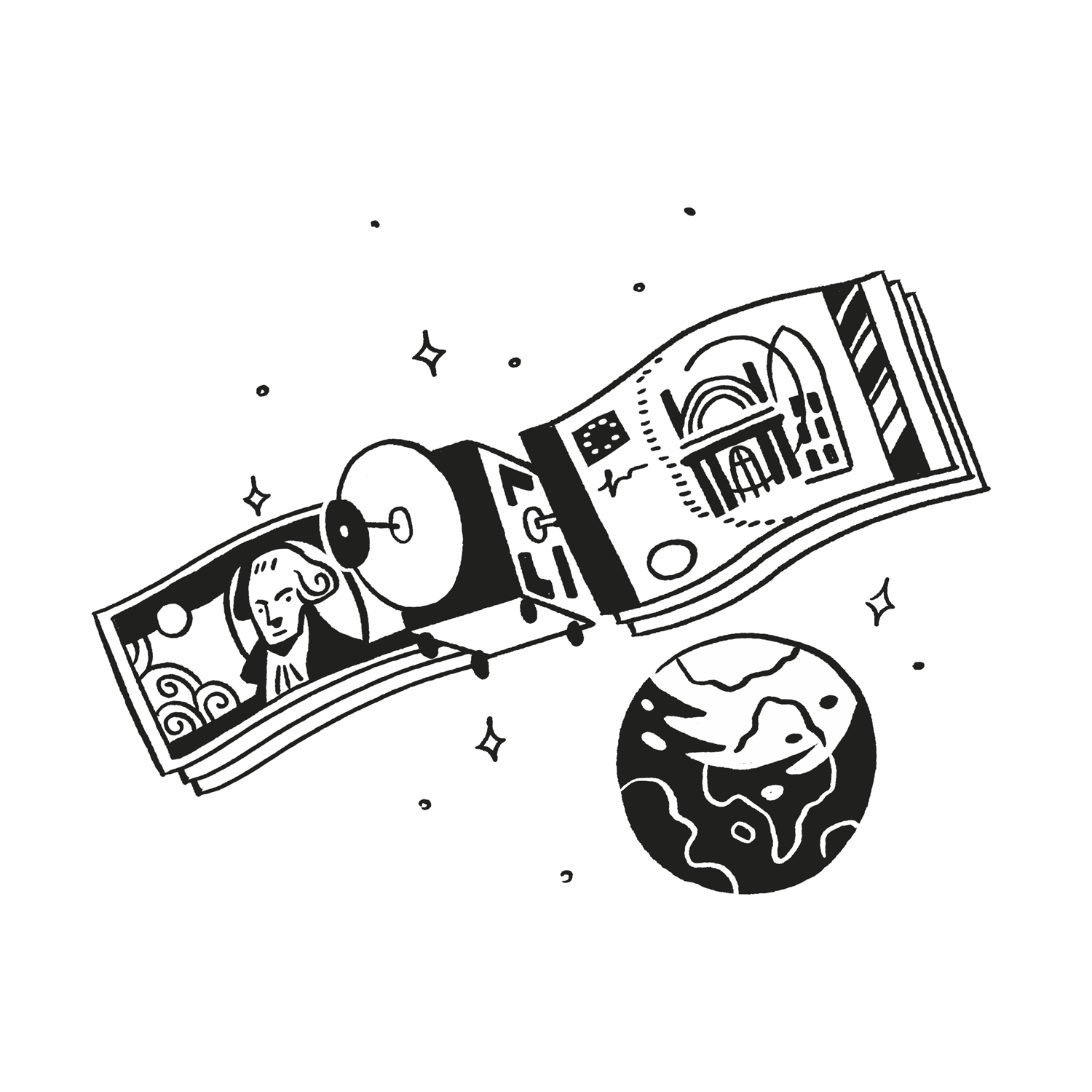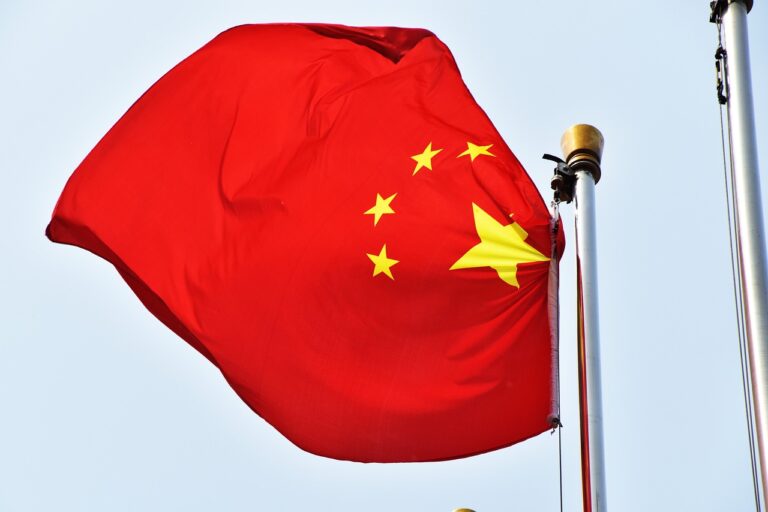Il ritiro dell’Italia dalla Belt and Road Initiative (BRI) cinese ha rappresentato la prima inversione di rotta a livello nazionale dell’allineamento della BRI tra le economie del G7 e l’inizio di una trasformazione a più livelli nella strategia estera italiana in ambito economico, industriale e di sicurezza informatica. Ma come sono cambiati i rapporti tra l’Italia e il Dragone? Un lungo e approfondito report pubblicato dal sito debuglies.com ha analizzato la portata del riorientamento strategico dell’Italia post-memorandum e ha valutato gli strumenti operativi e politici adottati dal 2024 al 2025 per mitigare l’influenza cinese nei settori critici, in particolare alla luce del secondo mandato presidenziale di Donald Trump. L’obiettivo dello studio è anche quantificare l’esposizione dell’Italia agli strumenti economici statali cinesi – che vanno dai veicoli elettrici ai materiali delle terre rare e alle telecomunicazioni sottomarine – e ad analizzare come il riallineamento dell’Italia si traduca in sovranità operativa, resilienza infrastrutturale e ricalibrazione diplomatica.
Disimpegno costruttivo
I risultati dell’indagine confermano che l’uscita dell’Italia è stata attuata attraverso una strategia diplomatica di “disimpegno costruttivo”, ma non ha messo in campo un distacco immediato. Tra il 2019 e il 2025, le esportazioni italiane verso la Cina sono aumentate solo marginalmente, mentre le importazioni sono aumentate in modo sproporzionato, con un deficit commerciale bilaterale che ha raggiunto i 22,6 miliardi di euro nel primo semestre del 2025. Oltre l’81% dei pannelli solari e il 94% delle celle per batterie al litio-polimero (LFP) importati nello stesso periodo provenivano dalla Cina, a conferma della profonda dipendenza dell’Italia dagli input cinesi per la sua transizione energetica. Allo stesso tempo, il 31,7% delle unità di accesso radio 5G italiane è rimasto di produzione cinese al secondo trimestre del 2025, nonostante gli impegni normativi di epurazione dei fornitori ad alto rischio. Sul fronte della sicurezza industriale, un aumento del 100% degli interventi di golden power dal 2019 riflette una crescente vigilanza normativa, mentre le materie prime essenziali, come gli elementi pesanti delle terre rare, continuano a provenire in modo schiacciante dagli esportatori cinesi, senza una capacità di stoccaggio nazionale o una catena di approvvigionamento verticalmente integrata per garantire l’autonomia strategica.
C’è poi il tema della resilienza delle infrastrutture. L’Italia funge da hub di atterraggio primario per 23 cavi sottomarini attivi, ma il 74% rimane al di fuori del perimetro di sicurezza informatica regolamentato dalla legislazione nazionale e della Ue. Nonostante ospiti oltre 255.000 km di percorsi in fibra ottica, il nostro Paese non ha presentato la revisione di resilienza richiesta dal Piano d’azione per la sicurezza dei cavi della Ue, con conseguente sorveglianza disgiunta tra autorità militari, civili e delle tlc. L’approvvigionamento delle apparecchiature per le reti sottomarine rimane parzialmente dipendente da entità soggette a sanzioni americane e le operazioni marittime mancano di un sistema di rilevamento delle anomalie basato sull’intelligenza artificiale. I tassi di copertura delle ispezioni dei cavi in Italia rimangono al 3,6%, ben al di sotto della media Ue dell’11,9%, creando significativi punti ciechi operativi.
Governo Meloni e la strategia su tre fronti
Con il governo Meloni la strategia si è mossa su tre fronti: il coinvolgimento attraverso una cooperazione modulare con la Cina in settori come la cultura e la sicurezza alimentare, il contenimento attraverso restrizioni del “golden power” e lo screening degli investimenti, la deterrenza attraverso la diplomazia parlamentare e l’architettura della sicurezza informatica.
Allo stesso tempo, gli investimenti strategici nella sorveglianza sottomarina e nella resilienza informatica rimangono vulnerabili. Sebbene missioni come “Operazione Fondali Sicuri” e nodi infrastrutturali come l’Underwater Dimension Hub di La Spezia rappresentino significativi passi avanti, i finanziamenti rimangono limitati a 2 milioni di euro all’anno. L’Italia non dispone di una struttura di comando nazionale per la protezione dell’energia via cavo e sottomarina, e solo 1 dei 4 moduli amplificatori di BlueMed Fase II proviene da un fornitore della Ue. Senza investimenti sostenuti e un’integrazione istituzionale a spettro completo, sottolinea il rapporto elaborato da analisti indipendenti, la capacità deterrente dell’Italia nel dominio sottomarino del Mediterraneo rimane vulnerabile a perturbazioni ostili.
Anche dopo l’uscita formale dell’Italia dalla BRI, gli scambi diplomatici ad alto livello sono proseguiti culminando nella visita ufficiale di Meloni a Pechino nel luglio 2024. Durante la visita, entrambe le parti hanno firmato il “Piano d’azione per il rafforzamento del partenariato strategico globale Italia-Cina (2024-2027)”, che ha delineato un quadro per la futura cooperazione in sei aree tematiche: commercio e investimenti, collaborazione finanziaria, scienza e istruzione, transizione verde, assistenza sanitaria e scambi culturali.
Assenti dal Piano d’Azione erano i pilastri originali della BRI: infrastrutture solide, corridoi di connettività e standardizzazione della logistica e dei regimi normativi. Non solo. Nell’ottobre 2024, l’Italia ha votato a favore dei dazi compensativi sui veicoli elettrici (EV) cinesi, promossi dalla Commissione europea. Il voto favorevole dell’Italia, confermato nel verbale della Commissione pubblicato il 4 ottobre 2024, è stato particolarmente significativo alla luce dei negoziati concomitanti con Dongfeng Motor Corporation, un’impresa statale cinese, sulla potenziale apertura di uno stabilimento di assemblaggio di EV nell’Italia meridionale.
I negoziati con Dongfeng, inizialmente inquadrati come una soluzione al calo della produzione automobilistica nazionale e alle crescenti tensioni tra il governo italiano e Stellantis, alla fine sono falliti. Dongfeng aveva chiesto non solo che Roma si opponesse ai dazi Ue sui veicoli elettrici cinesi, ma anche che facilitasse l’accesso di Huawei all’infrastruttura di rete 5G italiana. Entrambe le condizioni sono state ritenute politicamente inaccettabili, soprattutto alla luce delle preoccupazioni per la sicurezza nazionale sollevate nel 2022 dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) e ribadite all’inizio del 2024 dal direttore uscente dell’agenzia di intelligence interna italiana Aisi.
Sul fronte commerciale, il deficit strutturale dell’Italia con la Cina ha continuato ad ampliarsi nella prima metà del 2025, raggiungendo i -22,6 miliardi di euro entro la fine di giugno, secondo l’ultimo rapporto Commercio Estero dell’ISTAT. Questo deficit è stato determinato in gran parte da un aumento del 42,1% delle importazioni cinesi di pannelli solari (1,44 miliardi di euro nel primo semestre del 2025) e da un aumento del 33,6% delle importazioni di batterie agli ioni di litio (889 milioni di euro nel primo semestre del 2025), riflettendo la crescente dipendenza dell’Italia dagli input cinesi per la sua transizione verso l’energia pulita, una dinamica che mina la resilienza industriale nazionale. Nel frattempo, le esportazioni italiane verso la Cina nello stesso periodo hanno registrato un calo del 5,8%, scendendo a 6,21 miliardi di euro, con i beni dell’ingegneria meccanica (-7,3%) e della moda (-6,5%) maggiormente colpiti.
Un’analisi condotta nel maggio 2025 dalla Commissione Parlamentare per il Bilancio e la Programmazione Economica ha inoltre rilevato che l’Italia non dispone di un sistema centralizzato di monitoraggio degli investimenti cinesi collegati alle imprese statali in attività strategiche italiane. La rendicontazione rimane frammentata tra Sace, Cdp e Ministero delle Imprese, creando punti ciechi nelle capacità di sorveglianza, viene sottolineato nello studio. Che cita come esempio il caso delle infrastrutture portuali e della compagnia cinese Cosco Shipping Lines detiene una partecipazione del 40% nel Medcenter Container Terminal di Gioia Tauro. Il terminal di Cosco ha gestito 1,46 milioni di TEU nel primo semestre del 2025, con un aumento del 12,8% su base annua. Tuttavia, solo il 3,6% di queste spedizioni è stato sottoposto a ispezioni doganali in tempo reale, in netto contrasto con la media Ue dell’11,9%, evidenziando le vulnerabilità nei controlli della catena logistica nazionale.
Sul fronte delle tlc, mentre l’Italia si è impegnata a escludere gradualmente i fornitori ad alto rischio dalle infrastrutture digitali critiche, il Garante per la Sicurezza Cibernetica Nazionale ha confermato, nel suo audit tecnico del maggio 2025, che il 31,7% delle unità di accesso radio 5G installate rimane di origine cinese, con ZTE e Huawei che rappresentano il 92% di tali unità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Sicurezza delle Reti” nell’aprile 2025, fissando a dicembre 2028 una scadenza legale vincolante per la completa sostituzione delle componenti di telecomunicazione extra-UE nell’infrastruttura core. Ma secondo l’ultimo aggiornamento trimestrale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), al secondo trimestre del 2025, i nodi chiave nelle aree metropolitane di Milano, Napoli e Bari si basano ancora su configurazioni di rete core ibride in cui le unità di banda base cinesi rimangono attive, a causa di ritardi nei contratti di supporto alla transizione dei fornitori. In risposta, l’Agenzia europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha sollecitato l’accelerazione dell’approvvigionamento di alternative europee conformi nell’ambito del pacchetto di strumenti dell’Ue sulla sicurezza informatica del 5G. L’esposizione dell’Italia non è dovuta a inadempienze normative, ma piuttosto a un persistente coinvolgimento dei fornitori nel livello fisico della sovranità digitale, dove l’applicazione tecnica è in ritardo rispetto agli impegni strategici.
Il nodo energetico
Altro punto critico è l’esposizione del sistema energetico italiano al predominio manifatturiero cinese nei componenti solari ed eolici. L’81,6% dei pannelli fotovoltaici installati in Italia tra gennaio e maggio 2025 è stato prodotto in Cina, con tre fornitori – LONGi Green Energy, JA Solar e Trina Solar – che rappresentano complessivamente oltre il 67% delle spedizioni totali. Il valore cumulativo delle importazioni di moduli fotovoltaici dalla Cina durante questo periodo ha raggiunto 2,11 miliardi di euro, con un aumento del 36,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il Gestore Nazionale dei Servizi Energetici (GSE) ha riportato nel suo bollettino di giugno 2025 che l’89,4% delle turbine eoliche di nuova connessione in Sicilia, Puglia e Molise era dotato di navicelle e pale prodotte da Goldwind ed Envision Energy, due entità con affiliazioni documentate alla Commissione cinese per la Supervisione e l’Amministrazione dei Beni Statali. Nel settore dell’accumulo di energia a batteria, la dipendenza dell’Italia raggiunge un livello di criticità ancora maggiore. Il 94,8% delle celle per batterie al litio ferro fosfato importate in Italia proviene da produttori cinesi con un valore cumulativo delle importazioni per il primo semestre 2025 superiore a 1,76 miliardi di euro. L’Osservatorio per le Industrie Strategiche del Ministero delle Imprese ha rivelato che dei 14 progetti di accumulo di energia a batteria su scala industriale in costruzione in Lombardia ed Emilia-Romagna, 11 dipendevano interamente da inverter e sistemi di gestione delle batterie cinesi.
© Riproduzione riservata