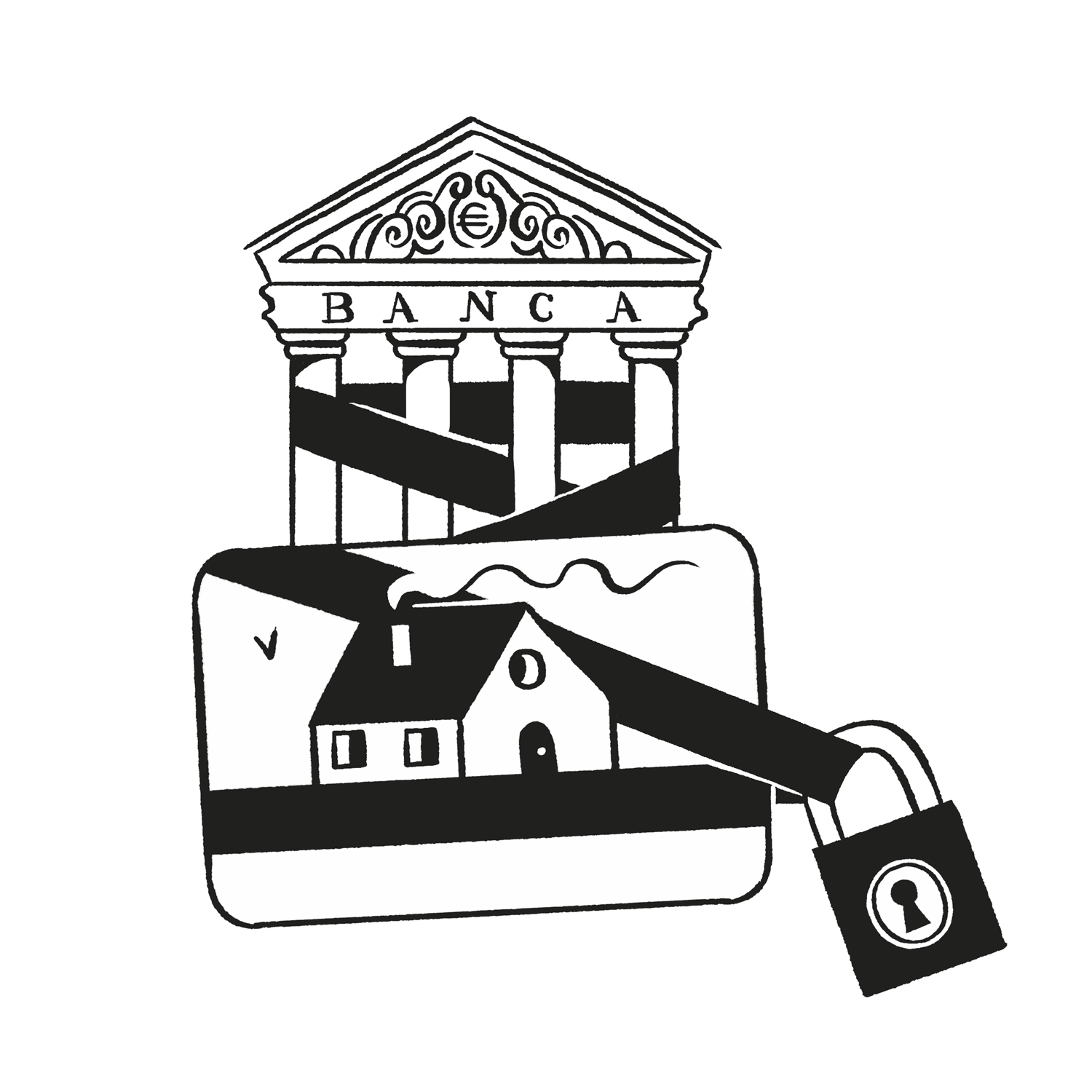Mille giorni sono una misura crudele del potere. Sono abbastanza lunghi da chiederne conto, ma non così lunghi da riscrivere la storia. Sono la soglia oltre la quale un governo non può più parlare di eredità ricevuta: tutto ciò che accade dopo diventa responsabilità propria. Per Giorgia Meloni questi primi mille giorni alla guida del governo, sono il racconto di una parabola doppia: politicamente, ha consolidato il suo potere come nessun predecessore era riuscito a fare da molti anni; ma sul fronte economico l’Italia è ferma al trampolino: pronta al salto, ma con le ginocchia non ancora piegate.
La sua ascesa non fu pacifica, generò apprensione, soprattutto all’estero: una premier postfascista a Palazzo Chigi, nel Paese con il debito pubblico più pesante dell’eurozona, sembrava la promessa di una nuova stagione di scontri. Invece è accaduto l’opposto. Meloni ha scelto, con freddezza e calcolo, la via della legittimazione internazionale. Ha sposato l’atlantismo, ha messo da parte ogni tentazione sovranista, ha gestito il Pnrr con realismo. Non ha sfidato l’euro, ha evitato rotture frontali. Si è trasformata in leader di governo, con un’efficacia che nemmeno Mario Draghi aveva raggiunto sul piano politico.
Senza più giravolte ravvicinate a Palazzo Chigi, la stabilità – vero successo di questo governo – è tornata moneta negoziabile: con i mercati, con Bruxelles, persino con gli alleati americani. Un merito non banale, in un’Europa scossa da elezioni dall’esito incerto e polarizzazioni di colore vario. Ma questa stabilità ha un prezzo, che al momento si chiama immobilismo.
Dietro una tenuta dei conti che ha quasi del miracoloso, l’economia italiana fatica a imporsi nonostante nell’Unione abbia recuperato dignità. Il Pil è infatti cresciuto, ma resta – sebbene di poco – sotto la media europea, mentre la produttività è ferma al palo. Per non dire del Mezzogiorno che, salvo qualche eccezione luminosa, resta in apnea. Eppure il governo Meloni si avvale del miglior ministro dell’Economia che si sia visto da molti anni: è Giancarlo Giorgetti che ha convinto le agenzie di rating che l’Italia non era sull’orlo del baratro; è lui che ha rassicurato Bruxelles quando i conti sembravano sfuggire di mano; ed è grazie alla sua linea rigorista che lo spread Btp-Bund è caduto a livelli che non si registravano da vent’anni. Inoltre, nessuna nuova procedura d’infrazione è alle viste, nessuna fuga dei capitali. Anzi, è tornato a crescere il flusso dall’estero.
La brutta notizia è che il debito pubblico ha superato la soglia di 3mila miliardi di euro. Si tratta di un livello sostenibile, ma solo finché i tassi restano sotto controllo e la crescita non va in negativo: due congiunture gestibili, ma gravate da non poche incognite in tempi di guerre commerciali e guerre reali.
A discarico del governo Meloni va segnalato che il gran balzo del debito è per 150-180 miliardi (la misura esatta la conosceremo solo tra due anni) conseguenza del Superbonus 110% introdotto con una leggerezza che lascia basiti dal governo Conte II: un’eredità di crediti incagliati, frodi miliardarie e deficit pubblico. Meloni ha il merito di avere interrotto il flusso ma, onde evitare effetti collaterali su edilizia e Pil, è stata costretta a farlo gradualmente. Giorgetti ha completato l’opera sterilizzando l’impatto contabile. Ma il danno era fatto, sicché oggi quel bonus pesa come un macigno su ogni manovra. Di qui probabilmente la lentezza con cui procedono i progetti di riforma più costosi.
Ma ci sono anche riforme che non costano e che potrebbero essere avviate strappando le incrostazioni vischiose di una burocrazia il cui scopo non è l’efficienza del sistema ma l’autoconservazione. Sicché, sul piano della politica industriale la promessa di una «visione strategica nazionale» si è infranta contro una realtà fatta di interventi cruciali ma estemporanei: l’aver chiuso l’annosa vicenda di Ita Airways, sciolto il pernicioso legame fra Tim e Vivendi attraverso Poste, risanato Banca Mps al punto da farne una testa d’ariete nel riposizionamento del credito nazionale, sono scelte coraggiose che nessun governo era riuscito a compiere. Ma il fatto che non sia ancora giunto a soluzione il capitolo più spinoso, ovvero il riassetto dell’ex Ilva di Taranto, è la prova che manca ancora un disegno organico, una regia che sappia guidare l’Italia dentro le transizioni tecnologiche e ambientali senza subirle. Lo stesso Piano Mattei, che doveva rilanciare la proiezione economica dell’Italia in Africa e nel Mediterraneo, rischia di restare senza gambe se non si integra con una strategia industriale seria.
Simili perplessità valgono per il fronte giustizia. La riforma Nordio, promessa come una svolta garantista e di efficienza, è ancora a metà del guado, rallentata da veti incrociati, resistenze interne e ambiguità nella maggioranza. Sicché, la battaglia per una magistratura più efficiente e meno ideologica, pur se meno rumorosa rispetto al passato, continua a consumarsi nei corridoi, più che nelle aule del Parlamento.
Naturalmente non possono essere ignorati i passi importanti compiuti sul fronte del lavoro: il tasso di disoccupazione è sceso dal 7,1% del 2022 al 6,5% a metà 2025, fino a far registrare un’occupazione mai così alta nella storia del Paese. E tuttavia, il segnale incoraggiante viene offuscato dal fatto che si tratta di lavoro precario, sottopagato e sbilanciato sul terziario fragile. I giovani, se possono, se ne vanno, mentre le nascite sono crollate sotto 370.000 e nel 2025 non si vedono inversioni. La buona volontà sotto forma di incentivi alla natalità non basta se mancano servizi, alloggi accessibili e un clima di fiducia sul futuro. Anche in questo i primi mille giorni del governo Meloni sono stati un tempo di gestione ordinaria, pur lodevole sotto più punti di vista, a cominciare dal fronte dell’immigrazione.
Tuttavia, lungi dall’essere una parentesi o un esperimento a termine, grazie all’esecutivo Meloni per molti osservatori – incluso The Economist, spesso severo nei giudizi – l’Italia non è più «un paziente instabile» dell’Unione europea. Anzi, è paradossalmente diventata uno degli attori più prevedibili e coesi. Anche in ambito internazionale il suo posizionamento è stato meno ideologico di quanto si temesse. Il governo ha mantenuto una linea atlantista e filo-Unione, senza gli scivoloni antieuropeisti che avevano segnato la comunicazione pre-elettorale. La gestione del dossier Ucraina, la cautela sui rapporti con la Cina, e la sponda trovata con Francia e Germania (nonostante qualche frizione) hanno dato a Meloni una credibilità che oggi consente a Giorgia Meloni di sedere a pieno titolo nei consessi europei. La sua postura transatlantica è composta, ma mai veramente innovativa.
In un mondo incerto, tutto questo ha funzionato. Perciò possiamo dunque dire senza esitazioni che Meloni ha vinto il primo tempo: ha dominato il quadro politico, neutralizzato l’opposizione, raccolto consenso. Ma nel secondo tempo – quello che si apre ora – servirà altro. Serviranno riforme vere. Decisioni anche impopolari. Una politica industriale. Una risposta al declino demografico. Una visione che non si limiti a confermare ciò che già funziona. Perché i primi mille giorni servono a costruire fiducia. I successivi, a giustificarla.
© Riproduzione riservata