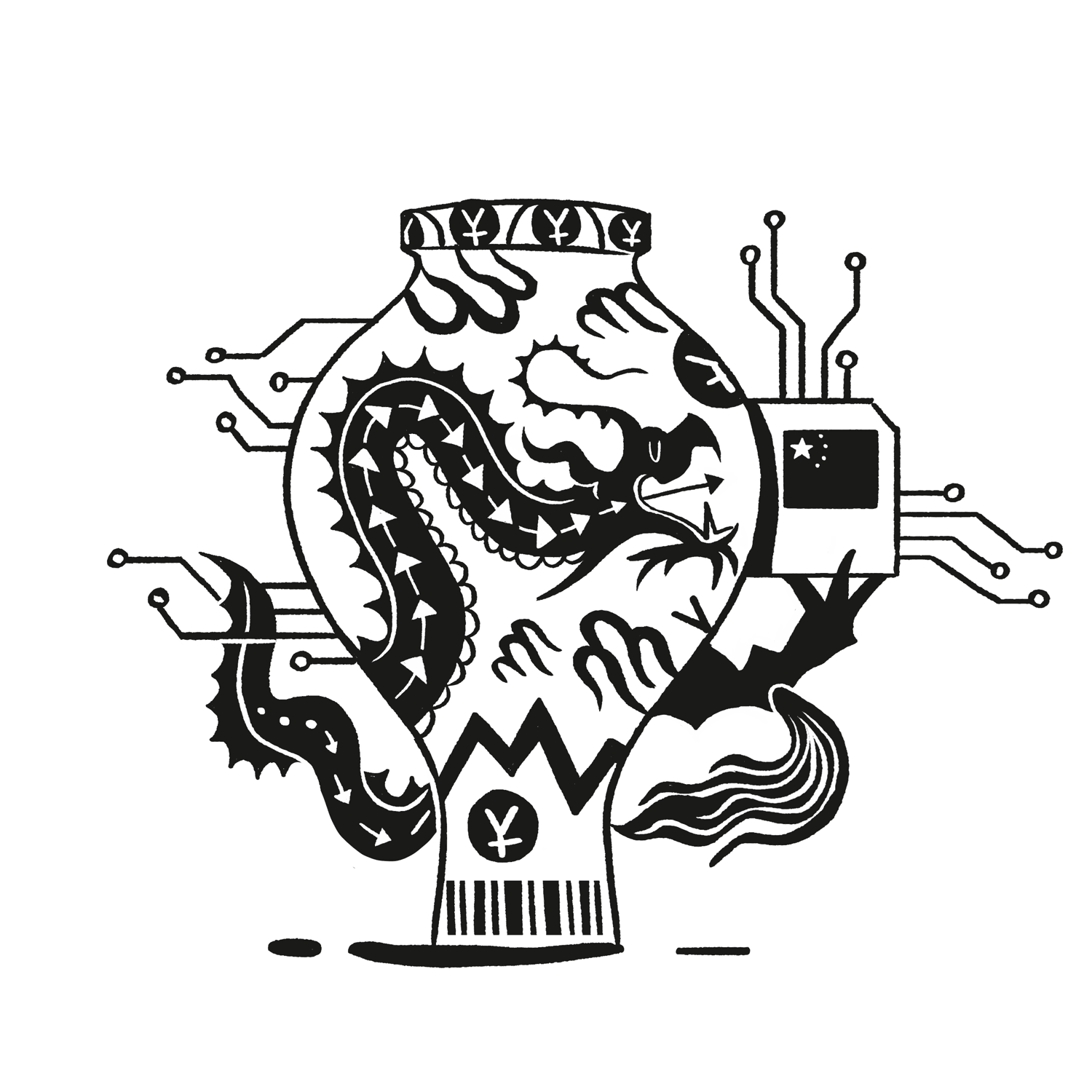«Avrei bisogno di un aiuto per questa esportazione negli Usa per la quale il cliente ha subito un addebito da Dhl di XX dollari su valore della merce di XX dollari in quanto la Dhl Usa ha modificato il codice doganale da noi indicato in fattura…». E’ solo una delle tante mail che ogni giorno riceve Federica Piran, consulente e partner dello studio KW Forester. Piran supporta le aziende nella gestione doganale delle operazioni con l’estero e il trasferimento fisico delle merci. Vede sul campo l’impatto della guerra commerciale scatenata da Washington sull’operatività delle imprese nostrane che esportano negli Usa.
Spunta il dazio supplementare
Molto si è detto e scritto sui danni che i dazi di Trump avranno sull’export italiano dei settori delle cosiddette tre effe – food, fashion e forniture (cibo, moda e arredamento) meno delle difficoltà che incontra chi esporta “macchinari per fare cose”: che siano macchinari per imballare materassi o macchinari per il controllo delle fialette dei medicinali risultano essere i prodotti che Italia esporta maggiormente. Si tratta di un mondo produttivo classificato alle voci doganali dei capitoli 84 e 85 (e inclusi per buona parte nelle 407 categorie merceologiche sui prodotti derivati dell’acciaio e dell’alluminio assoggettate dal 18.08 ai dazi del 50%). Ed è quello che oltre al dazio doganale universale del 15% sul valore FOB (Free on board) della merce – ovvero il costo totale fino al momento in cui viene caricata sulla nave nel porto di origine, includendo il costo della merce e le spese locali, ma escludendo il nolo e l’assicurazione marittima, a carico dell’acquirente – paga anche il dazio doganale supplementare sul valore dei componenti in acciaio e alluminio che ne costituiscono una buona parte.
«Purtroppo, – spiega Piran a Moneta – il tempo di produzione media di un macchinario si aggira tra i 3 e i 6 mesi: al momento della conclusione del contratto con la controparte americana la situazione daziaria non era questa e adesso si aprono delle trattative tra venditore e acquirente per capire come dividersi questo nuovo importo da sborsare. Il compratore americano solitamente è restio a rivedere il prezzo di acquisto soprattutto se è un importatore/distributore ed ha già rivenduto all’utilizzatore finale il macchinario e per cui questo nuovo dazio andrà ad impattare sulle tasche del produttore/esportatore».
Il tallone d’Achille delle pmi
Oltre al dazio c’è, però, una cosa di cui pochi parlano: la gestione propria dell’operazione doganale e la documentazione da presentare al Customs and Boarder Protection (Cbp) per sdoganare la merce in import negli States. «Mancano linee dirimenti su cosa bisogna presentare, come deve essere fatta questa documentazione, quando bisogna presentarla. Questo sta creando ritardi nelle consegne, merci ferme in dogana con soste molto costose, spedizionieri che hanno aumentato i noli del trasporto per costi dell’operazione doganale, confusione totale. Mancano indicazioni chiare sulla presentazione del set di documenti per la dogana americana», spiega l’esperta.
Chi sono le aziende in affanno
Il caos scatenato dai dazi ha alzato il tappeto e mostrato la polvere delle strategie di internazionalizzazione di molte aziende soprattutto le pmi. Secondo Piran, stanno pagando questa situazione le aziende che vendono all’estero non quelle internazionalizzate. «Le prime, per esempio, non hanno mai dato importanza all’avere un’adeguata compliance doganale che parte dalla gestione della supply chain, con il ruolo dei fornitori nella raccolta della documentazione che serve alla dichiarazione in dogana americana, alla determinazione dell’origine delle merci, elemento base dell’imposizione daziaria. Ancora troppi si limitano a pensare che siccome il prodotto è fatto nei loro stabilimenti in Italia sia di origine italiana.
Le piccole continuano a fornire le loro merci con la cosiddetta resa EXW (ex works o franco fabbrica) che lascia all’importatore di occuparsi di logistica e di sdoganamento non sapendo che eventuali false dichiarazioni al CBP pendono come spada di Damocle sul loro collo. Le piccole, spesso vedono negli Usa il loro mercato principale sviluppando una sorta di dipendenza monomercato e spesso monocliente e saranno quelle che pagheranno maggiormente la situazione che si è creata. Quelle, invece, internazionalizzate hanno capito che oggi serve una presenza produttiva tramite delocalizzazione e/o in joint venture con aziende americane.
«Le internazionalizzate hanno capito che in un mercato fatto da consumatori abituati ad avere il latte e il giornale fuori della porta tutte le mattine la gestione della logistica è cruciale e vendono con resa DDU (delivery duty paid)», aggiunge Piran.
Molte aziende hanno rivisto le loro condizioni generali di vendita, riservandosi la possibilità di rivedere i prezzi al variare dell’imposizione daziaria. La differenza fondamentale è che le pmi abbracciano solo il criterio di attrattività nella scelta del loro mercato export mentre quelle internazionalizzate valutano anche quello di accessibilità in termini di barriere tariffarie. La morale? «Paghiamo le dimensioni non tanto a livello produttivo, ma a livello di imprenditorialità e di cultura business. Il mercato Usa è quello più interessante, più redditizio ma anche il più difficile, soprattutto se non si affronta con una strategia, grandi investimenti e persone preparate a gestire modi di business, aspetti di cross-culture e oggi doganali completamente diversi da altre parte del mondo».
Leggi anche:
1. Dazi, Trump ricorre alla corte suprema e chiede tempi brevi
2. Dazi, il made in Italy va in dribbling negli Emirati Arabi
© Riproduzione riservata