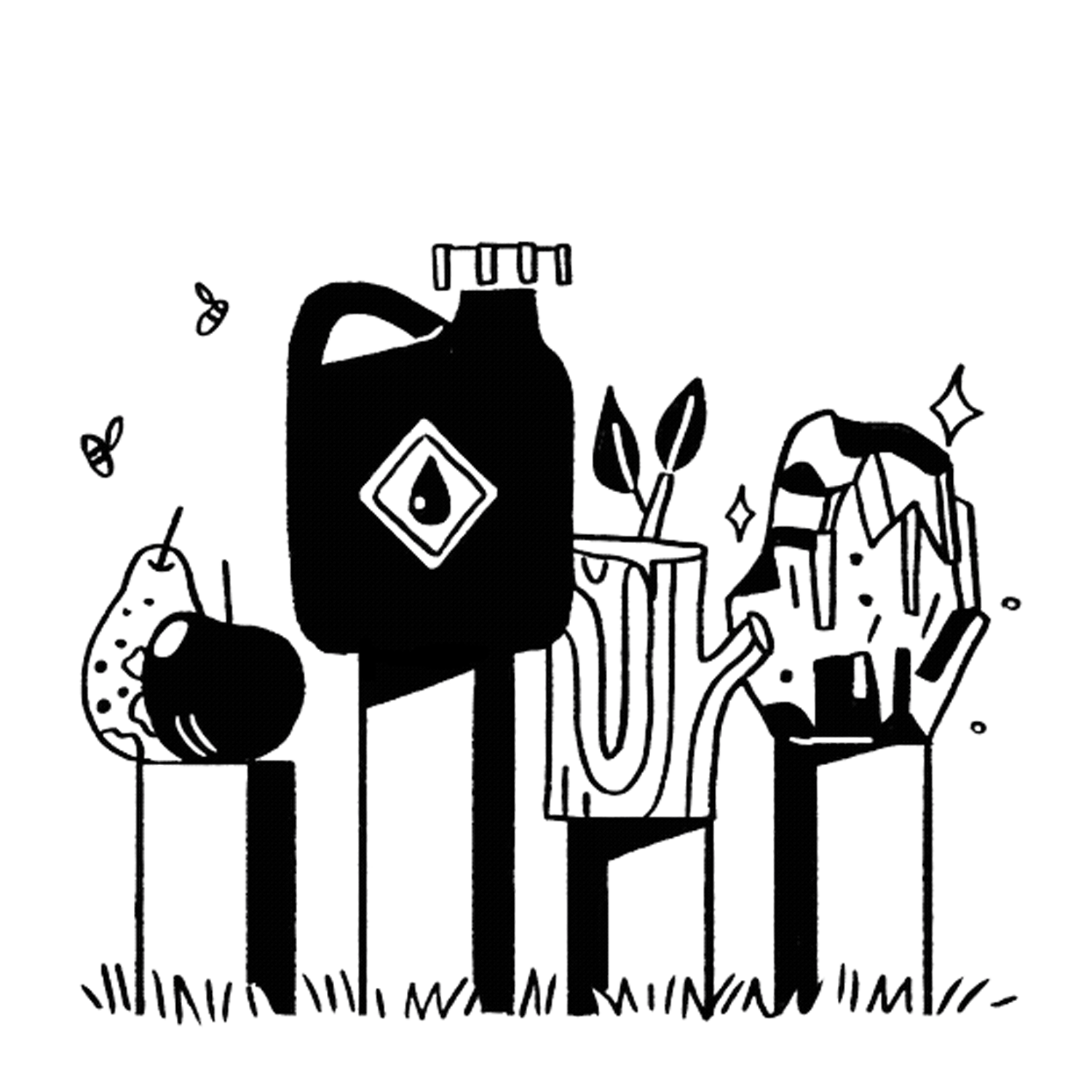Di fronte al precipizio imboccato a gran velocità dall’ex Ilva non c’è molto da dire, se non che lo Stato a questo punto deve decidere che cosa ne vuole fare. Dopo aver bruciato in 13 anni una ricchezza che nel complesso sfiora 50 miliardi tra Pil perduto e sovvenzioni pubbliche di varia natura (nel 2019 l’Isveimer segnalò un deficit di 23 miliardi per il solo Pil), anche i tempi supplementari sono esauriti. Quindi, delle due l’una: o lo Stato dichiara chiusa la partita assumendosi la responsabilità di azzerare d’un colpo una filiera industriale cui sono legati i destini di ventimila famiglie, con tutto ciò che comporta la rinuncia a produrre l’unico bene essenziale di cui nemmeno l’ultima modernità può fare a meno; oppure riunisce attorno a un tavolo i cinque o dieci maggiori acciaieri italiani, chiedendo loro di agire in consorzio per rilanciare una produzione senza la quale l’industria italiana avrebbe non pochi problemi, sia in termini di approvvigionamenti sia di maggiori costi.
Dopo l’ennesimo atto di una magistratura pervicacemente aggrappata alle proprie opinabili convinzioni, che di fatto ha dimezzato la produzione di acciaio a un solo altoforno invece di avviare indagini sulla natura forse dolosa dell’incidente all’origine del blocco, come pensare che Baku Steel, il partner potenziale con cui sono (erano?) in corso trattative, sia ancora disponibile a prendere il timone di una nave che ormai solo una chiamata alle armi del governo può impedire che finisca nel gorgo? Il ministro Adolfo Urso ci vorrebbe far credere che sia ancora possibile salvare capra e cavoli, ma persino i suoi più stretti collaboratori sanno che l’opzione “cavaliere bianco” è sempre più lontana. E non sarà certo una nuova nazionalizzazione che restituirà all’ex Ilva un briciolo di credibilità: né attraverso l’intervento di Invitalia, che rischierebbe di bruciare in un falò ciò che di buono ha fatto in questi anni, né attraverso una combinazione che non veda al comando gli imprenditori italiani del settore.
D’altro canto, il disastro dell’impianto tarantino è il risultato della peggiore fra le combinazioni possibili. A tanto si è giunti grazie alla miopia di una classe politica locale e nazionale sempre più reclinata su se stessa; all’irresponsabilità morale di una magistratura vittima dei propri deliri di onnipotenza; all’azione di un sindacato che non ha esitato a danzare sulle disgrazie famigliari, pur di raggiungere i propri obiettivi luddisti; alla cecità legislativa delle policy europee concepite a Bruxelles; infine, all’incapacità di maneggiare problemi complessi da parte di governi che pure sembrava avessero le carte in regola per affrontare i grandi nodi industriali del nostro tempo. Pie illusioni: l’aver guidato la prestigiosa Università Bocconi o la Bce del “whatever it takes” non ha impedito che si arrivasse allo sfascio.
Quando nell’ottobre 2023 il Giornale sbugiardò le «ottime condizioni» in cui navigava l’ex Ilva sbandierate dall’allora ceo Lucia Morselli in nome dell’azionista ArcelorMittal, documentando una realtà drammatica ormai matura per il commissariamento (cosa che di lì a poco avvenne), ci si era illusi che l’intervento straordinario e temporaneo dello Stato avrebbe consentito l’avvio di una nuova gara in cerca di partner più funzionali. Del resto, sebbene le potenzialità degli impianti apparivano assai ridotte rispetto alle 10mila tonnellate di buon acciaio prodotte ogni anno al tempo dei Riva, persino tra i concorrenti italiani c’era ancora chi ostentava ottimismo.
Errore grave non aver considerato la pervicacia della compagnia sgangherata che in dieci anni aveva accompagnato con mano ferma l’azienda sull’orlo del precipizio. È opera vana cercare di dipanare ora i singoli pessimi contributi, perché la maggiore responsabilità di quanto sta accadendo è di chi, nel rappresentare gli interessi dello Stato, non ha saputo manovrare le leve della collegialità in nome di personalismi che non andrebbero coltivati di fronte a derive così gravi. È superfluo fare nomi e cognomi, perché il cast di questo disastro, ben più grande di quello provocato dall’Alitalia, è quotidianamente affisso sui cancelli del polo tarantino. Parlare oggi di decarbonizzazione, di investimenti nuovi per 13 o 15 miliardi, di altri prestiti-ponte non ha alcun senso se prima non si è capito in quale direzione porta l’interesse collettivo.
È comprensibile che questo governo, cui è toccato di ereditare il disastro compiuto dagli esecutivi che lo hanno preceduto, fatichi ad assumersi la responsabilità di una scelta definitiva che costerebbe sacrifici a decine di migliaia di famiglie, rendendo monca la nostra industria pesante. Proprio per questo la premier Giorgia Meloni dovrebbe in tempi brevissimi avocare a sé il dossier e, qualora le ipotesi di rilancio non fossero percorribili, assumere una determinazione collegiale condivisa dall’intero governo.
© Riproduzione riservata