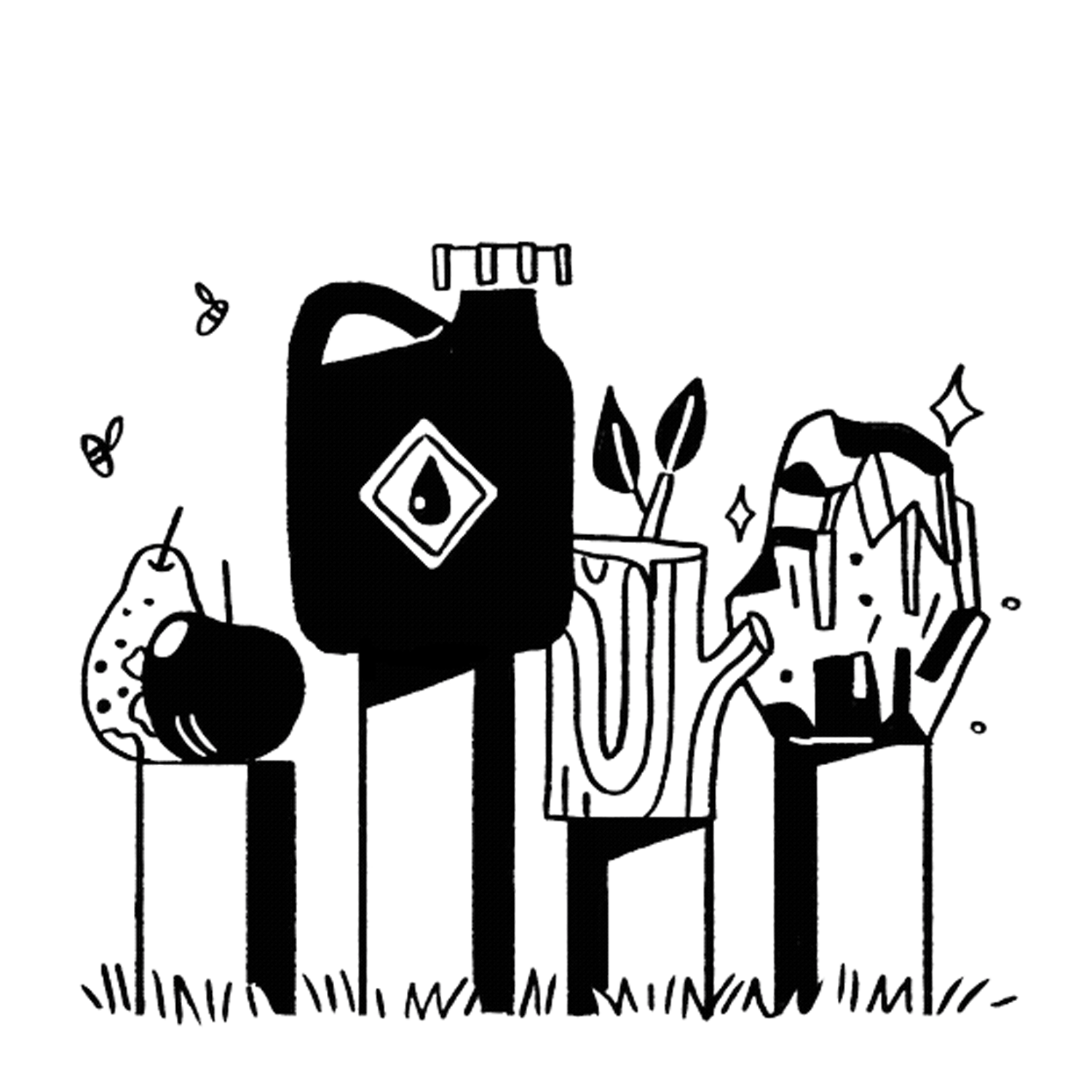Potrebbe sembrare il remake di un divertente film degli anni settanta “Finchè c’è guerra c’è speranza” in cui Alberto Sordi nei panni di un cinico mercante d’armi, per vendere il suo arsenale a uno dei dittatori di Paesi dell’Africa, scandiva la frase “è l’aratro che traccia il solco ma è la spada che lo difende”, utilizzando uno dei motti celebri del ventennio….E invece è pura attualità.
A pensarla cosi è infatti oggi la Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, che per finanziare i nuovi obiettivi di spesa militare ha presentato una ipotesi di bilancio con pesanti tagli all’agricoltura, uno dei pochi se non l’unico settore economico realmente integrato dell’Unione. Un vero voltafaccia quello della presidente della Commissione che, dopo le pesanti proteste dei trattori di inizio 2023, aveva avviato una stagione di dialogo con i rappresentanti del settore per ridurre la burocrazia e superare le contrapposizioni tra agricoltura e ambiente volute da Timmermans, ex vicepresidente plenipotenziario della Commissione.
Cosa stabilisce la pac
La Politica Agricola Comune (Pac) istituita con il Trattato di Roma del 1957 è uno dei pilastri dell’Unione nato con lo scopo di creare un mercato unico per i prodotti agricoli, migliorare la produttività, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare un equo tenore di vita per gli agricoltori, tutelare l’ambiente e garantire giusti prezzi ai cittadini. Un riconoscimento della centralità del settore che ha consentito all’Unione Europea di conquistare una posizione di leadership mondiale nell’agroalimentare. Obiettivi oggi più che mai attuali nella situazione di incertezza che pesa sul contesto geopolitico, economico e commerciale.
L’emergenza Covid sembrava aver dimostrato con chiarezza quanto fosse stato strategico aver sostenuto gli agricoltori europei che anche nei giorni più drammatici della pandemia erano stati in grado di fornire cibo sufficiente. Ma ora tutto sembra dimenticato. E come una doccia fredda è arrivata la proposta di bilancio, presentata dalla von der Leyen in piena estate, che va in tutt’altra direzione. Prevede infatti una pesante sforbiciata delle risorse destinate all’agricoltura nel periodo 2028-2034.
Come cambia, la proposta
Il commissario Ue all’Agricoltura, Christophe Hansen, ha spiegato che il bilancio vincolato al sostegno del reddito degli agricoltori è di poco inferiore ai 300 miliardi e rappresenta l’80% del bilancio destinato attualmente. Una lettura addirittura ottimistica secondo il direttore del Centro Studi Divulga, Felice Adinolfi, che sottolinea come l’importo stanziato sia inferiore del 24% a prezzi correnti, senza cioè tenere conto dell’inflazione, ma ovviamente in termini reali la riduzione è di gran lunga maggiore. Il budget da garantire nel periodo 2028-2034 per i pagamenti destinati a sostenere il reddito degli agricoltori è infatti pari a 295,7 miliardi di euro mentre quello stanziato nell’attuale programmazione 2021–2027 alla Pac, per un periodo analogo, è pari a 387,8 miliardi.
Un taglio netto che la proposta della Commissione cerca di nascondere dietro la riforma degli strumenti finanziari dedicati alla Pac, che nell’attuale programmazione è sostenuta dal Feaga (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) per gli aiuti diretti alle aziende (cosiddetto primo pilastro) e dal Feasr (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) per gli interventi strutturali (secondo pilastro). Quest’ultimo verrebbe “annacquato” all’interno di un Fondo Unico per la coesione, dove le risorse per le zone rurali sarebbero in una concorrenza “perdente” con gli interventi per la coesione economica, sociale e territoriale destinati anche agli enti pubblici locali. Verrebbero spostati invece a carico del primo pilastro gli interventi a sostegno degli investimenti aziendali, il ricambio generazionale, le misure agro-ambientali e gli interventi compensativi per zone soggette a vincoli naturali, che saranno considerati pagamenti di sostegno al reddito nella nuova Pac.
Le possibili conseguenze
Un gioco delle tre carte dove i conti complessivi non tornano come hanno fatto notare tutte le organizzazioni agricole europee che hanno duramente manifestato a Bruxelles, anche con cartelli e striscioni raffiguranti la von der Leyen e con scritte come “Benvenuti a Vonderland” fatti sfilare dai giovani della Coldiretti. Da difendere c’è un patrimonio di 9 milioni di aziende agricole europee dove sono impegnati 13 milioni e 148mila lavoratori, secondo l’Eurostat. Una realtà che, partendo dalle difficoltà del dopoguerra, ha reso oggi l’Unione Europea autosufficiente in molti settori agricoli di base, tra cui la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, frumento, orzo, carne di pollame, vino e alcune tipologie di frutta. Secondo l’analisi della Coldiretti, che ha guidato la protesta a Bruxelles, saranno oltre 770mila le aziende agricole nazionali colpite dal taglio della Pac 2028-2034 ma si avranno effetti potenzialmente disastrosi anche sulla produzione di cibo, la sicurezza alimentare e la spinta verso l’innovazione e la sostenibilità. Un vero autogol per l’Unione Europea. «Purtroppo, la proposta della Commissione non è all’altezza degli obiettivi», ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ritenendo le scelte fatte «un’involuzione rispetto a una pianificazione di carattere strategico che l’Europa, fin dai trattati fondativi, aveva per lo sviluppo dell’agricoltura». Come Italia – ha ricordato il ministro – è stato avviato un lavoro molto importante nei mesi scorsi con un documento specifico sottoscritto da altre 17 nazioni e non ha senso che la Commissione vada in un verso diverso rispetto a quello indicato dagli Stati nazionali che rappresentano la volontà popolare. Meno agricoltura in Europa e in Italia significa, secondo la Coldiretti, aumentare le importazioni dall’estero, ed esporre i prezzi del cibo alle fluttuazioni dei mercati, con un impatto devastante sulle tasche dei cittadini.
Le prossime fasi
La partita sembra ancora all’inizio e ci sono due anni per trattare prima di approvare definitivamente il nuovo bilancio. L’attuale programmazione si concluderà infatti nel 2027 mentre sulla nuova la Commissione dovrà trovare un accordo con i capi di Stato e di governo e con lo stesso Parlamento Europeo dove si annuncia una aspra battaglia bipartisan. Nello smussare gli angoli un ruolo centrale lo avrà il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione Europea, Raffaele Fitto, che già in passato aveva dimostrato grande attenzione all’agroalimentare Made in Italy.
«La nostra mobilitazione continuerà per fermare questa deriva – ha sottolineato il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo – perché non possiamo accettare che risorse vengano sottratte all’agricoltura e alla qualità del cibo per destinarle al riarmo, mettendo a rischio anche la salute dei cittadini». Mentre Cina e Stati Uniti investono singolarmente 1.400 miliardi in agricoltura, l’Europa taglia la Pac. «Un colpo mortale – ha concluso il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – per un settore che in Italia vale 707 miliardi e dà lavoro a 4 milioni di persone».
Ad essere preoccupato è infatti l’intero sistema agroalimentare Made in Italy e di «un profondo stravolgimento della Politica Agricola Comune, che ne compromette l’identità storica, la funzione economica e il carattere fondante dell’Unione Europea», ha aggiunto Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia. In un momento in cui Trump – ha ricordato Scordamaglia – corteggia le nostre aziende invogliandole con i dazi alla delocalizzazione, la von der Leyen gliele consegna in braccio, dando loro una scusa per delocalizzare. L’accordo Ue-Usa raggiunto sui dazi ha confermato l’applicazione di tariffe al 15%, con alcune eccezioni. Un compromesso destinato ad avere un impatto pesante su alcuni comparti dell’agroalimentare Made in Italy, che hanno negli Stati Uniti un determinante mercato di sbocco, a partire da vino, olio di oliva e pecorino romano che realizza oltre la metà del fatturato estero proprio Oltreoceano. Non mancano però aspetti positivi, secondo Paolo De Castro, presidente di Nomisma, tra cui la riduzione delle tariffe sui formaggi duri, come il Grana Padano e Parmigiano Reggiano, così come nel caso della pasta. «Entrambi, infatti, – ricorda De Castro – avevano raggiunto il 25% di dazio dopo il primo aprile, ma ora tornano alla soglia del 15%. Anche se non mancano problemi interpretativi alle dogane che hanno richiesto l’ intervento del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione».
Leggi anche:
–Ambienta entra nell’agricoltura sostenibile, acquisita la spagnola Agronova
–Agricoltura inclusiva: l’Italia semina un nuovo modello a favore dell’Africa
© Riproduzione riservata