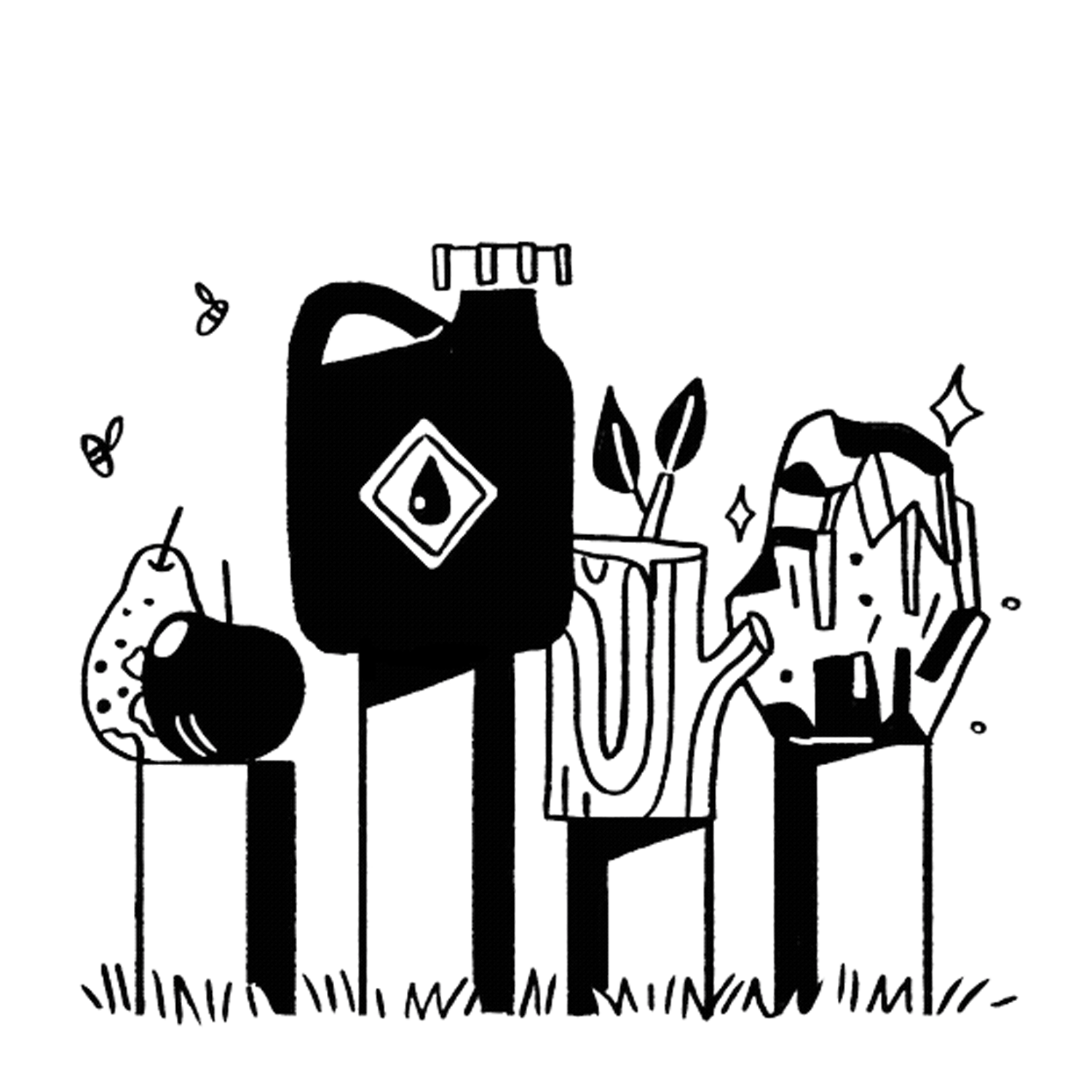Il 3 ottobre il ceo di Goldman Sachs, David Solomon, ha lanciato l’avvertimento all’Italian Tech Week prevedendo una correzione del mercato entro 12-24 mesi. «Ci sarà molto capitale investito che si rivelerà incapace di generare ritorni, e quando ciò accadrà, le persone non saranno contente», ha detto Solomon. Che poi ha tracciato diretti paralleli con la bolla dotcom: sebbene le nuove tecnologie generino innovazione, «di solito il mercato corre molto avanti rispetto al potenziale». Cinque giorni dopo, l’8 ottobre, a far suonare le sirene sono stati il Fondo Monetario e la Bank of England: i mercati azionari globali potrebbero finire nei guai, è la sintesi del loro messaggio, se l’appetito degli investitori per l’intelligenza artificiale dovesse venire meno. La direttrice dell’Fmi, Kristalina Georgieva, ha a sua volta offerto un consiglio franco agli investitori: «Allacciate le cinture: l’incertezza è la nuova normalità ed è qui per restare». Tra gli indicatori più significativi della preoccupazione c’è la valutazione senza precedenti dell’oro, che ormai viaggia attorno a 4.200 dollari l’oncia. Gerogieva ha descritto l’exploit come la prova di un crescente malessere nei mercati internazionali, unito all’esuberanza guidata dall’intelligenza artificiale che potrebbe trasformarsi in instabilità.
Nello stesso giorno, la Banca centrale inglese ha avvertito che il rischio di una «correzione brusca del mercato» è aumentato perché le valutazioni sembrano molto elevate, in particolare quelle delle società tecnologiche focalizzate sull’intelligenza artificiale. La BoE ha puntualizzato che «i fattori negativi includono progressi deludenti nella capacità/adozione dell’IA e probabilmente un aumento della concorrenza, che potrebbe portare a una rivisitazione dei guadagni attesi, attualmente molto elevati». Al coro si sono poi aggiunti Sam Altman di OpenAI, e il capo di JPMorgan, Jamie Dimon, secondo cui l’intelligenza artificiale ha fatto confluire «un sacco di soldi» sui titoli legati all’IA, «ma parte del denaro investito probabilmente andrà perduto». Dimon non nasconde la possibilità di scoppio di una bolla sul modello di quella delle dot-com nel 2000. «Sia chiaro, l’intelligenza artificiale è reale e nel complesso darà i suoi frutti. Proprio come le automobili e le tv hanno dato i loro frutti. Ma la maggior parte delle persone coinvolte in quei business non ha avuto successo», ha raccontato in un’intervista alla Bbc.
Scommessa sul futuro
Una bolla dell’intelligenza artificiale significa che le valutazioni superano di gran lunga i ricavi e i modelli di business comprovati. In sostanza, le aziende che sviluppano l’intelligenza artificiale e le tecnologie correlate ricevono investimenti in base alle promesse future piuttosto che alle prestazioni attuali. Nonostante l’ottimismo generalizzato, molti casi di uso dell’IA sono ancora speculativi, con un potenziale di fatturato ampiamente proiettato nel futuro. Bisogna aggiungere che i timori si sono intensificati nelle ultime settimane, dopo che big come Nvidia e OpenAI hanno annunciato accordi di finanziamento facendo sorgere il dubbio sulla loro capacità di continuare a sostenere il mercato. Grandi aziende tecnologiche come Meta, Microsoft e Amazon hanno speso centinaia di miliardi di dollari in data center e infrastrutture per sviluppare e potenziare l’intelligenza artificiale, e hanno stanziato centinaia di miliardi di dollari per ulteriori investimenti. Il problema è anche che il mercato appare alquanto concentrato su poche aziende: sette titoli (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla) rappresentano il 55% dei guadagni dell’S&P 500. Anche secondo Goldman Sachs questi fattori testimonierebbero l’esistenza di una bolla, sebbene la banca d’affari non veda un rischio immediato.
Ma qual è stato il là che ha scatenato in pochi giorni l’allarme congiunto – probabilmente prima solo latente – di banchieri, Fmi e Banca d’Inghilterra? Ad alimentare le preoccupazioni ha contribuito un report inviato ai propri clienti dalla società di ricerca indipendente Macrostrategy Partnership e firmato da Julien Garran (che in precedenza era a capo del team di strategia sulle materie prime di Ubs). Ebbene, secondo Garran l’intelligenza artificiale è una bolla 17 volte più grande di quella delle dot-com e quattro volte quella dei subprime, responsabile del crollo globale del 2008.
La tesi è che i tassi di interesse artificialmente bassi abbiano portato a una cattiva allocazione, ad un uso improprio di denaro e lavoro, e a una situazione destabilizzante perché i risultati, i prodotti o persino le promesse, se vogliamo, non si materializzano. Nel report si fa riferimento all’economista svedese del XIX secolo Knut Wicksell e al cosiddetto differenziale wickselliano per calcolare un deficit del Pil che include complessivamente intelligenza artificiale, immobili, investimenti in capitale di rischio e anche gli NFT. Secondo questa metrica, l’errata allocazione nel 2008, prima della crisi, era pari a circa il 18% del Pil e Garran stima che questa cifra potrebbe ora raggiungere un impressionante 65%.
Rischio inversione a U
Vengono poi evidenziati alcuni esempi concreti di come sta andando il boom della produttività dell’intelligenza artificiale. L’esperto cita uno studio in cui il tasso di completamento delle attività per l’IA in un’azienda di software era compreso tra l’1,5 e il 34% e, anche con i compiti in cui l’IA si era rivelata più brava, non riusciva a replicare in modo affidabile quel successo nel tempo. «Non sappiamo esattamente quando gli LLM (ovvero i modelli di linguistici di apprendimento profondo, ndr) potrebbero raggiungere rendimenti decrescenti, perché non disponiamo di una misura della complessità statistica del linguaggio», afferma Garran. «Per scoprire se abbiamo raggiunto un punto morto, dobbiamo osservare gli sviluppatori degli LLM. Se pubblicano un modello che costa 10 volte di più, che probabilmente utilizza 20 volte più potenza di calcolo rispetto al precedente, e non è granchè migliore di quello disponibile sul mercato, allora abbiamo raggiunto un punto morto».
Garran sottolinea inoltre che il pubblico che utilizza maggiormente gli LLM costa a queste aziende più potenza di calcolo «dei loro abbonamenti mensili». E gli stessi LLM costano una quantità esponenzialmente maggiore per addestrare ogni generazione, con un guadagno di precisione in rapida diminuzione. La conclusione di Garran è molto cruda: quando la bolla dell’intelligenza artificiale LLM scoppierà, il rischio non è solo che la crescita dei data center e l’effetto ricchezza di big come Nvidia si stabilizzino, ma che si invertano, proprio come il boom delle infrastrutture dot-com e l’effetto ricchezza si invertirono nel 2001. Se ciò dovesse accadere, si rischia di ridurre di altri 3 punti percentuali la crescita del Pil, spingendo gli Stati Uniti in una recessione sostanziale. Inoltre, la tendenza generale all’aumento dei tassi, unita alle conseguenze del balzo degli investimenti immobiliari residenziali del 2020-2022, renderebbe il settore edile insensibile ai tassi più bassi, almeno per un certo periodo di tempo.
Selezione naturale
Di certo, la vera sfida dei prossimi trimestri sarà distinguere chi riuscirà a trasformare la promessa in risultati e cassa, dentro schemi di finanziamento che si stanno facendo via via più complessi. È anche per questo che tra gli investitori si fa strada l’idea di spostarsi verso sotto-temi più “a valle” della catena. Come sottolinea Alberto Tocchio, capo del Global Equity di Kairos, «se la potenza di calcolo tende a diventare una commodity, il vantaggio competitivo si sposta verso il software: integrare agenti AI dentro applicazioni e processi, ridisegnare l’esperienza utente, governare i flussi di lavoro. In altre parole: quando il silicio non fa più la differenza, la differenza la fa chi presidia l’interfaccia, decide le priorità, cattura i dati e, di conseguenza, i margini».
© Riproduzione riservata